MARIO SIRONI: “BALLERINA”
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti
 M
ario Sironi (Sassari, 1885 - Milano, 1961), nasce da una famiglia di artisti.
M
ario Sironi (Sassari, 1885 - Milano, 1961), nasce da una famiglia di artisti.
Inizia a Roma gli studi di ingegneria, poi abbandonati per la pittura. Incontra Boccioni e frequenta lo studio di Balla.
Fin dal 1914 fa parte del movimento Futurista, intanto viaggia, in
Francia e in Germania. Assieme ad altri Futuristi inneggia
all’interventismo.
La pittura futurista di Sironi trae ispirazione da quella dell’amico
fraterno Boccioni, ma mentre in Boccioni tutto è dinamico, esplosivo,
la pittura del Nostro gode di un impianto compositivo solido e ben
costruito.
Dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale, nel marzo del 1919
Sironi rientra a Roma congedato. Ora suggestioni metafisiche pervadono
la sua pittura.
Nel dicembre del 1922 è tra i fondatori del Novecento Italiano animato
da Margherita Sarfatti. Il movimento aspira a una moderna classicità.
Sironi si dedica con gran fervore alla pittura d’affresco. L’ultimo
periodo della sua attività vede un’attenzione ad oggetti isolati dal
loro contesto, raggruppati su una sola tela, come pezzi di bassorilievo
accostati per caso.
|
|
|
EDITORIALE
 Fabio Tolomelli
Fabio Tolomelli
Autonomia è un termine dal significato
molto ampio. Viene usato dalla psicologia alla giurisprudenza, dalla
fisica alla filosofia, dalla politica al linguaggio comune…
Essere autonomi significa, sotto il profilo politico, avere la libertà
di manifestare la propria personalità senza urtare l’indipendenza di
altre persone. È un diritto che in Italia ha trovato piena attuazione
solo dopo la seconda guerra mondiale, con la promulgazione della
Costituzione, al costo di milioni di vittime innocenti. Mai come allora
fu importante e sentito il bisogno di libertà d’espressione e
partecipazione politica alla vita del paese, dopo il periodo fascista
che aveva limitato la libertà d’opinione, di stampa, di religione e di
riunione in partiti politici.
L’aspetto giuridico vede nell’autonomia la possibilità di governarsi
con proprie leggi; capacità di pensare e interagire liberamente senza
influenze estranee. È un principio che prende origine dall’Illuminismo,
che vedeva nella ragione umana la capacità di esprimersi senza
imposizione dall’alto (teocrazia, aristocrazia, oligarchia, tirannia).
In fisica per autonomia si intende la possibilità di fare un determinato lavoro senza fare un rifornimento di energia.
In psicologia l’autonomia è uno stadio dello sviluppo della personalità
che comincia a maturare nel bambino intorno al secondo anno di vita,
attraverso la capacità di dire no e il controllo degli sfinteri. Questo
stadio si struttura sulla base del senso di fiducia in sé stesso, che
nasce spontaneamente quando c’è un buon rapporto di attaccamento con la
madre. Se la donna, o chi si prende cura del bambino, risponde alle
richieste del piccolo in modo pronto e appropriato, lo renderà più
sereno e fiducioso. Se viceversa lo fa in modo freddo, distaccato e
inappropriato genererà insicurezza e paura nei confronti dell’ambiente
fisico e sociale. L’autonomia trova dunque le radici nella fiducia in
sé stessi: se non si matura questa capacità, difficilmente si avrà una
buona autonomia. Una volta maturata l’autonomia si entrerà nella fase
dello spirito di iniziativa, che si materializza nel coraggio di
affrontare la vita con le sue asperità. Personalmente, l’autonomia l’ho
raggiunta molto tardi, pur essendo uscito di casa ancor giovane. Un
forte conflitto interiore mi dilaniava: da una parte il bisogno
dell’affetto dei genitori dall’altra il bisogno di libertà. Fra le
esperienze che mi hanno condizionato, una delle più traumatiche è stato
un dialogo con mio padre, quando lo volli ringraziare per avermi dato
la possibilità di vivere in un appartamento dove vivevo solo e dove
avrei avuto la possibilità di manifestare la mia personalità,
dimostrandogli che non si era sbagliato a darmi fiducia. A sentir
questo, lui si arrabbiò tantissimo, asserendo che in casa ero sempre
stato lasciato libero e indipendente nelle mie scelte e con i miei
spazi. In realtà, anche fisicamente non è che avessi avuto molto
spazio, si viveva in cinque in un appartamento con una sola camera. Io,
mia sorella e mia nonna dormivamo in sala… Sotto il profilo affettivo
mia mamma è stata molto presente, mio padre più distaccato (molto
arrabbiato per sciocchezze, molto meno per le cose gravi), ma voleva
che fossi come un suo arto: pretendeva che facessi le cose che voleva e
nel modo imposto da lui. Non c’era molto spazio per l’autonomia. Quanto
mi sia mancata la fiducia del genitore mi è difficile dirlo, però forse
è un po' mancata quella maturazione dello spirito d’intraprendenza che
ti dà il ricevere fiducia. È vero che l’esperienza e il tempo mi hanno
fatto maturare, ma l’insicurezza, la paura di sbagliare mi hanno spesso
frenato, stoppato e fatto regredire nel bisogno di fare esperienze.
Forse un postumo tangibile c’è stato: il coraggio di affrontare
discorsi davanti a molte persone l’ho molto sentito e sofferto, e l’ho
superato solo dopo la morte di mio papà.
Tornando all’aspetto esperienziale, le esperienze continuamente
negative hanno frustrato e fatto precipitare la mia autostima e la
capacità di avere una visione corretta della realtà. Con questo non
voglio dire che è tutta colpa di mio padre, anzi, lui è stato un
esempio di correttezza e personalità. È sempre stato e sarà l’uomo più
forte che abbia conosciuto e a modo suo mi è stato sempre vicino. E
certamente l’affetto e il sostegno sono importanti. Ma l’autonomia per
la vita di una persona è davvero fondamentale.
Per questo, leggete Il Faro: giornale autonomo che rende autonomi.
|
|
|
LA MIA STORIA
Reggio Emilia 26.09.2016 Convegno Peers
 Angelo Bottini
Angelo Bottini
 M
i è stato chiesto di portare qui brevemente la mia storia, storia che è
semplicemente una delle tante, che però credo sia profondamente legata
a quanto detto qui, a quanto si dirà in questi due giorni.
M
i è stato chiesto di portare qui brevemente la mia storia, storia che è
semplicemente una delle tante, che però credo sia profondamente legata
a quanto detto qui, a quanto si dirà in questi due giorni.
Mia madre non mi ha mai sentito muovere nella sua pancia, era un segno.
Artrogriposi multipla congenita hanno detto i medici. Una condizione
clinica caratterizzata da rigidità, deformità delle articolazioni,
debolezza muscolare. Ero dunque un bimbetto irrigidito che avrebbe
cambiato la vita dei miei genitori, per sempre. Da quel giorno in poi
loro hanno fatto tutto quello che potevano e sapevano per cercare di
darmi la vita migliore che loro riuscivano a immaginare.
I primi due mesi di pellegrinaggi nei più importanti ospedali del nord
Italia sono terminati quando un probabilmente presuntuoso primario di
Milano ha detto loro che, sì, mi avrebbe fatto camminare ma che
certamente no, non sarei mai riuscito a scrivere.
I primi due anni di gessi e trazioni, poi negli anni una ventina di interventi.
Quasi subito ci siamo trasferiti in Liguria, perché il mare dicevano mi facesse bene.
I miei genitori hanno per questo rinunciato ai loro progetti di lavoro
e si sono adattati a una vita difficile senza però mai dubbi e
rimpianti, con una forza e una determinazione che ancora oggi fatico a
immaginare.
Fino a sei anni mi portano solo in carrozzina, in casa mi muovevo sul
sedere, in modo abbastanza efficiente però. Ma quell’estate,
nell’incoscienza di quei sei anni, decido che è ora di provare, di
provare a camminare. Ci provo, esco dalla camera pieno di paura e
voglia di mettermi alla prova, voglio anche sapere cosa mi diranno.
Attraverso la sala e lascio senza parole la mia famiglia che era in
cucina.
Il mio zampettare non era certo così efficiente, non sapevo difendermi
dalle numerose cadute che mi lasciavano senza fiato e a volte senza un
dentino, a volte con una frattura.
Camminavo poco e solo in casa, la carrozzina l’avrei messa in cantina solo a diciotto anni.
In qualche maniera io non mi sentivo diverso, non mi sentivo un
disabile, perché con il loro aiuto potevo fare ogni cosa. Da solo non
potevo vestirmi, non potevo andare in bagno, non potevo fare le scale,
prendermi da mangiare, con loro si, erano le mie braccia e le mie
gambe.
Avevo una sorta di corpo esteso, efficace, comodo, oggi so che non era
probabilmente la via migliore. Ma in quegli anni i genitori erano
lasciati soli a cercare la soluzione migliore, e loro hanno fatto più
di quello che potevano e forse più di quello che dovevano.
A diciotto anni mi dicono che col bisturi hanno finito, non si sa che
altro fare per me. Non c’è più nulla da correggere ma io so di non
essere aggiustato per niente, sono comunque felice di non dovere
soffrire più, era già qualche anno che ero rassegnato all’idea di avere
bisogno di aiuto per tutto. Gli ultimi interventi erano stati per
questo motivo emotivamente devastanti.
Finite le superiori ho aperto un negozio, sotto casa che era più
facile. Basta carrozzina, anche se non camminavo tanto, comunque mai da
solo. I miei genitori avevano il terrore che cadessi, e io con loro.
Passa qualche anno, la catena di cui ero complice mi sta stretta,
decido che forse il cadere e il rompermi una gamba in realtà possono
essere un rischio più che accettabile. E così rischiando e faticando,
cammino sempre di più, miglioro resistenza ed equilibrio. Le cadute
diventano rare e meno disastrose.
È stata una conquista difficile, un trauma emotivo per tutti, un durissimo allenamento alla paura, e alla libertà.
Passano anni, vista da fuori la mia vita sembra quasi normale, ma non lo è.
I miei genitori mi aiutano a lavarmi, vestirmi, spostarmi, mi portano
al lavoro tutti i giorni quando mi assumono in una ditta a venti
chilometri da casa. Le vacanze sono solo con loro, con gli amici non
posso allontanarmi mai per una giornata intera, la mia catena è più
lunga, ma non abbastanza.
Non sono felice ma non riesco a immaginare altra via, altra vita. E mi basta.
Si impara a non desiderare.
Divento docente grazie alla passione per l’informatica. Giro istituti
professionali ed aziende vincendo una timidezza che nei primi due anni
mi lasciava senza energia ad ogni lezione. Se ci penso oggi, so di aver
accettato la prima docenza proprio perché mi sembrava impossibile.
A trent’anni decido di affrontare la commissione per la patente di guida.
Anche questa cosa mi sembrava impossibile. Quindi ci provo. La
commissione si rifiuta di visitarmi e mi caccia via malamente
chiedendomi chi diavolo mi avesse detto di fargli perdere del tempo,
che erano lì per lavorare, loro.
L’anno dopo ci riprovo. Questa volta però sono più chiari e definitivi.
Non esiste nessun mezzo al mondo che io sarò mai in grado di guidare,
inutile protestare o fare la vittima, mi dicono.
I miei genitori tirano un respiro di sollievo, erano angosciati da questo mio incomprensibile desiderio.
Mi hanno convinto, ci metto una pietra sopra.
Si impara a non desiderare.
I mezzi pubblici sono inaccessibili e il problema dell’autonomia negli spostamenti non ha più quindi una soluzione.
Passano diversi anni, provo a chiedere ai medici cosa io possa fare per migliorare la mia autonomia. Nessuna risposta.
Nel 2008, dopo un ricovero imprevisto, capisco che sono su un binario
morto, la mia totale dipendenza dai miei genitori non è sostenibile
illimitatamente. Che il futuro fosse nero lo sapevo da tempo, che ci
fossero alternative non ero nemmeno capace di pensarlo.
Nuovi amici mi danno nuova energia. Uno di loro, in carrozzina, mi
convince a riprovare la commissione per la patente. Questa volta non
fingono nemmeno di visitarmi e mi danno l’autorizzazione. Dopo tredici
anni dalla prima visita passo al volo teoria e pratica, e quel dicembre
guido la mia prima macchina.
Una enorme rabbia per come alcune persone, senza nessuna ragione,
possano ridurti le scelte di vita disponibili, mi ha tormentato per
mesi.
Cosa posso fare ancora? Voglio capire. Magari dopo vent’anni le
tecniche chirurgiche saranno cambiate, pensavo. Mi indicano Budrio che
poi mi indirizza al policlinico di Modena, là conoscono bene
l’artrogriposi. Voglio andarci, assolutamente, ma da solo. È
impossibile, e quindi vado.
Non so vestirmi e in parte non so andare in bagno, Modena è a quattro
ore di viaggio, in albergo non mi vede nessuno se dormo vestito e con
le scarpe, se mangio poco i giorni precedenti, magari non serve andare
in bagno. Si può fare.
Per due mesi, nei weekend giro per le tortuose strade dell’entroterra
ligure per allenarmi mentalmente e fisicamente alla distanza da casa,
metto alla prova la lunghezza della mia invisibile catena.
È stata la visita più lunga e approfondita alla quale sia mia stato
sottoposto. Oltre tre ore di test, valutazioni, interviste. Rimango
sorpreso, spiazzato, affascinato.
Non sono più una patologia rara, sono una persona che affronta ostacoli
quotidiani dovuti a una patologia rara.
Scopro così la terapia occupazionale.
Capisco subito che il punto di vista si allarga, non sono io il malato,
quello da aggiustare, è il modo in cui faccio le cose che è da
aggiustare. Il segno non è una minore estensione del gomito, il segno è
il non riuscire a mettersi le scarpe da soli.
È la più grande rivoluzione che riesco ad immaginare, è la restituzione del ruolo del corpo a mezzo e non fine.
Vuoi provare a metterti le calze? Con la mia artrodesi? Faticano i miei
genitori a mettermele, è impossibile. È stato magico mettermi le calze
per la prima volta, come è stato guidare.
Nei sei mesi successivi, a quarantaquattro anni, la terapia
occupazionale ha eliminato tutti gli ostacoli principali per la mia
completa autonomia.
Il futuro da prevedibilmente nero, si trasforma in un grande e meraviglioso, ignoto, punto interrogativo.
Quell’autunno sono andato a visitare una fiera a Düsseldorf, in
Germania. Una sera mi ritrovo a passeggiare nei vicoli storici della
cittadina tedesca. Sono a oltre mille chilometri da casa, sono da solo
per la prima volta, una sensazione di libertà e serenità che non riesco
a descrivere, una sensazione di ufficiale presa in carico della mia
vita.
Al ritorno in Italia decido di osare un altro viaggio impossibile che
incanali l’energia compressa di anni, che trasformi utilmente la rabbia
per aver trovato così tardi soluzioni ai limiti della mia vita. Che mi
consentisse di dare il mio contributo per cambiare le cose anche per
altre persone. Che desse valore al mio difficile, ma anche comune,
percorso. Sono passati quasi cinque anni, lo scorso novembre mi sono
laureato in terapia occupazionale, qui a Reggio Emilia.
Ho vissuto e sto vivendo una vita inimmaginabile fino a cinque anni fa, l’impossibile, ancora una volta è diventato possibile.
Sono qui a cercare di percorrere una mia via per rendere utili, per me
e per gli utenti che incontro tutti i giorni nel mio lavoro, per le
loro famiglie, per i miei colleghi, non solo le competenze tecniche
acquisite con lo studio, ma tutta la mia storia, i venti interventi
subiti, la fatica, gli anni di ospedali e trattamenti, gli immensi
sacrifici della mia famiglia.
E ho scoperto presto che ci sono tante storie simili alla mia, e proprio nella recovery, tanti sono stati gli utenti che da peer supporter,
da facilitatori, hanno scelto di diventare terapisti occupazionali.
Perché dall’inizio della storia della recovery è stato chiaro che c’era
una affinità elettiva con i terapisti occupazionali. Come ci ricorda
Julie Repper, illustre ospite di domani mattina, il terapista
occupazionale capisce quale parte di una attività risulti difficile o
impossibile per chi vuole conquistare la massima autonomia. E così
quell’attività diventerà anch’essa mezzo e fine del processo della
recovery.
Dunque, avere la piena capacità di partecipare e contribuire con
dignità alla propria comunità non deve essere una opzione casuale o
fortunata, è un diritto fondamentale di cui bisogna rendere consapevoli
anche le persone che hanno imparato a non desiderare.
È un diritto che bisogna proteggere e garantire. Perché desidera chi può scegliere, desiderare significa vivere.
Grazie.
|
|
|
L’AUTONOMIA E IL SUO SIGNIFICATO
 Anonimo
Anonimo
I
l termine autonomia deriva dalle parole greche autòs e nómos
e indica la capacità di darsi da sé le regole che determinano le
proprie scelte e il proprio comportamento, più semplicemente significa
‘fare da soli’, non dipendere dagli altri. Essere autonomi non
significa solo essere in grado di vestirsi, mangiare da soli, muoversi
da soli, avere cura di sé per mezzo dell’igiene personale, ma significa
soprattutto essere in grado di scegliere, decidere della propria vita,
organizzarsi, rifiutare, assumersi responsabilità e doveri, entrare in
relazione con gli altri e desiderare di avere interessi per sé, perché
è nel diritto di ogni persona poter godere al massimo delle autonomie
raggiunte sfruttando tutte le potenzialità e le capacità che ognuno
possiede.
I termini autonomia ed autosufficienza molto spesso vengono confusi o
usati come sinonimi, ma in realtà le due parole hanno significati
diversi. Persona autonoma è chi sa prendere decisioni senza l’influenza
di un’altra persona. Persona autosufficiente è chi dispone delle
energie e dei mezzi necessari per badare a sé stessa e soddisfare le
proprie esigenze.
Anche per chi nella società ricopre il ruolo di paziente psichiatrico
il concetto di autonomia ha a che fare con la libertà, la potenzialità
di decisione e la dignità. Persone con disturbi mentali possono
attraversare condizioni transitorie in cui la libertà e la capacità
decisionale sono messe in discussione, ma con un giusto percorso
riabilitativo si possono ottenere risultati soddisfacenti.
Il percorso che ogni persona è chiamata a compiere deve avere come
obbiettivo primario il raggiungimento della capacità di scelta,
affinché possa vivere una vita con dignità e senza essere di peso agli
altri. È ragionevole ritenere la famiglia come una delle fonti
principali dell’autonomia della persona disabile e considerare il modo
in cui i familiari affrontano i problemi legati alla disabilità, in
quanto tutto questo influisce sull’individuo e sulla sua capacità di
ottenere la propria autonomia, per questo motivo può dimostrarsi utile
un’influenza familiare positiva. Come paziente psichiatrica devo
ammettere che la malattia mi aveva privata della mia autonomia. Ciò che
si è dimostrato essere un ottimo rimedio alla mia temporanea disabilità
è stata la mia frequenza al Centro Diurno Psichiatrico. Dal percorso
riabilitativo seguito con coraggio e determinazione ho ricevuto molti
benefici. Utili ed importanti sono stati la ricerca del benessere
fisico e psichico e il perseguire obbiettivi gratificanti, elementi
fondamentali per ottenere la propria autonomia. Il percorso intrapreso
mi ha aiutato ad apprezzare la mia libertà e la relazione con gli
altri, inoltre mi ha permesso di ottenere la capacità di compiere
scelte che consideravo impossibili come smettere di fumare e troncare
una relazione sentimentale non proprio ideale, scelte che hanno
migliorato la qualità della mia vita e che mi consentono di godere
delle opportunità che la vita mi offre. Entusiasta dei risultati
ottenuti mi prefiggo di continuare a mantenere la mia autonomia per la
soddisfazione mia e dei miei familiari.
|
|
|
L’AUTONOMA CORNACCHIA
 Luigi Zen pass
Luigi Zen pass
 Chissà come, la cornacchia sa
riconoscere la presenza di cibo in questo cilindro ben chiuso, che ha
già ripetutamente beccato ed ha già parzialmente aperto.
Chissà come, la cornacchia sa
riconoscere la presenza di cibo in questo cilindro ben chiuso, che ha
già ripetutamente beccato ed ha già parzialmente aperto.
|
|
|
DILEMMA
 Paolo Sanzani
Paolo Sanzani
I
Dilemma che dilania la mente di molti addetti ai lavori della psichiatria e non !!!!!!!
Sostegno all’autonomia (in termini di euro) ma vincolati a certe dinamiche?
Emancipazione,
percorso più ostico ma forse più completo, che permette all'individuo
di recidere quel cordone ombelicale che si crea con un lungo tempo di
attesa (cosa aspetti?).
|
|
|
LA LIBERTÀ DI AUTONOMIA
 Stefy
Stefy
 Èdifficile spiegare a parole cos’è
l’autonomia, anche perché è un concetto che durante la nostra vita si
va ad unire a tanti altri aspetti del nostro essere. Consapevolezza di
sé, libertà di pensiero, senso di appartenenza, solidarietà… Nasciamo
che non siamo autonomi, ma poi man a mano che apprendiamo le regole che
ci impone la società in cui viviamo impariamo a gestirla e attraverso
una ricerca del nostro essere raggiungiamo l’autonomia di pensiero.
Impariamo a gestire le nostre idee ed emozioni, facendole convivere con
quelle degli altri. A volte avere un pensiero libero proprio è quasi
una forma di isolamento che va a cozzare con il nostro bisogno di
sentirci parte di un gruppo, una famiglia… Comprendiamo così che la
libertà di pensiero è anche lasciare liberi i pensieri altrui, ricerca
che va fatta dentro sé stessi, staccandosi dai giudizi. Dobbiamo
imparare a stare dentro un gruppo, adeguandoci agli altri o facendo in
modo che gli altri si adeguino a noi, senza perdere la nostra identità.
Dentro a ogni gruppo ci sarà sempre una gerarchia che va dal gradino
più basso, cioè chi si crede autonomo ma non lo è, al gradino più alto,
il leader che ha una forte personalità, ha raggiunto una sua autonomia
di pensiero ed è in grado di trascinare tutto il gruppo. Manterrà quel
ruolo fino a che non incontrerà una personalità più forte e autonoma.
Libertà e autonomia convivono ma non sono la stessa cosa, perché la
libertà nasce dal proprio modo di pensare e vedere le cose, mentre
l’autonomia è come si vive la propria vita rapportandosi con gli altri.
L’autonomia, come la libertà, non è facile da conquistare e ti rende
responsabile di quello che fai e di quello che sei. Ti rende
indipendente dagli altri, da quelli che vogliono decidere per la tua
vita senza prendersi la responsabilità, anzi te ne fanno una colpa.
L’autonomia va costruita pian piano, pezzo per pezzo e richiede anni di
riflessioni, su quello che siamo e pensiamo e su quanto siamo disposti
a sacrificarci per ottenerla. Sacrifici che quando non eravamo autonomi
non ci venivano richiesti. La miglior forma di dimostrazione di amore
che si può fare a chi vuoi bene è insegnargli le basi per essere
autonomo. Così facendo gli regali la possibilità di una sua libertà e
autonomia personale. Non gli metti le catene ai piedi e ai polsi. Gli
lasci la libertà di scegliere se vuol correre o volare o fermarsi o
atterrare. L’autonomia crea in noi una mentalità libera e, a sua volta,
una mentalità libera crea l’autonomia. Libertà e autonomia non riescono
a essere totali: per quanto noi possiamo fare, resta sempre un anello
di quella catena che ci lega, o comunque ci pone dei limiti, che noi
non riusciamo a vedere. Il solo modo che abbiamo per allargare questi
confini è riuscire a creare in noi stessi una mentalità aperta, ‘con
libertà di autonomia’, cioè con la capacità di essere liberi e avere un
nostro modo di pensare rispettando la libertà e il pensiero altrui
senza farci influenzare. Percepiremo così un pacifico senso di libertà
e individualità, un sentirci unici ma non soli!
Èdifficile spiegare a parole cos’è
l’autonomia, anche perché è un concetto che durante la nostra vita si
va ad unire a tanti altri aspetti del nostro essere. Consapevolezza di
sé, libertà di pensiero, senso di appartenenza, solidarietà… Nasciamo
che non siamo autonomi, ma poi man a mano che apprendiamo le regole che
ci impone la società in cui viviamo impariamo a gestirla e attraverso
una ricerca del nostro essere raggiungiamo l’autonomia di pensiero.
Impariamo a gestire le nostre idee ed emozioni, facendole convivere con
quelle degli altri. A volte avere un pensiero libero proprio è quasi
una forma di isolamento che va a cozzare con il nostro bisogno di
sentirci parte di un gruppo, una famiglia… Comprendiamo così che la
libertà di pensiero è anche lasciare liberi i pensieri altrui, ricerca
che va fatta dentro sé stessi, staccandosi dai giudizi. Dobbiamo
imparare a stare dentro un gruppo, adeguandoci agli altri o facendo in
modo che gli altri si adeguino a noi, senza perdere la nostra identità.
Dentro a ogni gruppo ci sarà sempre una gerarchia che va dal gradino
più basso, cioè chi si crede autonomo ma non lo è, al gradino più alto,
il leader che ha una forte personalità, ha raggiunto una sua autonomia
di pensiero ed è in grado di trascinare tutto il gruppo. Manterrà quel
ruolo fino a che non incontrerà una personalità più forte e autonoma.
Libertà e autonomia convivono ma non sono la stessa cosa, perché la
libertà nasce dal proprio modo di pensare e vedere le cose, mentre
l’autonomia è come si vive la propria vita rapportandosi con gli altri.
L’autonomia, come la libertà, non è facile da conquistare e ti rende
responsabile di quello che fai e di quello che sei. Ti rende
indipendente dagli altri, da quelli che vogliono decidere per la tua
vita senza prendersi la responsabilità, anzi te ne fanno una colpa.
L’autonomia va costruita pian piano, pezzo per pezzo e richiede anni di
riflessioni, su quello che siamo e pensiamo e su quanto siamo disposti
a sacrificarci per ottenerla. Sacrifici che quando non eravamo autonomi
non ci venivano richiesti. La miglior forma di dimostrazione di amore
che si può fare a chi vuoi bene è insegnargli le basi per essere
autonomo. Così facendo gli regali la possibilità di una sua libertà e
autonomia personale. Non gli metti le catene ai piedi e ai polsi. Gli
lasci la libertà di scegliere se vuol correre o volare o fermarsi o
atterrare. L’autonomia crea in noi una mentalità libera e, a sua volta,
una mentalità libera crea l’autonomia. Libertà e autonomia non riescono
a essere totali: per quanto noi possiamo fare, resta sempre un anello
di quella catena che ci lega, o comunque ci pone dei limiti, che noi
non riusciamo a vedere. Il solo modo che abbiamo per allargare questi
confini è riuscire a creare in noi stessi una mentalità aperta, ‘con
libertà di autonomia’, cioè con la capacità di essere liberi e avere un
nostro modo di pensare rispettando la libertà e il pensiero altrui
senza farci influenzare. Percepiremo così un pacifico senso di libertà
e individualità, un sentirci unici ma non soli!
|
|
|
NELLE MANI DELLA TECNOLOGIA
 Stefy
Stefy
Noi esseri umani, cosa siamo diventati
mettendoci nelle mani della tecnologia? Delle amebe solitarie, incapaci
di sopravvivere se non abbiamo il nostro PC o il nostro I-Phone. E
pensare che siamo arrivati fin qua grazie al nostro fattore umano (che
ora abbiamo perso) fatto di fantasia e creatività! Il tutto sospinto
dalle nostre emozioni, che ci han spinto con tenacia a cercare dei
miglioramenti nella nostra vita… Ma ci si è ritorto contro e siamo
arrivati a svalutare il nostro cervello, il nostro cuore e l'importanza
del contatto con chi ci circonda. A volte abbiamo paura addirittura di
raffrontarci con noi stessi, preferiamo fare qualche stupido test su
Facebook per darci una risposta. Se su un panorama umano così ci si può
fare della comicità, è perché non sappiamo più neanche piangere, non
sappiamo più come sono le emozioni! Fortuna per me che la mia Missy
viene ancora a chiedere il mangiare a me, e non va dal mio PC, forse
perché è troppo antiquato: non ha il programma per aprire le
scatolette… E così, volentieri, lo faccio io!
|
|
|
NÉ DI TESEO NÉ DI ARIANNA
 Antonio Marco Serra
Antonio Marco Serra
Rino, non riconosco gli aneddoti;
sfiondami, spostami tutte le efelidi;
aprimi, picchiami solo negli angoli;
brivido, no, non distinguo più i datteri.
Enzo Jannacci - Silvano
 uesto
è un articolo autonomo. È talmente autonomo che il testo dell’articolo
non ha niente a che vedere col titolo (che è quello di un altro mio
scritto) ed entrambi non hanno niente a che vedere con la citazione
iniziale. In realtà ho sempre desiderato scrivere un articolo che
avesse come citazione iniziale le sublimi parole di Enzo Jannacci su
riportate, ma, come è facile immaginare, non è semplice scrivere
qualcosa che possa attingere alle vette della loro insondabile
profondità, e così non intendo lasciarmi sfuggire questa occasione.
Veramente pensavo di scrivere un articolo in cui ogni paragrafo fosse
autonomo da ogni altro, ma poi non me la sono sentita di mettere a così
dura prova la pazienza dei miei lettori. Come vedete non sono autonomo
neppure dal giudizio che potete avere su di me voi, miei cari quattro o
cinque lettori. uesto
è un articolo autonomo. È talmente autonomo che il testo dell’articolo
non ha niente a che vedere col titolo (che è quello di un altro mio
scritto) ed entrambi non hanno niente a che vedere con la citazione
iniziale. In realtà ho sempre desiderato scrivere un articolo che
avesse come citazione iniziale le sublimi parole di Enzo Jannacci su
riportate, ma, come è facile immaginare, non è semplice scrivere
qualcosa che possa attingere alle vette della loro insondabile
profondità, e così non intendo lasciarmi sfuggire questa occasione.
Veramente pensavo di scrivere un articolo in cui ogni paragrafo fosse
autonomo da ogni altro, ma poi non me la sono sentita di mettere a così
dura prova la pazienza dei miei lettori. Come vedete non sono autonomo
neppure dal giudizio che potete avere su di me voi, miei cari quattro o
cinque lettori.
Per poter scrivere di autonomia, bisognerebbe dare per scontato che
essa abbia senso, e cioè che l’uomo sia dotato di libero arbitrio.
Schiere di teologi, filosofi e scienziati ci hanno dottamente spiegato
che ciò non è vero. Il povero Pelagio, che sosteneva che l’uomo potesse
autonomamente conquistare la propria salvezza eterna, senza l’aiuto
della Grazia divina, non ha fatto una brutta fine solo perché ha avuto
il buon senso di nascere in un periodo in cui mandare al rogo gli
eretici non era ancora diventato di moda.
Tra i tanti filosofi che hanno negato il libero arbitrio mi piace
citare il buon Baruch Spinoza: “Chi crede di parlare o di tacere, o di
fare qualsiasi cosa, per libero decreto della Mente, sogna ad occhi
aperti”. Ed è indubitabile che delle due teorie fisiche che oggi si
ritengono reggere le sorti dell’universo mondo, l’una, la relatività
generale, è strettamente deterministica, l’altra, il modello standard
della meccanica quantistica, insaporisce il tutto con un pizzico di
caso, ma né l’una né l’altra lasciano il minimo spazio a una decisione
autonoma dell’uomo (che potrebbe anche starci) e neanche dei miei nove
gatti (che è difficile da credere) sulle proprie azioni.
E dunque… E dunque, del tutto incuranti di ciò che la teologia, la
filosofia o la scienza possano dirci a riguardo, continuiamo ad essere
convinti che noi siamo gli artefici del nostro destino e che siamo
responsabili di ciò che compiamo, salvo magari avere qualche
ripensamento quando ciò che abbiamo compiuto viene giudicato dai nostri
simili non propriamente ‘carino’.
In fondo poco importa se possiamo essere autonomi dal punto di vista
teorico, ciò che conta è la percezione che noi abbiamo della nostra
autonomia, o della nostra mancanza di essa. E questo è vero in modo
particolare per coloro che, a causa dei propri disturbi psichici,
sentono gravemente limitata la propria autonomia, sia perché non sono
in grado di compiere, o compiono con grande difficoltà, azioni che per
la maggior parte delle altre persone risultano assolutamente normali,
sia perché in tanti casi sono altri che prendono le decisioni su cosa
sia meglio per loro. Il libero arbitrio potrebbe anche non esistere, ma
l’illusione di essere liberi è indubbiamente piacevole, e, al
contrario, la percezione di non esserlo è motivo per molti di grande
sofferenza. Non a caso tutti i moderni approcci al disagio psichico
basati sulla recovery e sull’empowerment mettono in primo piano la riacquisizione di autonomia da parte dei pazienti. “I carers
devono mostrare rispetto per la dignità intrinseca e l’autonomia
individuale delle persone con problemi di salute mentale”, recita una
dichiarazione del 2010 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
dall’evocativo sottotitolo “L’empowerment non è la meta ma il viaggio”. Ma questa è solo la teoria, la realtà, almeno per il momento, è ancora molto diversa.
 Ovviamente l’autonomia di giudizio è sempre relativa, siamo pur sempre
espressione di una ben particolare società e di un ben particolare
ambiente sociale, per non parlare della nostra biologia e dei nostri
geni, una autonomia ‘assoluta’ è un concetto privo di senso.
Ovviamente l’autonomia di giudizio è sempre relativa, siamo pur sempre
espressione di una ben particolare società e di un ben particolare
ambiente sociale, per non parlare della nostra biologia e dei nostri
geni, una autonomia ‘assoluta’ è un concetto privo di senso.
Spesso si dice che il percorso dell’essere umano, dalla puerizia alla
maturità, sia un percorso da una dipendenza pressoché assoluta, alla
conquista di una sempre maggiore autonomia. Ciò non è del tutto vero,
il bambino ha una dipendenza materiale e forse psicologica (ma in che
cosa essa consista andrebbe indagato più a fondo) da coloro che gli
prestano le cure parentali, ma allo stesso tempo ha il massimo numero
di gradi di libertà che avrà mai in tutta la sua vita: è potenzialmente
in grado di evolvere in maniera estremamente differenziata, ed è
proprio la particolare cultura e il particolare ambiente nei quali
cresce a limitare queste potenzialità e quindi, in un certo senso, la
sua autonomia, scegliendo per lui un percorso tra una possibilità di
traiettorie piuttosto limitata. Non a caso i bambini che crescono in
ambienti multiculturali (mettiamo che i due genitori provengano da
culture molto differenti tra loro) solitamente acquisiscono una maggior
apertura mentale e una maggior capacità di adattamento a situazioni
diversificate. Io, da bambino, guardavo agli adulti con un misto di
superiorità e di umana pietas, mi domandavo come fosse possibile che
fossero dei tali allocchi da dare importanza a delle cose del tutto
inessenziali, in particolare non riuscivo a capacitarmi che dessero un
tal peso a ciò che gli altri adulti pensavano di loro e, nella mia
ingenuità fanciullesca ero convinto che non avrei fatto la loro fine.
Purtroppo sono invece divenuto assi più babbeo di loro.
L’autonomia è anche una questione di quantità, a seconda della società
in cui cresciamo, la nostra effettiva scelta autonoma può decidere tra
un numero di differenti alternative assai diverse tra loro.
Il figlio di un servo della gleba, destinato dalla società in cui
viveva ad essere servo della gleba e a non spostarsi dal podere
padronale per tutta la vita, aveva un numero piuttosto limitato di
scelte tra le quali esercitare la propria autonomia. Però, visto che la
realtà di cui era conoscenza era solo quella, non è detto che
percepisse ciò come una limitazione della propria autonomia. Al
contrario, per noi che viviamo in una società in cui apparentemente il
numero di scelte possibili è elevatissimo, la nostra autonomia può
venire auto-limitata da un diffuso conformismo, noi viviamo in una
società sempre più omologata e forse crediamo di scegliere ciò che
altri hanno scelto per noi. Mi direte che se non ce ne accorgiamo, non
ha in fondo poi molta importanza; ma anzitutto noi siamo molto di più
di ciò che coscientemente crediamo di essere, e questa parte inconscia
può far sì che questa mancanza di un’autonomia reale possa causarci un
senso di malessere indefinito e inspiegabile; in secondo luogo questo
nostro sonnambulismo non è perenne, e può capitarci di risvegliarci dal
nostro torpore e che all’improvviso tutto ciò in cui abbiamo creduto ci
appaia privo di valore. Come un personaggio di un racconto di Čechov ci
viene da esclamare: “Tutto ciò che prima consideravo la mia visione del
mondo e in cui vedevo il senso e la gioia della mia vita, si è
rivoltato sottosopra ed è volato in frantumi”.
Tornando ai pazienti psichiatrici e al riconoscimento della loro
autonomia da parte delle istituzioni di cura, sarò pessimista ma vedo
un rischio: quello che i pazienti che spesso hanno una bassa autostima,
sentendosi valorizzati dalle strutture ed appagati da ciò,
inconsciamente, per non perdere questa considerazione, aderiscano al
punto di vista delle istituzioni, perdendo una reale autonomia dalle
stesse. Sto ‘sparando sulla Croce Rossa’, lo so, ma un po’ di sana
diffidenza può essere salutare.
Lasciatemi concludere con un’ultima provocazione che potrebbe essere
uno spunto per un racconto di fanta-psichiatria. Al momento esistono i
servizi per le dipendenze patologiche, ma non quelli per le autonomie patologiche.
Ma chissà, forse il DSM-6 (1) prevedrà questa nuova patologia,
sempreché, con l’attuale smania di allargare a dismisura la platea dei
pazienti psichiatrici, a quel punto, per motivi di economia, non si
deciderà di elencare, anziché i criteri di diagnosi delle malattie
mentali, i criteri in base ai quali stabilire se una persona è
psichicamente sana, visto che non più di qualche decina di persone al
mondo, coincidente con gli estensori del Manuale stesso,
soddisferebbero tali criteri. Il DSM-7 poi, non vedrà mai la luce,
perché gli estensori, avendo riscontrato in sé stessi delle gravissime
patologie psichiatriche, non si riterranno adatti alla bisogna.
Se a causa del titolo ‘autonomo’ dell’articolo, la curiosità di qualche
lettore fosse rimasta inappagata, gli do una dritta: “Né di Teseo, né
di Arianna, il labirinto appartiene al Minotauro, e in esso lui solo è
Signore”.
(1) Il DSM è il “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, edito dalla American Psychiatric Association, ormai giunto alla quinta edizione.
|
|
|
DAZZENGER
 Darietto
Darietto
● Due studenti s’incontrano. “Ciao! Ti va di studiare filosofia con me?”... “Preferisco la spagolucia”.
● Mistero della natura: I passe-rotti si possono aggiustare?
● Sapete quale verdura piace ad un asino? Il brocco-lo.
● Quale uccellino adora i castelli? Il merlo.
● Sapete cos’è un burrone? Un burro gigantesco.
● Come si addormenta un conta-dino? Contando i dino-sauri.
● Cos’è una pestilenza? È quando involontariamente pesti il piede di Enza.
● Qual è il miglior condi-vento? Il vent-aglio.
|
|
|
 LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE
LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE
 Francesca
Francesca
I
Il bambino dalla nascita in poi è alla ricerca della propria autonomia
dalla mamma, imparando a muoversi da solo nelle varie tappe del suo
sviluppo. Così l’uomo adulto diviene sempre più autonomo, imparando ad
affrontare il mondo e la realtà che lo circonda su vari aspetti:
economico, di vita quotidiana, tecnologico e via dicendo. Come si legge
nel vocabolario, l’autonomia è un concetto molto ampio che nell’uso
comune è la facoltà e capacità del singolo di regolarsi liberamente. Si
può avere, godere, raggiungere, perdere, rivendicare, difendere la
propria autonomia. L’autonomia economica è la capacità di provvedere da
sé alle proprie necessità. Per estensione, l’autonomia è indipendenza,
libertà di agire. C’è anche un’autonomia di pensiero. Ognuno di noi
costruisce un proprio pensiero, un concetto generale di vita con idee e
opinioni, influenzato dal nostro passato ma anche dalla nostra
personalità, che è di base innata, ma si costruisce anche nel tempo a
seconda delle esperienze fatte nell’arco della vita e che perciò cambia
da individuo a individuo. L’autonomia in questo senso è avere una
propria linea di pensiero da seguire e rafforzare. Essere certi e
sicuri delle proprie idee in modo da non farsi influenzare da quelle
degli altri. Sviluppare una propria capacità critica che ci consente di
fare un'attenta analisi del nostro pensiero e di quello altrui e nel
confronto rafforzare le nostre idee, in modo da divenirne fautori.
Penso anche che l’autonomia di pensiero sia una condizione mentale che
ci porta a cercare sempre il modo per fare da sé, nella vita pratica,
senza appoggiarci agli altri, in poche parole arrangiandoci, a meno che
non abbiamo bisogno di essere guidati in determinate circostanze a noi
sconosciute perché nuove, apprendendo la giusta modalità di
affrontarle. Maggiore è il nostro bagaglio di conoscenze e di
competenze acquisite, maggiore diventa la nostra capacità di gestire a
padroneggiare la nostra vita. Questo è fondamentale per riuscire a
essere liberi di scegliere e di capire quali siano le decisioni più
giuste da prendere nei diversi momenti, rendendoci più forti e quindi
autonomi. Ovviamente più siamo informati più diventiamo autonomi.
Stringendo, maggiore è il nostro bagaglio di conoscenze e competenze,
maggiore è la nostra autonomia perché siamo oltretutto liberi di
scegliere la soluzione più giusta da prendere.
|
|
|
L’AUTONOMIA E LO ZEN
 Luigi Zen pass
Luigi Zen pass
 Un’automobile si dice che con un pieno
fa 400 chilometri e si dice che questa cifra è la sua ‘autonomia’; ma
siccome l’auto è stata costruita dall’uomo, è simile all’uomo: nasce,
vive e muore. Da questo si deduce un fattore: il tempo di durata.
Affinché l’auto possa ripetutissime volte fare i 400 chilometri, è
necessario un buon uso e la manutenzione. Quindi anche per l’uomo c’è
un importante fattore: la durata della sua vita… che è un’incognita, ma
la morte è una certezza… Da quando nasce e viene allattato, l’uomo
riempie una serie di recipienti che lo rendono autonomo da un
allattamento o da un pasto al successivo; e si riempie e si vuota di
respiri e sospiri dalla nascita alla morte; quindi è dotato, come
un’automobile, di serbatoi che si riempiono e si svuotano, quelli della
sua manutenzione. Durante la sua crescita e i suoi studi non può
comunque essere completamente autonomo, poiché a lui provvede
economicamente la famiglia. Ci sono anche infinite altre eccezioni,
come è il caso di quelli che vengono adottati eccetera.
Un’automobile si dice che con un pieno
fa 400 chilometri e si dice che questa cifra è la sua ‘autonomia’; ma
siccome l’auto è stata costruita dall’uomo, è simile all’uomo: nasce,
vive e muore. Da questo si deduce un fattore: il tempo di durata.
Affinché l’auto possa ripetutissime volte fare i 400 chilometri, è
necessario un buon uso e la manutenzione. Quindi anche per l’uomo c’è
un importante fattore: la durata della sua vita… che è un’incognita, ma
la morte è una certezza… Da quando nasce e viene allattato, l’uomo
riempie una serie di recipienti che lo rendono autonomo da un
allattamento o da un pasto al successivo; e si riempie e si vuota di
respiri e sospiri dalla nascita alla morte; quindi è dotato, come
un’automobile, di serbatoi che si riempiono e si svuotano, quelli della
sua manutenzione. Durante la sua crescita e i suoi studi non può
comunque essere completamente autonomo, poiché a lui provvede
economicamente la famiglia. Ci sono anche infinite altre eccezioni,
come è il caso di quelli che vengono adottati eccetera.
Poi quando l’uomo è adulto si versa nella società e può riuscire a
trovare un lavoro o un impiego per rendersi economicamente autonomo,
per non pesare ulteriormente sulla famiglia. Eventualmente può
diventare ‘autonomo’, dipendente se assunto, o non dipendente se lavora
in proprio, o rimanere un eterno disoccupato, o diventarlo se l’azienda
è ‘psicolabile’, che licenzia o fallisce, o diventare lui
‘psicolabile’, se è il lavoro che fa lo fa diventare tale. Tuttavia,
quando l’automobile subisce interventi nel motore o in altre parti,
assomiglia ai periodi di malattia degli uomini.
Concludo dicendo che l’uomo non può essere autonomo eccetto che per le
sue piccole cose di manutenzione del corpo, anche perché l’uomo singolo
non può costruirsi un aereo o un treno per farsi un viaggio, occorre
che ci siano delle migliaia di uomini che fanno prima l’aereo o il
treno, un po’ come le formiche nel formicaio.
A proposito di mali, l’autonomia esiste e non esiste, va e viene
secondo i mali che vengono ad abitare in noi: le patologie. Così gli
italiani stanno facendo oggi un uso enorme di badanti, segno di brevi o
lunghi archi di tempo della propria vita in cui non si è del tutto
autonomi.
Proverbio Zen
Non tutti i mali vengono per nuore e per suocere…
|
|
|
VIVERE DA SOLO UNO SCOPO CHE INSEGUO DA SEMPRE
 Luca G.
Luca G.
…perché mi affascina l’autonomia,
la prospettiva di me.
Laura Pasini
È
da quando avevo dodici anni (sono nato nel 1987) che cerco di imparare
a fare le cose da solo. Così presto? - mi chiederete voi - Che cosa
pretendi? Solo a trent’anni, e spesso neanche a quell’età, si riesce a
raggiungere la piena autonomia di sé…
Io non ci vedo niente di strano a voler diventare autonomo, a voler
imparare a fare le cose da solo. Sarà per il fatto che quando andavo
alle elementari, già a otto anni, sentivo dire in giro e in TV che
c’erano ragazzi con qualche anno più di me, di undici-tredici anni, che
lo erano, e pensavo che a quell’età si diventasse ‘grandi’, in
automatico. Sarà per il fatto che sempre alle elementari io giravo per
le altre aule, guardavo dentro e addirittura usavo la mia passione per
la geografia e gli atlanti indicando i continenti e i paesi sul
planisfero ai ragazzi delle classi. Sarà per il fatto che ho visto film
come Da grande con Renato Pozzetto o Mamma ho perso l’aereo
con Macaulay Culkin, in cui il protagonista si ritrova a fare delle
cose da adulti, o a vivere solo in casa. Sarà per il fatto che quando
sentivo dire come sarebbe stata la vita futura, come mi facevo
raccontare, pensavo che in automatico tutto quanto mi sarebbe entrato
dentro, come se i miei genitori avessero il potere di infondermi
l’essenza di essere grandi in un colpo solo, senza capire che in realtà
per diventare grandi e autonomi bisogna non solo crescere fisicamente,
ma anche raccogliere e vivere quello che ti succede intorno. Ebbene, io
alle elementari ero convinto che già a dodici anni sarei stato grande.
E mi ero convinto che una volta arrivato a dodici anni prima, a
diciotto anni poi e infine a ventiquattro anni, sarei diventato un uomo
grande a tutti gli effetti, passando per la scuola media, la scuola
superiore, l’acquisizione dello status di persona maggiorenne e infine
quella di essere finalmente un uomo adulto. Tutto questo in automatico,
convinto che i diciotto anni fossero soprattutto un conseguimento di un
privilegio, che permetteva di fare alcune delle cose che fanno gli
adulti (e non credo in questo di avere tutti i torti, visto che ho
sempre saputo che solo chi ha almeno diciotto anni può accedere a certi
servizi telefonici…).
Non mi hanno mai inculcato in testa il concetto che l’università fosse
obbligatoria, ed è per questo che sin dalle medie avevo decretato che
non l’avrei mai frequentata e che avrei iniziato a lavorare, sempre in
automatico. Però mi hanno fatto capire che a ventiquattro anni, e solo
a quell’età, si diventa totalmente adulti. Probabilmente questa mia
visione delle cose era ed è generata dalla visione e descrizione che mi
era stata fatta della scuola dell’obbligo, e di cosa succede alla
propria dentatura, nel senso che l’età in cui cade l’ultimo dente da
latte e l’età in cui spunta quello del giudizio coincidono con date
importanti nella vita di un essere umano.
A undici anni terminai le elementari e iniziai le scuole medie. E a
questo punto, accadde qualcosa di nuovo. Vedevo gli atteggiamenti
esuberanti ed estroversi, quasi sfacciati, dei miei compagni e di
quelli delle classi più grandi, e oltre a starmene in disparte, ero
addirittura terrorizzato da quelli di seconda e terza media. Ricordo un
ragazzo con il cappellino del Milan pieno di chiodini, tipo quelli dei
punk, anch’egli estroverso. Ricordo che la mia fanciullezza e i miei
gusti dovevano essere messi a dura prova e poi costretti a cambiare,
perché pressati dalla presenza dei compagni di classe, di cui molti
erano stati miei compagni di catechismo e alcuni rispetto a me erano
grandissimi intenditori di cinema e di musica. Ricordo pure che fu
proprio in prima media che iniziai a guardare gli episodi dei Simpson,
il primo fu La paura fa Novanta VIII,
uno special di Halloween. Ricordo che quando dicevo che mi piacevano i
film comici italiani, con attori tipo Villaggio e Pozzetto mi si
rispondeva male, e che quando dicevo che mi piacevano gli 883 mi si
rispondeva ancora peggio.
 Ricordo che un giorno io e un compagno vedemmo un’immagine della Pimpa,
che a me piaceva tanto da piccolo e che, quando il compagno mi chiese
cos’era, io per non sfigurare dissi: “Roba da piccoli”, non solo
sentendomi correggere che era la Pimpa, ma creando inconsapevolmente un
muro tra me e la cagnolina di Altan. Ricordo perfino una volta che una
prof mi chiese di entrare in una classe a me superiore, non ricordo se
una seconda o una terza media, perché facesse silenzio. Bussai, e poi
dissi timidamente: “Scusate l’intrusione, ma…” … “Che vuoi, baby?” , mi
chiese uno dei ragazzi. “La professoressa mi ha detto di dirvi di stare
zitti!” . Dissi questa frase quasi urlando, stizzito, e di botto
richiusi la porta per paura delle reazioni dei ragazzi più grandi. E
ricordo pure che prima di partire per una gita, mi ritrovai seduto sul
pullman affiancato ad alcuni ragazzi più grandi, sempre delle medie, e
invano dal finestrino chiesi a mia madre di fare qualcosa. Ma sto
divagando. Per tornare al discorso dell’autonomia, voglio citare un
episodio significativo, sempre risalente alla prima media. Il nostro
prof di educazione tecnica non aveva un buon carattere, almeno io non
lo sopportavo benissimo, però ci procurava sempre i biglietti per le
partite di Coppa UEFA del Bologna. In occasione della semifinale di
ritorno col Marsiglia, io chiesi di farmi dare un biglietto solo. Era
mia intenzione andare da solo allo stadio, visto che abito lì vicino,
ritrovarmi coi compagni di classe, vedere la partita e tornare a casa.
Mio padre non la prese per niente bene, e credetti volesse vietarmi di
vedere la partita, tanto che coprii con vergogna la maglietta rossoblù
che avevo indossato per l’occasione. Anzi, fraintesi la sua ira e
rimasi male nel sentirlo dire che voleva accompagnarmi a tutti i costi.
Pensavo addirittura che volesse accompagnarmi perché poteva esserci
maltempo! “Guarda, non piove”, gli dissi una volta usciti dal portone,
ma lui non rispose. Una volta allo stadio, negli ingressi sotto la
Torre Maratona (era il 1999, non c’erano ancora i tornelli e tutti i
controlli che si fanno oggi) un bigliettaio ebbe comprensione della
situazione e dette al babbo un biglietto strappato caduto per terra,
così potemmo entrare e goderci la partita, così come ci eravamo goduti
gli ultimi minuti della partita d’andata contro il Lione. Solo allora
mio padre tornò a essere allegro. Ma solo perché ero con lui e non da
solo.
Tutto bene, finché non si tornò a casa. Pensavamo che evitando la ressa
finale quando tutti lasciano lo stadio avremmo superato il peggio. Non
era così: Laurent Blanc tirò un rigore e segnò (due volte!), e poi
nell’ingresso degli spogliatoi scoppiò una rissa tra i giocatori. E
come se non bastasse, i compagni di classe che pensavo di vedere
vennero a suonare sotto casa in un momento in cui io ero già a letto a
dormire! Ditemi voi se non è assurdo!
Ricordo che un giorno io e un compagno vedemmo un’immagine della Pimpa,
che a me piaceva tanto da piccolo e che, quando il compagno mi chiese
cos’era, io per non sfigurare dissi: “Roba da piccoli”, non solo
sentendomi correggere che era la Pimpa, ma creando inconsapevolmente un
muro tra me e la cagnolina di Altan. Ricordo perfino una volta che una
prof mi chiese di entrare in una classe a me superiore, non ricordo se
una seconda o una terza media, perché facesse silenzio. Bussai, e poi
dissi timidamente: “Scusate l’intrusione, ma…” … “Che vuoi, baby?” , mi
chiese uno dei ragazzi. “La professoressa mi ha detto di dirvi di stare
zitti!” . Dissi questa frase quasi urlando, stizzito, e di botto
richiusi la porta per paura delle reazioni dei ragazzi più grandi. E
ricordo pure che prima di partire per una gita, mi ritrovai seduto sul
pullman affiancato ad alcuni ragazzi più grandi, sempre delle medie, e
invano dal finestrino chiesi a mia madre di fare qualcosa. Ma sto
divagando. Per tornare al discorso dell’autonomia, voglio citare un
episodio significativo, sempre risalente alla prima media. Il nostro
prof di educazione tecnica non aveva un buon carattere, almeno io non
lo sopportavo benissimo, però ci procurava sempre i biglietti per le
partite di Coppa UEFA del Bologna. In occasione della semifinale di
ritorno col Marsiglia, io chiesi di farmi dare un biglietto solo. Era
mia intenzione andare da solo allo stadio, visto che abito lì vicino,
ritrovarmi coi compagni di classe, vedere la partita e tornare a casa.
Mio padre non la prese per niente bene, e credetti volesse vietarmi di
vedere la partita, tanto che coprii con vergogna la maglietta rossoblù
che avevo indossato per l’occasione. Anzi, fraintesi la sua ira e
rimasi male nel sentirlo dire che voleva accompagnarmi a tutti i costi.
Pensavo addirittura che volesse accompagnarmi perché poteva esserci
maltempo! “Guarda, non piove”, gli dissi una volta usciti dal portone,
ma lui non rispose. Una volta allo stadio, negli ingressi sotto la
Torre Maratona (era il 1999, non c’erano ancora i tornelli e tutti i
controlli che si fanno oggi) un bigliettaio ebbe comprensione della
situazione e dette al babbo un biglietto strappato caduto per terra,
così potemmo entrare e goderci la partita, così come ci eravamo goduti
gli ultimi minuti della partita d’andata contro il Lione. Solo allora
mio padre tornò a essere allegro. Ma solo perché ero con lui e non da
solo.
Tutto bene, finché non si tornò a casa. Pensavamo che evitando la ressa
finale quando tutti lasciano lo stadio avremmo superato il peggio. Non
era così: Laurent Blanc tirò un rigore e segnò (due volte!), e poi
nell’ingresso degli spogliatoi scoppiò una rissa tra i giocatori. E
come se non bastasse, i compagni di classe che pensavo di vedere
vennero a suonare sotto casa in un momento in cui io ero già a letto a
dormire! Ditemi voi se non è assurdo!
Attorno ai tredici anni, nell’anno di seconda media, varie circostanze
fecero sviluppare in me un grandissimo senso del pudore e della
vergogna, così grande da suscitare nei compagni di scuola dei buoni
pretesti per prendermi in giro. Per esempio il tentativo che feci per
festeggiare con musica ad alto volume l’inizio del 2000, soffocato
immediatamente dai genitori. Oppure l’atto di conservare in camera il
calendario senza veli di Alessia Marcuzzi, che già tenevo nascosto in
un armadio con gancio perché nessuno lo vedesse. Ma era inutile. Ogni
volta che mio padre apriva l’armadio, fingeva di rivolgersi alla
Marcuzzi con tono lezioso: “Ehi, ciao!”, diceva, facendomi irritare per
la vergogna. E pensare che per evitare di sentirmi dire chissà cosa
dall’edicolante, avevo chiesto proprio a lui di comprarlo al mio posto.
Un altro esempio che faccio è stato quando una sera vidi l’inizio di un
videoclip, con un polipo gigantesco che dopo aver distrutto la statua
della Sirenetta a Copenaghen, la Torre Eiffel e la Statua della
Libertà, spaventava a morte una famiglia già terrorizzata da un
servizio televisivo riguardante il polipo stesso. Quando mia madre mi
vide atterrito, mi chiese il perché, io per la vergogna spiccicai
qualche parola e lei aumentò ancora di più il mio sentimento, dicendomi
che il video-clip non avrebbe avuto successo né sarebbe piaciuto se ci
fossero stati i protagonisti nell’atto di raccogliere i fiori o di fare
una gita in barca sul lago.
A quattordici anni, in terza media, leggemmo in classe un brano tratto
da un’autobiografia di Niki Lauda, nella quale egli raccontava di
guidare già da ragazzino una macchina. A casa dissi che anche a me
sarebbe piaciuto guidare un’auto, magari una vecchia utilitaria, nel
cortile della casa di campagna. Solo quando i miei genitori
realizzarono che cosa intendevo dire ci fu la loro reazione,
indubbiamente negativa. Ciò significa che già da adolescente sognavo di
imparare a guidare, cosa che ritenevo avrei imparato in automatico da
grande, o almeno lo ritenevo scontato. Ebbene, ancora oggi non ho mai
imparato a farlo, non ho neanche mai iniziato a seguire le lezioni per
la patente. In America già nei licei ci sono i corsi per imparare a
guidare, già a sedici anni si diventa maggiorenni e si può prendere la
patente. “Ma non si è forse un po’ troppo immaturi a sedici anni?”, mi
ha chiesto mia madre. E poi, se in America circolano così tante
macchine, mi chiedo io, forse non è anche per questo che c’è tanto
inquinamento? Sempre a quattordici anni, però, ci furono anche delle
occasioni in cui imparai a fare delle cose da solo. Per esempio mi
capitò di andare da solo a giocare al bar di via Zoni o al bowling che
c’era in via San Felice. Ma erano ancora i miei primi tentativi,
infatti per almeno due volte fui sgridato perché non ero tornato a casa
entro l’orario stabilito, e una perché oltre a essere tornato in
ritardo avevo perso il berretto.
Ma ci sono stati anche casi contrari. Una sera, i miei avevano deciso
che saremmo andati prima in pizzeria, tutti quanti, e poi a giocare al
bowling di San Lazzaro. Al mio posto chiunque sarebbe stato
felicissimo. Ma io non lo fui, perché ero già bell’e contento di
giocare al computer in casa mia e poi la notizia era del tutto
inaspettata. Perciò fui imbronciato, feci storie, addirittura simulai
dei pianti per poter tornare a casa. E questo solo perché i miei non
volevano lasciarmi in casa da solo. Però avevo capito le loro buone
intenzioni, avevo visto quanto immenso fosse il bowling, perciò su mia
proposta ci ritornammo il sabato successivo, e stavolta passammo una
bella serata.
 Mi rendo conto che dovrei parlare di essere autonomi, e che invece mi
ritrovo a raccontare questi episodi di vita che ho vissuto. Cosa vuol
dire essere autonomo? Vuol dire fare le cose da soli, senza assistenza,
o senza qualcuno che le faccia per te.
Mi rendo conto che dovrei parlare di essere autonomi, e che invece mi
ritrovo a raccontare questi episodi di vita che ho vissuto. Cosa vuol
dire essere autonomo? Vuol dire fare le cose da soli, senza assistenza,
o senza qualcuno che le faccia per te.
Alla mia età ci sono ancora tantissime cose che non sono in grado di
fare, e che forse non imparerò mai, che mi sono precluse. Sarà per il
fatto che ogni volta che c’era qualcosa da fare i miei genitori mi
dicevano: “Tranquillo, ci pensiamo noi!”, scansandomi e facendo per me
quello che c’era fare, precludendomi ogni possibilità di imparare di
persona. Mio padre era così, voleva sempre fare tutto personalmente. E
quindi non potevo imparare nulla, né avere spiegazioni, nemmeno
prendere iniziative o dare suggerimenti e fare osservazioni che
potevano anche essere corrette.
Per fare qualche altro esempio, devo tornare a parlare di alcuni
episodi vissuti alle medie, se non prima. Una volta, alla Coop, avevo
visto un adolescente alla cassa, che pagava la spesa, avrà avuto
quindici-sedici anni. Da allora ho sempre pensato che prima o poi la
spesa da solo l’avrei fatta anch’io, arrivato a quell’età. Credo
conosciate lo stereotipo del ragazzo che viene mandato dalla mamma a
fare la spesa e invece di comprare cibi fondamentali come pane, latte,
formaggio eccetera compra solo quel che piace a lui: gelati, nutella,
caramelle, bibite e così via. Credetemi, se facessi io una cosa del
genere mi metterei sottoterra dalla vergogna, proprio perché so bene
che i miei reagirebbero molto male, rimproverandomi per aver buttato
via dei soldi. Eppure, capitarono dei problemi ai primi tentativi che
feci già a dodici anni. Una volta presi l’iniziativa di acquistare Famiglia Cristiana,
oltre alle uova, e dovetti restituire il giornale perché i soldi che
avevo a disposizione non bastavano per comprare anche quello. E a casa
la presero male. Un’altra volta comprai un derivato del latte diverso
da quello che voleva la mamma, solo perché non ero riuscito a trovarlo,
e non potei neanche andare a cambiarlo subito perché avevo gettato via
lo scontrino e dovemmo telefonare al direttore del supermercato per
risolvere la cosa. Una terza volta comprai quel che serviva per fare
gli gnocchi al pesto, ed ebbi qualche difficoltà nel portare in mano la
roba a casa, che non era neanche tanta, perché non avevo pensato che
fosse necessario prendere la sportina di plastica. Ricordo però altri
episodi, anche divertenti, di economia domestica. Per esempio, da
piccolo, mi era capitato di salire su un minuscolo banco per
raggiungere il lavello e lavare i piatti, riuscendo a non romperli. E
un’altra volta, a quattordici anni, preparai la pasta per i miei tutto
da solo. Unico difetto, dopo aver scolato la pasta non la rimisi in
pentola per mescolarla al sugo, ma feci in modo che la pasta venisse
trovata come si vede nelle pubblicità, cioè la versai in bianco nei
piatti in modo da riempirli fino all’orlo e sulla sommità posi il sugo.
La pasta inoltre era perfettamente al dente, visto che avevo seguito
alla lettera i tempi di cottura. Il giudizio fu accettabile, e le
intenzioni apprezzate.
Ma il desiderio di imparare anch’io alcune faccende domestiche non si è
limitato al cibo e alla spesa. Infatti mi è stato insegnato
superficialmente come pulire per terra, ma a parte il fatto che non mi
è capitato spesso di doverlo fare, ancora oggi quelle poche volte che
lo faccio finisco solo per rendere appiccicoso o scivoloso il pezzo di
pavimento che avevo sporcato e che dovevo ripulire. Almeno finora non
ho causato incidenti. Comunque ancora oggi preferisco evitare di
sporcare piuttosto che dover ripulire. Discorso che vale anche per i
vestiti, poiché anche mia madre, quando le ho chiesto di dirmi come si
lavano i panni, mi ha spiegato che lei stessa fatica a gestire la
lavatrice e che stirare è difficile. Capisco benissimo, però la mamma
lava e stira lo stesso, mentre io mi limito solo a riportare i panni
dentro casa quando si sono asciugati. So che il ferro da stiro è molto
pericoloso, che potresti bruciarti una mano, che se lasci troppo tempo
il ferro acceso su un panno questo si brucia e si fa il buco, ma se non
impari a farlo, se non sbagli qualche volta, come cavolo impari?! Anche
questo è diventare autonomi, fare pratica e sbagliare!
Adesso riesco benissimo ad andare anche in posti lontani da solo, in
autobus o a piedi, per qualche tempo sono pure andato fino a San
Lazzaro da solo, per una borsa lavoro, però ricordo che a undici anni
fui costretto ad andare alla scuola media che stava nella mia via,
raggiungibile camminando per cinque minuti, solo perché non ce n'erano
altre. Mi lamentai moltissimo di questo (almeno finché non visitai la
prima volta la scuola, rimanendone estasiato e illudendomi che avrei
fatto tante ore di laboratorio), infatti non solo non volevo
rincontrare i ragazzi del catechismo e del vicinato, ma volevo
continuare ad avere contatti con quelli delle elementari. Pensavo che
molti sarebbero andati alle Zanotti, vicino a via Agucchi, ed ero pure
attratto dai laboratori di informatica e di audio lingua di quella
scuola, quindi dichiarai che volevo andare là. I miei erano molti
stupiti e dispiaciuti, per non dire scandalizzati da questa cosa,
perché significava che avrei dovuto alzarmi presto e prendere
l’autobus, e impiegare molto tempo per tornare a casa, ciò che infatti
poi mi ritrovai a fare per andare a lavorare a San Lazzaro. Eppure a
undici anni ero desiderosissimo di farlo, convinto di fare bene, perché
prima impari a fare una cosa faticosa, prima ti abitui a farla. Anzi,
mi giustificai appunto dicendo che prendendo l’autobus a undici anni da
solo “avrei imparato che la vita è fatta di fatica e sudore”.
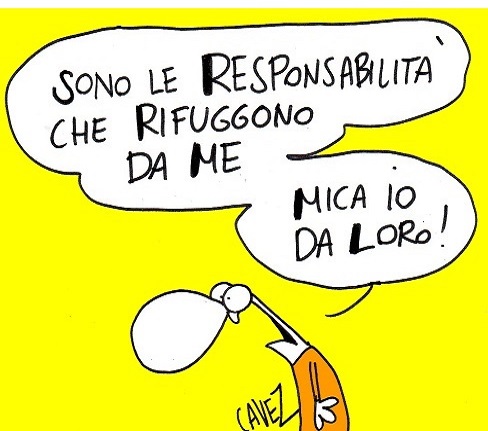 Non dico che i miei mi hanno sempre cresciuto nella bambagia, però è
anche vero che mi hanno dato poche possibilità di imparare a fare le
cose da solo, di fare esperienza, ritenendo che fosse sempre troppo
presto. E non ho neanche fatto quei laboratori che pensavo di fare. In
ogni caso ho imparato ad andare a scuola da solo semplicemente
attraversando la strada quand’ero alle medie, e poi a prendere
l’autobus quando si trattava di andare al liceo, scelto sempre
basandosi su quanto vicino a casa fosse e con che autobus si potesse
raggiungere. Non so però guidare la macchina, e a volte penso che sia
giusto così, perché non sono sicuro di potermi riabituare a studiare
per prendere la patente, anzi mi sono disabituato molto in fretta.
Anche mia madre dice che se dovesse perdere la patente e ricominciare a
capo, dovrebbe ridursi a usare la bici. Altre volte però penso che
saper guidare può sempre tornarmi molto utile, metti caso che mi
ritrovo da solo e che devo fare un viaggio. Almeno una volta ho
viaggiato da solo in treno, anzi, persino i viaggi fatti in altre città
o all’estero con la scuola mi hanno formato, ma se i miei parenti
dovessero regalarmi casse di ortaggi e primizie, come faccio io a
portarmeli se non so guidare la macchina?! Tornando poi alle faccende
domestiche, devo dire che se ho imparato a cucinare è stato solo perché
un giorno, a ventun anni, ho chiesto energicamente a mia madre di
spiegarmi come si fa e lei ha accettato, non solo perché imparassi a
fare una cosa che mi sarebbe sempre tornata utile, ma pure perché in
quei giorni doveva stare dietro al babbo che era malato. Se non mi
avesse insegnato, avrebbe dovuto dividersi tra le mie esigenze e quelle
del babbo, oppure lasciarmi senza la possibilità di mangiare visto che
la malattia del babbo era poco chiara e abbastanza grave. Per carità,
mia madre non mi ha insegnato a preparare piatti elaborati come la
parmigiana o certi tipi di torta, anzi, grazie a lei so come preparare
le cose basilari, come la pasta, la carne, le uova, senza rischiare di
scottarmi, bruciarmi, tagliarmi o incidenti simili. Ma almeno sento di
aver raggiunto uno scopo. Anche se l’unica volta che ho voluto provare
a usare il microonde per cuocere invece che per scaldare, ho bruciato
un piatto, delle patate e ho persino fuso il panno di plastica usato
per porre i piatti sul banco di lavoro della cucina. Se al centro
diurno di via Tasso ho voluto fare attività ambientate in cucina è
stato anche e soprattutto perché ero convinto di poter imparare
qualcosa in merito, anche se non ho imparato molto, solamente a stare
insieme ad altri e collaborare tutti insieme alla preparazione di un
piatto o di un pranzo. Lo ripeto, se ho imparato è stato solo perché ho
insistito a lungo con mia madre perché mi insegnasse. Desiderio
scaturito dalla voglia di rendermi autonomo, e quindi di emanciparmi,
di non dover più andare via di casa quando i miei genitori vogliono
assentarsi per una settimana o due, solo perché io in casa da solo non
so stare per tutto questo tempo. E la cosa non mi piace più tanto dal
giorno in cui improvvisamente il babbo mi prelevò dalla scuola per
andare dritti filati in Puglia per il funerale di mio nonno.
Non dico che i miei mi hanno sempre cresciuto nella bambagia, però è
anche vero che mi hanno dato poche possibilità di imparare a fare le
cose da solo, di fare esperienza, ritenendo che fosse sempre troppo
presto. E non ho neanche fatto quei laboratori che pensavo di fare. In
ogni caso ho imparato ad andare a scuola da solo semplicemente
attraversando la strada quand’ero alle medie, e poi a prendere
l’autobus quando si trattava di andare al liceo, scelto sempre
basandosi su quanto vicino a casa fosse e con che autobus si potesse
raggiungere. Non so però guidare la macchina, e a volte penso che sia
giusto così, perché non sono sicuro di potermi riabituare a studiare
per prendere la patente, anzi mi sono disabituato molto in fretta.
Anche mia madre dice che se dovesse perdere la patente e ricominciare a
capo, dovrebbe ridursi a usare la bici. Altre volte però penso che
saper guidare può sempre tornarmi molto utile, metti caso che mi
ritrovo da solo e che devo fare un viaggio. Almeno una volta ho
viaggiato da solo in treno, anzi, persino i viaggi fatti in altre città
o all’estero con la scuola mi hanno formato, ma se i miei parenti
dovessero regalarmi casse di ortaggi e primizie, come faccio io a
portarmeli se non so guidare la macchina?! Tornando poi alle faccende
domestiche, devo dire che se ho imparato a cucinare è stato solo perché
un giorno, a ventun anni, ho chiesto energicamente a mia madre di
spiegarmi come si fa e lei ha accettato, non solo perché imparassi a
fare una cosa che mi sarebbe sempre tornata utile, ma pure perché in
quei giorni doveva stare dietro al babbo che era malato. Se non mi
avesse insegnato, avrebbe dovuto dividersi tra le mie esigenze e quelle
del babbo, oppure lasciarmi senza la possibilità di mangiare visto che
la malattia del babbo era poco chiara e abbastanza grave. Per carità,
mia madre non mi ha insegnato a preparare piatti elaborati come la
parmigiana o certi tipi di torta, anzi, grazie a lei so come preparare
le cose basilari, come la pasta, la carne, le uova, senza rischiare di
scottarmi, bruciarmi, tagliarmi o incidenti simili. Ma almeno sento di
aver raggiunto uno scopo. Anche se l’unica volta che ho voluto provare
a usare il microonde per cuocere invece che per scaldare, ho bruciato
un piatto, delle patate e ho persino fuso il panno di plastica usato
per porre i piatti sul banco di lavoro della cucina. Se al centro
diurno di via Tasso ho voluto fare attività ambientate in cucina è
stato anche e soprattutto perché ero convinto di poter imparare
qualcosa in merito, anche se non ho imparato molto, solamente a stare
insieme ad altri e collaborare tutti insieme alla preparazione di un
piatto o di un pranzo. Lo ripeto, se ho imparato è stato solo perché ho
insistito a lungo con mia madre perché mi insegnasse. Desiderio
scaturito dalla voglia di rendermi autonomo, e quindi di emanciparmi,
di non dover più andare via di casa quando i miei genitori vogliono
assentarsi per una settimana o due, solo perché io in casa da solo non
so stare per tutto questo tempo. E la cosa non mi piace più tanto dal
giorno in cui improvvisamente il babbo mi prelevò dalla scuola per
andare dritti filati in Puglia per il funerale di mio nonno.
Un giorno avevo pure chiesto al babbo: “Mettiamo che io un giorno
diventi completamente autonomo. Cosa farete voi?”, lui mi assicurò che
in tal caso mi avrebbe lasciato decidere se venire o no con lui in
campagna. Ma finché non avessi imparato a stare da solo in casa, avrei
dovuto andare dove voleva lui e fare come diceva lui. Non è solo
autorità questa, ma anche un certo grado di protezione. Di genitori
protettivi, anche troppo, ce ne sono tanti. E purtroppo, occasioni per
fare anche solo il primo passo per diventare autonomo mi sono state
precluse.
Adesso ho ventinove anni, anzi quasi trenta, e ancora oggi sono
costretto ad andare a Foggia quando vuole mia madre, pure perché ci
sono molte, moltissime cose che non so fare e che potrebbero rendermi
totalmente autonomo. Per esempio non so fare il pesce, anzi mia madre
mi ha detto che se devo mangiare del pesce, devo accontentarmi di pesce
in scatola, perché quello fresco è difficilissimo da pulire e cucinare.
Eppure mi basterebbe imparare. Lo stesso vale ovviamente per bollire la
verdura, sbucciare la frutta (per la verità non riesco nemmeno a
mordere le mele come fanno tutti), lavare i panni, pulire per terra,
pulire il bagno, stirare, guidare l’auto, persino tagliarmi le unghie
dei piedi (ma credo sia un’abilità di tipo diverso, come allacciarsi le
scarpe). E potrei aggiungere anche curarmi come si deve quando ho un
malanno o un infortunio senza che mi rivolga a un medico o a qualcuno
più esperto di me. Però le possibilità che io possa imparare a fare le
cose da solo possono aumentare sensibilmente in futuro, perché
crescendo, evolvendomi, vivendo ho imparato a fare cose che da piccolo
non sopportavo né concepivo, come sopportare la presenza in casa
d’altri. Inoltre, c’è la possibilità che in un futuro neanche troppo
immediato, mia madre progetti e magari riesca a procurarsi un
appartamento tutto suo, nello stesso palazzo, nel piano sotto a quello
dove abitiamo insieme per il momento, in modo da poter venire ogni
tanto a vedere se va tutto bene o se ho bisogno di qualcosa. Di
conseguenza, a stare in casa da solo potrei diventare un po’ più
responsabile e imparare a fare altre cose, e accrescere il mio grado di
autonomia e indipendenza.
Essere autonomi non è solo un traguardo di vita, non è solo badare a sé
stessi, imparare delle abitudini sane, è anche poter affermare la
propria essenza, il proprio essere su sé stessi e sugli altri. Che
razza di vita è quella di una persona che dipende sempre e solo dalle
altre persone?! Come potrà mai condurre le proprie abitudini senza che
vengano intaccate dall’influenza degli altri?! Secondo me se uno è
dipendente dagli altri, non potrà mai afferrare del tutto la vita che
lo circonda. Se si è indipendenti invece, si può decidere da soli cosa
fare, come condurre le proprie giornate, come seguire un buon stile di
vita, come vivere, insomma. Autonomia è affermazione, è indipendenza, è
libertà. E raggiungere la più completa autonomia sarebbe per me una
grande soddisfazione, la più grande di tutta una vita.
|
|
|
DELLA MORTE O DEI SOPRAVVISSUTI
OVVERO DELLA SCOMPARSA DI PERSONE CARE E DELL’AUTONOMIA
 Matteo Bosinelli
Matteo Bosinelli
 "… non sapeva neppure la data della sua morte, che pur prevedeva vicina", da Jean Genet, Querelle de Brest,
finale dell' omonimo, formidabile film (pur anche nelle sue parti
perverse), del grande regista tedesco Rainer Werner Fassbinder (1982)
"… non sapeva neppure la data della sua morte, che pur prevedeva vicina", da Jean Genet, Querelle de Brest,
finale dell' omonimo, formidabile film (pur anche nelle sue parti
perverse), del grande regista tedesco Rainer Werner Fassbinder (1982)
I due sopravvissuti, quando si videro, si guardarono un attimo,
incantati, e poi si sorrisero teneramente, Si presero per mano l'un
l'altra come un fratello e una sorella e ... non erano più soli.
Era la mia ultima scalata di una montagna, e volli arrischiarla da
solo. Sentivo che la Morte mi precedeva, ma quando l'avrei raggiunta?
"L' idea del mare evoca l'idea dell'amore, l'idea dell'amore evoca l'idea della morte...".
Inizio sia del romanzo sia del film sopracitati. È un concetto
(interessante e suggestivo sì, ma che mi lascia alquanto perplesso. Che
ne pensa il lettore?).
Ne Il settimo sigillo,
Bergman fa morire il Cavaliere che cerca di opporsi alla morte con il
gioco degli scacchi e lascia sopravvivere l'Artista un po’ naïf.
"Pare infatti che la creatività sia il solo mezzo, anche se illusorio,
che noi possediamo per meno affliggerci dell'inesorabilità del morire",
ha scritto qualcuno.
|
|
|
L’AUTONOMIA
 Tina Gualandi
Tina Gualandi
Vivo sola da molti anni ed è tutto
sulle mia spalle. Dovrei essere autonoma, ma non mi ci sento del tutto,
perché sono abbastanza negata per le cose tecniche (computer,
telefonino, videoregistratore). Ho una casa di mia proprietà, che ho
pagato con un mutuo (molto faticoso), faccio molta fatica ad arrivare a
fine mese, anche perché ho delle spese condominiali costose e non sono
proprio per niente brava a risparmiare. Mia sorella dice che sono una
cicala (mentre lei è una formica); in realtà Bologna non è una città a
buon mercato e vivere sola e con pochi risparmi non è semplice. Quando
abitavo con i miei genitori ho dovuto combattere con un padre
spilorcio, che mi ha fatto diverse volte pentire di essermi iscritta
all’università, e non appena mi sono laureata ho iniziato subito a
cercare dei lavoretti per mantenermi senza chiedere più niente a casa.
Quando ho iniziato a lavorare stabilmente, mia madre era già morta e
con mio padre avevo già rotto i ponti, quindi avevo già un’autonomia
che mi stava stretta, anche perché avevo rapporti difficili con mia
sorella, che non aveva mai capito perché per me fosse così importante
stare lontano da casa e da mio padre e vivere per conto mio. Ci sono
delle volte che penso che avrei dovuto lavorare subito dopo la
maturità: avrei certamente faticato meno, viaggiato di più e mi sarei
goduta maggiormente mia madre, che desiderava la mia autonomia,
soprattutto perché quando mio padre ed io discutevamo per i soldi lei
soffriva molto. Essere autonomi è bello ed importante. Soprattutto, se
si è autonomi, si è anche liberi.Non esiste una vera libertà se non c’è
una vera autonomia.
|
|
|
PIOVE
 Marcella Colaci
Marcella Colaci
Piove,
la pioggia sembra cancellare
i ricordi
come mani nasconde
purifica il presente
pare sia l'unico modo
per sottrarre
le paure
che tutto si ripeta
che tutto sia vano
ma è un'altra storia
un'altra vita
un altro amore
e piove
lasciando stare
il sole
passeggio
spero
ma indietreggio
cadendo nei sogni
irrealizzabili
impercettibili
ancora la pioggia è lenta
non distrae
ma il cielo è in subbuglio
fino a oscurare
io
io porto dentro il sole.
|
|
|
… FRA LA DENSA BRUMA
 Matteo Bosinelli (1977)
Matteo Bosinelli (1977)
Laggiù in quel piccolo paesino
splende ridente
la luce di una festa.
Ed io quassù chino
me ne sto riverente,
solo a pensare alla mia vita mesta.
E stelle e pianeti,
fra la densa bruma,
gridano agli occhi miei:
"Figliol, altro non sei
che una lacrima di Luna".
|
|
|
VIA VENEZIA N. 5
 Anonimo
Anonimo
Né sbarre alle finestre
né catenacci alle tue porte.
Fuori un grande salice piangente
ogni giorno aspetta il tuo ritorno!
Il suo nome è un po’ triste
come un po’ triste è l'effigie al suo cancello,
ma le tue stanze
son dimora
di affetti e di speranze!
Dai vetri, da variopinte
tende agghindati,
scorgi un grande parco
che tutto intorno ti sorride
e dietro ai grandi alberi
silenziosamente
scorre un fiume.
Tutto questo
può esser terapia
ma per me
è diventato casa mia!
Se a volte sei un po’ triste
o di sofferenza prigioniero
non ti dimenticar
di Via Venezia
perché è lì che puoi sorridere
per continuare a vivere.
Forse per me un giorno
diventerai dimora passeggera
ma di te il ricordo
rimarrà per sempre
che cancellar
nessuno mai potrà.
|
|
|
CI PENSO
 Marcella Colaci
Marcella Colaci
Ci penso
ti penso
e ti amo
volevo
morire
poi
ci ho
ripensato
vita maledetta
pensavo
poi
ci ho ripensato.
|
|
|
L’AUTONOMIA
 Paola Scatola
Paola Scatola
Volevo diventare di qualcuno
perché non ero indipendente
ancora.
Ora sono mia.
|
|
|
L’AUTONOMIA
 Paola Scatola
Paola Scatola
Colgo l’attimo che mi dai
e ti prendo la mano
su quel letto
perché c’è in te qualcosa
che ci appartiene:
l’amore.
|
|
|
ALL’OSPEDALE
 Mirna Zucchini
Mirna Zucchini
Me ne andavo un mattino a lavorare
quando vidi un’anziana stare male,
era un’anziana che aveva un dolore
così chiamai subito il dottore.
Al letto s’è fermato è stato un poco
e poi s’è ritornato, è ritornato ed è
venuto a me e mi chiese: che male c’è?
Ha un forte dolore addominale e
al bagno non riesce ad andare.
Fu subito chiamata ed al suo arrivo
la domanda fu scontata: signora di aria ne fa?
No, no dottore noi siamo una razza che non ne fa!
|
|
|
OGNI COSA PASSA
 Rita Di Pietro
Rita Di Pietro
Adesso che sono al buio
In una stanza vuota
Chiedo
Perdono a Dio per loro:
Mi hanno legato le mani
Mi hanno bendato gli occhi
Mi tormentano....
Non mi lamento mai
Ragionando con un filo di speranza
Penso che tutto passerà.
Mi hanno martoriato in ogni parte del corpo
Torturandomi ingiustamente,
Si sono divertiti a tagliarmi le ciocche
Dei miei folti capelli,
Mi hanno iniettato il loro veleno,
Mi hanno rubato tutto l'oro
Depositato in banca,
Mi hanno tradito davanti
E in casa mia,
Mi hanno ingannato con le loro bugie,
Mi hanno soffocato con la loro cocciutaggine
Gettandomi nella spazzatura
Puzza di marcio asfissiante,
Mi hanno ferito d' umiliazioni,
Mi hanno cosparso il vestito di cenere
Bruciandolo in vari punti,
Nuda e distrutta
Mi hanno scaraventato giù dalle scale
Poi dal balcone,
Mi hanno calunniato senza ritegno
Portandomi via i figli, i nipoti ancora piccoli,
Offendendo la mia purezza d'animo.
Mi hanno sequestrato, facendomi il terzo grado,
Mi hanno lasciato qui agonizzante
In una pozza di sangue,
Dividendomi in tre parti.
Tornerò a casa, il lavoro è finito,
Tutto passa nel dimenticatoio:
Fame, sete e malattie!
|
|
|
PER DIRITTO
 Rita Di Pietro
Rita Di Pietro
Sorella e fratello, fedeli rappresentanti
Di una volta. Qualcuno se volesse criticarli.
Essi pulivano le vostre mani ruvide
I partiti si allenavano, con la candela accesa, bianca e nera.
Si moriva di gelo e che schifo il vostro cibo,
I compagni portavano il pane per i profughi.
Qualcuno è sopravvissuto per raccontarlo.
Sono disoccupato, per questo uccidevano i padri vecchi.
Durante tale millennio i decreti si ristabilirono.
Una vera adozione, tingevano i pavimenti
Con l'arcobaleno dell'amore!
|
|
|
PARLARE SCHIETTO: CON RISPETTO
 Rita Di Pietro
Rita Di Pietro
Perché piangi, quando hai tutto o quasi?
Mi sento sprecato, vorrei dire tante cose
Nessuno m'ascolta.
Dille a me che capisco: incidi un disco
Hai una bella voce, parli bene (predichi)
Hai imparato una lingua rara: schietta e perfetta.
Ti faccio il solletico poi tu parli per telefono.
Esco in giardino e incontro il soldatino,
Lo afferro per mano e lo getto in mezzo al gruppo.
Fui contenta di lasciarti un documento, scritto:
Sono riconoscente e vi nomino sergente!
Non era necessario era già stato decorato.
La penna gli scivola, gustava la cioccolata.
Buonasera, stampo nel berretto il mio stemma
Aquila nera!
Sull'attenti è arrivato il gran capo, ha portato
Il gelato. Tutti mangiano felici poi vanno al gabinetto,
Lo trovano interdetto. Come mai? Occupato da un servizio
Di Stato.
Con un giorno anticipato non potevo farvi entrare:
Logico è aspettare.
Beviamo il tè o il caffè?
Cambiano subito squadriglia e succede un parapiglia.
Mangiano suonano e ballano.
Il disco poi finiva e un bebè faceva uè uè.
Bella la tua sposa, in vacanza la sposavi.
Sei papà, forza lascia quella pappa troppo molle.
Cucinare del buon riso per la truppa e non la solita zuppa.
Componi una canzone da mandare in divisione.
Tutti sono allineati e si lisciano i capelli
Sono belli del comando e tu dici:
Cari sono guai se non fate ciò che dico, pigliate pane e vino
Poi mi date un pochino di ricotta per la mia dolce cocca.
|
|
|
L’AUTONOMIA
 Paola Scatola
Paola Scatola
Ti amo
perché ho bisogno di te.
Vicina non sono
sola con voi
e lo so.
|
|
|
CHE BELLO ESSERE AUTONOMI DEL TUTTO
 Lucia Monacao
Lucia Monacao
 I
nnanzitutto, prima che mi metta a scrivere e a elaborare l’argomento
‘autonomia’, chiedo scusa, per tutti quelli che sono disabili. Io,
grazie a Dio, non lo sono, ma in alcuni momenti, per come si manifesta
il mio essere, è come se lo fossi.
I
nnanzitutto, prima che mi metta a scrivere e a elaborare l’argomento
‘autonomia’, chiedo scusa, per tutti quelli che sono disabili. Io,
grazie a Dio, non lo sono, ma in alcuni momenti, per come si manifesta
il mio essere, è come se lo fossi.
Essere autonomo ti porta a farti sentire forte, indipendente, utile per
il prossimo, e che puoi affrontare la vita con grande dignità… Io mi
sento utile per me stessa e per chi mi è a fianco (solo mio marito), ma
alcune volte, secondo me, è come se fossi una disabile, con questa
fragilità molto accentuata che mi ritrovo sulla mia pelle.
Quando ero piccola ero molto debole fisicamente, ma avendo una forza di
volontà molto elevata spostavo anche le montagne. Ho vissuto molto il
complesso di inferiorità dentro di me, confrontandomi con altri anche
nelle cose più semplici, ad esempio nel correre, saltellare, in
qualsiasi contesto di gioco. E non facevo altro che fermarmi presto,
perché il mio fisico non ce la faceva. Accusavo subito capogiri e
difficoltà respiratoria e di conseguenza i miei amichetti mi
deridevano. Solo la mia mamma se ne preoccupava. Ricordo che, quando
eravamo piccoli tutti i miei fratelli e le mie sorelle, qualche volta
io mi affiancavo a loro per giocare, solo per fare un girotondo, un
saltello nel nostro cortile, lei si accorgeva presto che io accusavo
malessere e non insistevo, e così lei mi chiamava con dolcezza, mi
prendeva per mano, mi accarezzava e mi diceva. “Lucia, vieni con me,
lasciali perdere, che loro sono molto bricconcelli”.
Comunque col tempo mi ha retto la forza interiore e secondo alcuni
medici è stato quello il mio errore, perché quando accusavo capogiri,
era il primo campanello d’allarme e mi dovevo fermare. Ma scusate,
quando si è su un posto di lavoro come si fa a fermarsi? Lo puoi fare
una volta o due… Ma la mia psicologa quando avevo ventun anni mi disse:
“Lucia, con la fragilità che hai, è come se avessi una gamba
spezzata…”. Ma io le risposi: “E io non ce l’ho, e vado avanti, la mia
gamba è intatta”. E lei: “Se continui così, diventerai irrecuperabile a
livello psichiatrico”. Io avevo bisogno di lavorare, dovevo vivere… e
così dopo vari anni di ricoveri neurologici e psichiatrici, osservavo i
disabili e dentro di me mi dicevo: “Apparentemente sembro autonoma, ma
con i sintomi che accuso a volte mi sento come loro”. Non potersi
organizzare, fare un programma oggi per domani, non poter fare un
lavoro proprio che piace… Dopo aver lavorato in una casa di riposo per
anziani non autonomi e con disagi mentali, dopo essermi qualificata con
un corso - studiavo, e in più lavoravo - ero l’essere più felice, più
realizzato. E poi era un lavoro che mi soddisfaceva molto, mi sentivo
utile per quegli ammalati. Perciò la mia fragilità la sconfiggevo
curando, amando, correndo di qua e di là da un bisognoso all’altro, e
quando sentivo che la mia mente cominciava a farmi vedere tutto buio,
prendevo il mio ape-car (una volta io guidavo l’ape-car, non potendo
permettermi di prendere la patente) e via di seguito…
Per me il mio ape-car era la vita, infatti parlavo con il mio ape-car,
gli dicevo: “Io con te mi integro, sono più autonoma, mi proteggi dalle
intemperie visto che accuso varie malattie, mi porti a lavorare, mi
aiuti quando sono carica di spese varie…”. E potevo andare a correre
con il mio ape-car, come mi pareva e piaceva, quando lo prendevo, per
recarmi a lavorare, oppure di notte, lo guidavo e correvo da un ponte
all’altro del fiume, per scaricare ansie, fobie e brutte notizie, e gli
dicevo, al mio ape: “Tu sei la mia vita!”. Infatti il nome del mio
ape-car… che poi lo avevo ‘cassonato’ per quando facevo la spesa e
caricavo delle persone dentro, se no mi vedevano i vigili e mi facevano
la multa, e se pioveva non si bagnavano, la spesa e le persone che
caricavo… sembrava più un carro di carnevale, infatti per Bologna non
passava inosservato, ma io me ne fregavo delle critiche, bastava il
fatto che, trasformato in un furgoncino, mi faceva sentire utile,
indipendente e vitale… il nome del mio motocarro... io lo chiamavo
“Vita mia”. Quando non stavo bene gli davo delle pacche sul manubrio e
gli dicevo: “Vita mia, portami dove vuoi, che ho bisogno di carica!”.
E così se era notte mi giravo tutta Bologna, se invece era giorno,
senza di lui, il mio motocarro, mi recavo fra i prati, mi abbracciavo
un albero, guardavo su, verso il cielo tutto pieno di luce immensa e mi
riempivo di gioia immaginando che io e il nostro caro Gesù volavamo per
il cielo e fra le nuvole, io e Gesù, e tutte le schiere celesti. Mi si
illuminava di nuovo la mente e ritornavo alla carica della solita
routine, lavoro, casa, ambulatori eccetera. E dopo, che cosa è
successo? Quando ero piccola mi reggeva la forza interiore, poi da più
grande si sono bilanciate, con alti e bassi, la forza interiore e
quella fisica. A forza di tirare, come mi è stato detto, a un certo
punto ho perso tutto. La forza, sia interiore che fisica, la mia
autonomia, la mia vita (ape-car), la dignità, la vitalità, la voglia di
vivere, camminare, apprezzare la natura… Niente: Lucia non ha capito
più niente, perdendo tutto di sé, compreso il lavoro, acquistando solo
un pugno di mosche morte in mano, sì, solo un pugno di mosche morte in
mano, infatti con questo senso di vuoto e di fallimento devo seguire i
segnali delle mie energie. Mi sento morta interiormente, sì, per le
strade, nel mio balcone, sembro autonoma, ma solo io e le mura di casa
mia sappiamo la fatica che faccio per stare in piedi. Lo psichiatra me
lo diceva: “Lucia, fermati, stai tirando la corda” e io rispondevo
.”Dotto’ - alla meridionale… terrona come sono e contenta di esserlo -
a me mi può passare sopra anche un tir, ma non mi fermo, perché sono
forte”, anche perché, con la mia forza di volontà, si sono fermate
alcune malattie organiche a rischio che ho. Ma il mio psichiatra e
altre persone che conoscevo si stavano accorgendo che cominciavo a
‘sbacchettare’ e mi davano consigli sui vari problemi che confidavo e
che non mi va di esporre in questo contesto.
Comunque, in breve - che già l’ho fatta lunga - beato chi ha
l’autonomia reale, non solo apparente!
Apprezzatela, non sciupatela, e dite grazie e grazie a Gesù, come
faccio io quando riesco ad andare a far la spesa e a riordinare la
casa. Grazie, Gesù, di questa poca autonomia che mi hai donato.
Per quanto riguarda l’ascolto e i consigli che mi davano i medici, di
non tirare la corda perché non sono del tutto autonoma… sarebbe stato
giusto che altri facessero qualcosa per me. Io dicevo: “Non c’è
problema, sono forte come un tir”, e quando anni fa ho avuto il secondo
crollo psicofisico totale, una certa persona mi ha detto: “Ecco, Lucia,
il tir ti è passato sopra”. Rimasi male, ma io ci ho provato, ho
investito e messo in opera tutte le mie risorse, non me ne pento. Però,
devo essere sincera, non so se tornando indietro lo rifarei, perché
perdere del tutto la dignità, e fare la matta per strada, ed essere
commiserata, oppure sentirsi dire che lo fai apposta per essere al
centro dell’attenzione, il mio ego non è contento.
|
|
|
UNA STRADA VERSO LA STESSA CASA
 Costanza Tuor
Costanza Tuor
 Aquel tempo con le mie due sorelle
frequentavamo la stessa scuola elementare. Io ero in quinta, mia
sorella mezzana in quarta e la più piccolina in prima elementare. Non
ricordo il motivo, ma la mia mamma decise che dovevamo tornare a casa
da sole prendendo l’autobus. E così facemmo disordinatamente insieme,
ciascuna al suo ritmo.
Aquel tempo con le mie due sorelle
frequentavamo la stessa scuola elementare. Io ero in quinta, mia
sorella mezzana in quarta e la più piccolina in prima elementare. Non
ricordo il motivo, ma la mia mamma decise che dovevamo tornare a casa
da sole prendendo l’autobus. E così facemmo disordinatamente insieme,
ciascuna al suo ritmo.
Nel varco tracciato nella mia memoria di bambina che ritorna a casa
accompagnando le sue sorelle, esplode oggi soffusamente l’incanto di
comprendere che coloro che mi hanno amato a quel tempo mi hanno
lasciato lo spazio per diventare autonoma e magari, come dice qualcuno,
si nascondevano dietro una colonna per verificare da lontano/vicino che
il mio percorso fosse allegro e lieve.
È meraviglioso accorgersi come io e le mie sorelle, che abbiamo seguito
percorsi molto diversi una dall’altra nella vita, camminiamo ancora
insieme come su quei marciapiedi di una volta, per mano, ciascuna con
la sua propria andatura ma sempre verso la stessa casa.
|
|
|
NON CI CAPISCO PIÙ NULLA
 Anonimo
Anonimo

 uando
due teneri piccioni stanno covando, a un tratto l’ovetto si schiude e
ne esce il pulcino: lo riempiono d’amore e, quando comincia ad avere
una certa età, gli insegnano a volare, a procurarsi il cibo e a sapere
chi sono i suoi nemici… Che tenerezza! Poi però, quando sarà adulto, il
loro piccolo lascerà il suo nido e i genitori, per diventare autonomo e
crearsi una famiglia. Generalmente, nel mondo animale, quello
selvatico, si conduce questo genere di vita… uando
due teneri piccioni stanno covando, a un tratto l’ovetto si schiude e
ne esce il pulcino: lo riempiono d’amore e, quando comincia ad avere
una certa età, gli insegnano a volare, a procurarsi il cibo e a sapere
chi sono i suoi nemici… Che tenerezza! Poi però, quando sarà adulto, il
loro piccolo lascerà il suo nido e i genitori, per diventare autonomo e
crearsi una famiglia. Generalmente, nel mondo animale, quello
selvatico, si conduce questo genere di vita…
Non è così, ahimè, nel mondo umano e più precisamente, e recentemente,
nel mondo dei ‘bamboccioni mammoni’ (giovani che non ce la fanno coi
soldi e devono sottostare ai genitori), per colpa di un’inetta politica
e della grave crisi economica… e l’autonomia intorno all’età adulta se
ne va a quel paese. Addirittura, con questa scusa, i genitori pensano
che i loro figli siano ancora dei bambini e non li lasciano
‘adultizzare’ completamente… E la cosa si aggrava quando il figlio
desidererebbe molta più privacy e libertà di movimento, senza
l’‘appiccicosità’ dei genitori che, per ogni movimento e/o parola che
si dice, hanno sempre qualcosa da ridire e motivi per litigare.Una cosa
che poi nessuno t’insegna, per quanto riguarda il discorso
dell’autonomia, è come gestirti tra tasse, pagamenti, posta,
burocrazia, eccetera. Non lo fa la scuola, non lo fanno i genitori e
nemmeno la TV. Ma che diamine di società è questa, una società civile?
Siamo davvero civilizzati come vogliono farci credere? Per me
assolutamente no! La diffusione sempre maggiore di internet non
corrisponde a spazi né strumenti per facilitarne l’accesso al pubblico
e ciò limita l’autonomia necessaria a informarsi e a raggiungere
documentazioni di cui solo internet ha ormai il pieno controllo. Anche
il semplice fatto di non avere un pc, che ormai è richiesto ovunque, è
un limite nella ricerca di un lavoro. Del resto l’alfabetizzazione
informatica in Italia è allo sbando, mentre il paese dovrebbe essere
una grande eccellenza vista la rapida crescita della tecnologia.
Francamente non ci sto più capendo un tubo!!!
|
|
|
BUON COMPLEANNO MIO TOPO!!!
 Stefy
Stefy
 Giovedì è il compleanno di mio figlio.
Compie ventidue anni. Sono passati così in fretta da quel giorno in cui
quell'esserino ha deciso di uscire dal mio corpo, seguendo il suo
istinto naturale di autonomia. La sua prima reazione non è stato
piangere, ma fare due starnuti che sembravano quelli di un gatto. Forse
aveva già compreso che sulle scelte che si fanno in autonomia non
bisogna piangerci sopra più di tanto. Nel corso degli anni io e suo
padre abbiamo cercato di insegnargli ad essere autonomo in ciò che fa e
ciò che pensa e a gestire in modo ponderato questa autonomia che ora,
che è grande e grosso, ha. Ascolta sempre le nostre parole, ma le
prende come consigli, perché alla fine la decisione è sempre quello che
pensa lui.
Giovedì è il compleanno di mio figlio.
Compie ventidue anni. Sono passati così in fretta da quel giorno in cui
quell'esserino ha deciso di uscire dal mio corpo, seguendo il suo
istinto naturale di autonomia. La sua prima reazione non è stato
piangere, ma fare due starnuti che sembravano quelli di un gatto. Forse
aveva già compreso che sulle scelte che si fanno in autonomia non
bisogna piangerci sopra più di tanto. Nel corso degli anni io e suo
padre abbiamo cercato di insegnargli ad essere autonomo in ciò che fa e
ciò che pensa e a gestire in modo ponderato questa autonomia che ora,
che è grande e grosso, ha. Ascolta sempre le nostre parole, ma le
prende come consigli, perché alla fine la decisione è sempre quello che
pensa lui.
Ora si alza, va al lavoro, va in palestra ed esce con gli amici senza
il bisogno di dipendere da me e suo padre. Penso che siamo riusciti nel
nostro intento, ad insegnargli ad essere autonomo senza perdere di
vista il valore per le persone che lo circondano. Io, per quel che mi
può permettere la mia autonomia finanziaria, gli regalo una bella cena
con gli spaghetti allo scoglio, che è una delle poche cose per cui il
mio topo dipende ancora da me.
|
|
|
C’ENTRA CON L’AUTONOMIA
 Edoardo Bellanca
Edoardo Bellanca
 Viveva una persona, che non aveva
particolari problemi ma, forse perché era sola, si sentiva spesso
triste, angosciata. Decise di andare dal ‘saggio’ del paese, gli spiegò
del suo ‘malessere’, per avere un consiglio. Questi lo ascoltò
benevolmente, poi gli chiese: “Hai delle galline?” “Sì - rispose
prontamente - ne ho una decina”. “E dove le tieni?” “Beh, naturalmente
nel pollaio!” “Allora, prendile tutte e mettile in casa con te, poi tra
un mese ritorna”. Dopo un mese, quello ritorna. “E allora, come va?”
gli chiese il saggio. “Uno schifo tremendo, le piume, il letame
dappertutto” “Bene”, rispose quello. Poi gli chiese “Hai il maiale?”
“Sì” “E dove lo tieni?” “Naturalmente nel porcile” “Bene, prendilo e
mettilo in casa, poi ritorna tra un mese”. Dopo un mese, quello
ritorna. “E allora, come va?” gli chiese il saggio. “Uno schifo ancora
peggiore, un fetore insopportabile, un caos indescrivibile” “Bene”,
rispose quello. Poi gli chiese “Hai una vacca?” “Sì” rispose quello, un
po’ atterrito. “E dove la tieni?” “Naturalmente nella stalla” “Bene,
prendila e metti anche lei in casa, poi ritorna tra un mese”. Dopo un
mese quello, sfiduciato, nauseato, ritornò malvolentieri dal saggio. Il
saggio gli disse: “Adesso rimetti le galline nel pollaio, il maiale nel
porcile e la vacca nella stalla”. E quello così fece, e fu tutto
contento … e per un bel po’ di tempo non si sentì più triste e né
angosciato. Morale della storia: L’autonomia è apprezzata solo quando
la si perde.
Viveva una persona, che non aveva
particolari problemi ma, forse perché era sola, si sentiva spesso
triste, angosciata. Decise di andare dal ‘saggio’ del paese, gli spiegò
del suo ‘malessere’, per avere un consiglio. Questi lo ascoltò
benevolmente, poi gli chiese: “Hai delle galline?” “Sì - rispose
prontamente - ne ho una decina”. “E dove le tieni?” “Beh, naturalmente
nel pollaio!” “Allora, prendile tutte e mettile in casa con te, poi tra
un mese ritorna”. Dopo un mese, quello ritorna. “E allora, come va?”
gli chiese il saggio. “Uno schifo tremendo, le piume, il letame
dappertutto” “Bene”, rispose quello. Poi gli chiese “Hai il maiale?”
“Sì” “E dove lo tieni?” “Naturalmente nel porcile” “Bene, prendilo e
mettilo in casa, poi ritorna tra un mese”. Dopo un mese, quello
ritorna. “E allora, come va?” gli chiese il saggio. “Uno schifo ancora
peggiore, un fetore insopportabile, un caos indescrivibile” “Bene”,
rispose quello. Poi gli chiese “Hai una vacca?” “Sì” rispose quello, un
po’ atterrito. “E dove la tieni?” “Naturalmente nella stalla” “Bene,
prendila e metti anche lei in casa, poi ritorna tra un mese”. Dopo un
mese quello, sfiduciato, nauseato, ritornò malvolentieri dal saggio. Il
saggio gli disse: “Adesso rimetti le galline nel pollaio, il maiale nel
porcile e la vacca nella stalla”. E quello così fece, e fu tutto
contento … e per un bel po’ di tempo non si sentì più triste e né
angosciato. Morale della storia: L’autonomia è apprezzata solo quando
la si perde.
|
|
|
FIDUCIA IN SÉ STESSI E FORZA DI VOLONTÀ
 Tonina Lai (Centro Volontari della Sofferenza)
Tonina Lai (Centro Volontari della Sofferenza)
 Credo che la prima forma di autonomia
sia tentare di costruire una certa fiducia in sé stessi. Presento un
esempio pratico: mio marito era disabile, con una forma di distrofia
muscolare: malattia che progressivamente toglie ogni capacità di
movimento, lasciando intatta la parte intellettiva. Aveva un grande
coraggio per affrontare le difficoltà con la sua forza di volontà,
cercava e studiava ogni mezzo per facilitare il vivere quotidiano. Gli
servivano le mie braccia, ma era lui che indicava il modo più semplice
per usarle. Gli piaceva la tecnologia, perciò cercava tutti gli ausili
possibili. È stato uno dei primi a usare la carrozzina elettrica e a
far attrezzare un pullmino (parlo degli anni ’80!). Mi ha insegnato che
se non mi fermo a ciò che non posso avere, ma cerco di servirmi di
tante opportunità, riesco ad attuare la mia autonomia, soprattutto
rifiutando i pregiudizi che potrebbero frenare la mia volontà di
farcela. Sono autonoma se accetto la collaborazione delle persone e
delle cose, ma non mi lascio condizionare da esse. Personalmente mi
aiuta il pensiero che Nostro Signore ha guardato oltre i nostri limiti,
dandoci la capacità di servirci di tanti doni che ha messo a nostra
disposizione. Questa base di fede non mi toglie gli scoraggiamenti
umani, ma mi dà la certezza che ho delle risorse come persona unica,
ricordata da un Dio Padre che mi ama come sono.
Credo che la prima forma di autonomia
sia tentare di costruire una certa fiducia in sé stessi. Presento un
esempio pratico: mio marito era disabile, con una forma di distrofia
muscolare: malattia che progressivamente toglie ogni capacità di
movimento, lasciando intatta la parte intellettiva. Aveva un grande
coraggio per affrontare le difficoltà con la sua forza di volontà,
cercava e studiava ogni mezzo per facilitare il vivere quotidiano. Gli
servivano le mie braccia, ma era lui che indicava il modo più semplice
per usarle. Gli piaceva la tecnologia, perciò cercava tutti gli ausili
possibili. È stato uno dei primi a usare la carrozzina elettrica e a
far attrezzare un pullmino (parlo degli anni ’80!). Mi ha insegnato che
se non mi fermo a ciò che non posso avere, ma cerco di servirmi di
tante opportunità, riesco ad attuare la mia autonomia, soprattutto
rifiutando i pregiudizi che potrebbero frenare la mia volontà di
farcela. Sono autonoma se accetto la collaborazione delle persone e
delle cose, ma non mi lascio condizionare da esse. Personalmente mi
aiuta il pensiero che Nostro Signore ha guardato oltre i nostri limiti,
dandoci la capacità di servirci di tanti doni che ha messo a nostra
disposizione. Questa base di fede non mi toglie gli scoraggiamenti
umani, ma mi dà la certezza che ho delle risorse come persona unica,
ricordata da un Dio Padre che mi ama come sono.
|
|
|
UN FIORE TRA LE MANI
 Patrizia Degli Esposti
Patrizia Degli Esposti
 Con il termine autonomia (dal greco
antico) si intende la possibilità per un soggetto di svolgere le
proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di terzi.
Essere autosufficiente, contare sulle proprie forze e capacità. Sembra
scontato riuscire a compiere le attività che quotidianamente
affrontiamo: dalle più banali quali grattarsi un orecchio o aprire o
chiudere un cassetto. Entrambi i miei genitori sono stati intrappolati
dalla perdita di autonomia. È un processo lento, ma inesorabile.
Piccoli segnali quali non riuscire a piegare un tovagliolo, chiudere
con fatica un rubinetto, dimenticare dove si è riposto un oggetto... È
difficile accettare che un genitore perda la propria autonomia e
dignità e, spesso involontariamente, sottovalutiamo questi
comportamenti per rimandare il problema che occorre affrontare. Ho
dovuto accettare questa realtà e renderla meno traumatica e dolorosa.
Ho pensato ad un fiore che, un petalo alla volta, si spoglia, piega il
gambo e si secca.
Con il termine autonomia (dal greco
antico) si intende la possibilità per un soggetto di svolgere le
proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di terzi.
Essere autosufficiente, contare sulle proprie forze e capacità. Sembra
scontato riuscire a compiere le attività che quotidianamente
affrontiamo: dalle più banali quali grattarsi un orecchio o aprire o
chiudere un cassetto. Entrambi i miei genitori sono stati intrappolati
dalla perdita di autonomia. È un processo lento, ma inesorabile.
Piccoli segnali quali non riuscire a piegare un tovagliolo, chiudere
con fatica un rubinetto, dimenticare dove si è riposto un oggetto... È
difficile accettare che un genitore perda la propria autonomia e
dignità e, spesso involontariamente, sottovalutiamo questi
comportamenti per rimandare il problema che occorre affrontare. Ho
dovuto accettare questa realtà e renderla meno traumatica e dolorosa.
Ho pensato ad un fiore che, un petalo alla volta, si spoglia, piega il
gambo e si secca.
Ora la mia mamma è diventata la mia bambina adulta. Prima di lei ho
avuto mio babbo che era il mio bambino adulto. Porre la posata nella
mano di mamma e lasciare che mangi da sola, non importa se si sporca o
sbrodola, pazienza, una carezza sul viso, il tovagliolo a pulire le
labbra e si ricomincia. Mantenere un contatto con piccoli gesti
quotidiani: lavarsi le mani, bere un bicchiere di acqua o di caffè
d'orzo. Gesti banali, ma fondamentali per la mamma per ripassare ogni
giorno quello che la mente tende a dimenticare. Gioco con la mamma, le
canto canzoni che invento al momento e cerchiamo le rime e se non le
viene in mente nulla le propongo degli aiutini e ridiamo, ci
abbracciamo e ci baciamo. E se non parliamo stiamo vicine, le massaggio
le gambe, le braccia, le mani, le spalle e glielo racconto: "Un bel
massaggio ai piedi, ti piace? Continuo?". E quando ‘capisce’ e vorrebbe
essere di nuovo autonoma e tornare a casa sua, l'abbraccio e le dico
che è una principessa e le principesse non fanno nulla, hanno chi le
aiuta a vestirsi, svestirsi, lavarsi, hanno chi fa da mangiare, hanno
la pettinatrice. Lei mi guarda, ci pensa un attimo e mi sorride, allora
aggiungo che ora è una principessa ma diventerà regina. Mamma sorride
di più e sembra serena e a volte mi accarezza il volto, mi tiene
strette le mani e mi bacia.
|
|
|
L’ARTICOLO 5 DELLA COSTITUZIONE
 Luca Pasini
Luca Pasini
 L’autonomia è per me un concetto ben
preciso: indica la possibilità di una o più persone di provvedere a sé
stesse con coscienza e indipendenza. È un dovere e un diritto. Il
lavoro per me sotto certi aspetti è fondamentale per essere autonomi,
tuttavia l’autonomia è un concetto ben più ampio. Senza parlar oltre
voglio citare ciò che a mio parere rende chiaro, meglio di ogni altra
cosa al mondo, ciò che sto dicendo, l’articolo 5 della costituzione
italiana: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
Ma l’autonomia ha, a mio parere, ragione di esistere solamente quando
non mina l’unità di uno stato, specialmente il nostro. Perché come,
dice l’articolo 5 della costituzione, che è un articolo fondamentale,
la Repubblica, è “una e indivisibile”. Capirete quindi che sono folli
vaneggiamenti quelli che certi tizi fanno quando proclamano
l’indipendenza di una fantomatica Padania, e non hanno ragione
d’esistere certi stati quali San Marino e il Vaticano, specialmente
quest’ultimo.
L’autonomia è per me un concetto ben
preciso: indica la possibilità di una o più persone di provvedere a sé
stesse con coscienza e indipendenza. È un dovere e un diritto. Il
lavoro per me sotto certi aspetti è fondamentale per essere autonomi,
tuttavia l’autonomia è un concetto ben più ampio. Senza parlar oltre
voglio citare ciò che a mio parere rende chiaro, meglio di ogni altra
cosa al mondo, ciò che sto dicendo, l’articolo 5 della costituzione
italiana: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
Ma l’autonomia ha, a mio parere, ragione di esistere solamente quando
non mina l’unità di uno stato, specialmente il nostro. Perché come,
dice l’articolo 5 della costituzione, che è un articolo fondamentale,
la Repubblica, è “una e indivisibile”. Capirete quindi che sono folli
vaneggiamenti quelli che certi tizi fanno quando proclamano
l’indipendenza di una fantomatica Padania, e non hanno ragione
d’esistere certi stati quali San Marino e il Vaticano, specialmente
quest’ultimo.
Quindi concludo affermando che a mio modesto parere l’autonomia deve
esserci, ma senza minare l’unità e l’uguaglianza, che sempre devono
unire le persone.
|
|
|


Il movimento per la recovery
 Antonio Maone psichiatra A.S.L. Roma 1
Antonio Maone psichiatra A.S.L. Roma 1
R
ecovery ha nella lingua inglese, e in particolare nel linguaggio
medico, un significato che può essere reso in italiano con il termine
‘guarigione’. Tuttavia l’accezione inglese è meno stretta, nel senso
che può includere stati di sostanziale recupero di una condizione di
benessere che non implichi necessariamente la guarigione definitiva
della malattia (condizione, questa, più propriamente tradotta in
inglese dal termine cure). Questa relativa indeterminatezza del
concetto può essere fonte di ambiguità terminologiche quando è
utilizzato nelle malattie croniche, nel cui decorso si possono ottenere
(grazie alle cure, agli stili di vita o al corso naturale del disturbo)
condizioni di remissione dei sintomi e di parziale o temporaneo
miglioramento, anche se la malattia non sia stata del tutto debellata.
Nel campo della psichiatria, in particolare, i rischi di tale ambiguità
possono risultare ulteriormente accentuati, se si pensa alla carenza di
conoscenze eziopatogenetiche, all’arbitrarietà dei criteri diagnostici,
alla multidimensionalità dell’esito, ai diversi ‘valutatori’ in gioco
(le diverse figure professionali coinvolte, il paziente stesso, i
familiari eccetera). Negli ultimi vent’anni, poi, il concetto è stato
oggetto di un ulteriore ampliamento semantico, finendo per indicare
qualcosa di natura significativamente diversa dalla mera guarigione
clinica.
Si può intanto dire, in estrema sintesi, che in psichiatria abbiamo
attualmente a che fare con due diverse accezioni del concetto di recovery.
La prima è radicata storicamente nella tradizione medica e allude
sostanzialmente all’esito clinico, valutato in base a quanto vengano
soddisfatti criteri di guarigione operazionalmente definiti: remissione
dei sintomi, ripristino del funzionamento personale e sociale eccetera.
La seconda e più recente accezione riguarda invece, fondamentalmente,
la soggettività del paziente e la sua esperienza vissuta della malattia
mentale; più che riferirsi all’esito clinico, essa riflette un processo
autenticamente personale, avviato a un certo punto del decorso e
caratterizzato da un impegno attivo del paziente nel tentativo di
ripristinare un certo grado di controllo sulla propria vita e di
recuperare potenzialità e aspettative di realizzazione di sé che la
malattia, la disabilità e lo stigma sociale avevano compromesso in modo
apparentemente irreversibile. Essere ‘in recovery’, in questo
senso, non implica primariamente una riduzione dei sintomi o dei
deficit, né il ritorno a un preesistente stato di salute; richiede
piuttosto che il disturbo mentale venga considerato come solo uno degli
aspetti della persona nella sua totalità.
Questa diversa visione ha ottenuto nel giro di un ventennio, anche
fuori dai paesi anglofoni in cui ha preso avvio, una notevole
espansione e un diffuso consenso, che si manifestano nella
moltiplicazione di pubblicazioni, ricerche e incontri scientifici,
nonché nella promulgazione di policy
governative in vari paesi, finalizzate alla trasformazione dei servizi
di psichiatria di comunità e all’adozione di nuove pratiche recovery-oriented.
In questo contributo tenterò di far luce sulle origini, le
caratteristiche e le prospettive di ciò che oggi si definisce e si
riconosce come recovery movement.
Ma, prima di affrontare il tema specifico, mi sembra opportuno proporre
una sintetica revisione delle evidenze disponibili circa il significato
di guarigione dei disturbi mentali gravi, in particolare della
schizofrenia, tentando di chiarirne le ambiguità.
Molto più che in altre branche della medicina, in psichiatria la
valutazione del decorso e dell’esito dei disturbi si scontra con
molteplici difficoltà metodologiche. La misurazione oggettiva del
miglioramento o della guarigione da un disturbo mentale è resa incerta
innanzitutto dall’impossibilità di utilizzare marker biologici e quindi
dal doversi affidare quasi esclusivamente all’osservazione e al
giudizio dei clinici. Inoltre, perché tale misurazione sia
significativa, riproducibile e comparabile, è necessario che il quadro
osservato sia ascrivibile con certezza a una data categoria
diagnostica; ma la validità delle stesse definizioni e classificazioni
diagnostiche in psichiatria è messa in questione dalla mancanza di una
corrispondenza dimostrata fra i sintomi osservabili e una precisa e
individuabile lesione o alterazione del funzionamento del sistema
nervoso. Altri problemi derivano dal fatto che, affinché la valutazione
sia completa e affidabile, è necessario tener conto non solo dei segni
e dei sintomi, ma anche di altre dimensioni dell’esito, quali il
funzionamento personale e sociale, il benessere soggettivo eccetera; in
altri termini, non è così semplice stabilire in modo definitivo e
condiviso cosa si intenda per ‘buon esito’.
Tuttavia, malgrado queste e altre limitazioni che saranno riprese più
avanti, la ricerca ha prodotto risultati indicativi, soprattutto a
partire dagli anni Settanta del secolo scorso.
Due sono sostanzialmente le tipologie utilizzate nella ricerca sul
decorso e l’esito dei disturbi schizofrenici, che costituisce uno dei
campi più indagati in psichiatria. Dai classici studi naturalistici (un
centinaio) che hanno riguardato ampie coorti di pazienti per follow-up
di lunga durata, si distinguono le migliaia di studi randomizzati e
controllati che più recentemente hanno dominato il campo della ricerca.
Questi ultimi sono per lo più di breve durata, spesso solo di alcune
settimane e di rado superiori a un anno, e sono per lo più finalizzati
alla valutazione della risposta ai trattamenti farmacologici. I primi
rappresentano invece, essenzialmente, una descrizione del corso
naturale del disturbo, piuttosto che la risposta a uno specifico
intervento terapeutico. Considerati nel loro complesso, i risultati di
questi studi hanno dimostrato un esito sorprendentemente più favorevole
di quanto la concezione classica del disturbo, dominante per quasi
tutto il ventesimo secolo, potesse far ritenere. Se si considerano, in
particolare, gli studi a lungo termine con una durata media dei
follow-up di circa vent'anni e che hanno riguardato migliaia di
pazienti in varie parti del mondo, il tasso di recovery
completa è fra il 20 e il 30%, mentre, in un analoga percentuale, il
decorso appare chiaramente sfavorevole. Ma se si analizzano i dati per
determinare il numero di casi che a distanza di molti anni dal primo
ricovero non hanno più sintomi, non assumono farmaci e che hanno al
massimo una limitazione in una delle aree del funzionamento (lavoro,
vita indipendente e relazioni sociali), si ottengono percentuali che
vanno dal 53 al 68%.
L’insieme di queste evidenze è tuttavia caratterizzato da un’estrema eterogeneità degli esiti.
Oltre all’eterogeneità dei decorsi per come emerge dal confronto fra i
singoli casi, importanti differenze sono state osservate confrontando
gruppi di casi raccolti in base a criteri geografici e socio-culturali.
Una delle evidenze più sorprendenti prodotte dall’International Pilot Study of Schizophrenia
dell’OMS è l’esito significativamente più favorevole della schizofrenia
nei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi industrializzati. È
forte l’impatto che questa evidenza ha prodotto nel far emergere, anche
se in modo non chiaramente e univocamente interpretabile, l’influenza
del contesto sociale ed economico sul decorso e l’esito della
schizofrenia.
Oltre alla variabilità nel confronto fra i singoli casi o fra gruppi di
casi, occorre tener conto anche di quella interna a ciascun caso,
quando si considerino, cioè, più in dettaglio, le differenti dimensioni
che vanno poi a costituire, insieme, la misura globale dell’esito. Una
volta accertata, così come è stato possibile attraverso i vari studi di
esito e malgrado l’eterogeneità sopra descritta, una certa entità di
evoluzioni ‘favorevoli’, si pone il problema di chiarire meglio di
quali esiti si tratti: clinici (sintomi psicotici positivi e negativi,
altri sintomi), neuropsicologici (funzioni cognitive), funzionali
(lavoro, indipendenza abitativa, relazioni sociali), esperienziali
(benessere soggettivo, qualità della vita). Ci si deve anche chiedere
quanto tali esiti restino stabili nel tempo e tener conto del divario
nella affidabilità delle misurazioni fra le diverse dimensioni: da una
parte, per esempio, la replicabilità e la precisione della valutazione
dei deficit cognitivi, dall’altra la potenziale elusività dei criteri
di valutazione del benessere soggettivo o della vita sociale.
In ogni caso, considerate le controversie e le incertezze che pervadono
tuttora questo campo, ci si può chiedere se abbia senso, nel tentativo
di definire i criteri di guarigione, proporre una visione gerarchica
‘piramidale’ che consideri prioritaria una dimensione dell’esito
rispetto ad altre.
Nei paragrafi precedenti abbiamo accennato ad altri due fattori di
problematicità che caratterizzano gli studi sull’esito della
schizofrenia. Il primo riguarda i criteri utilizzati nella selezione
dei pazienti di cui si intende valutare il decorso o la risposta a un
trattamento. Per ottenere la massima attendibilità attraverso gli studi
randomizzati e controllati, che rappresentano il gold standard della
ricerca, è necessario selezionare accuratamente i campioni, affinché i
pazienti oggetto degli studi siano quanto più possibile omogenei e
rispondenti strettamente ai criteri diagnostici utilizzati. Ciò però
comporta l’esclusione dagli studi dei molti pazienti del cosiddetto
‘mondo reale’, per cui è stato proposto l’utilizzo di studi pragmatici
che tengano conto della realtà della pratica clinica quotidiana, ma a
scapito del rigore metodologico. In altri termini, cercare di ottenere
negli studi la validità interna comporta che i risultati non possono
poi essere facilmente generalizzati al mondo reale; mentre, se
cerchiamo di ricorrere ad una più alta rappresentatività - attraverso
studi nel mondo reale, quindi con una scarsa selezione dei campioni -
perdiamo il rigore metodologico .
Per reclutare campioni omogenei sotto il profilo diagnostico sono stati
adottati nel secolo scorso criteri differenti, in relazione alla
demarcazione, ora più ora meno stretta, dei confini diagnostici della
schizofrenia. Agli stretti criteri tradizionali, fondati sul decorso
infausto e sull’esito in demenza (già praticamente incorporati nella
diagnosi di dementia praecox), sono succeduti quelli più ampi di Bleuler e Schneider, focalizzati sulla sintomatologia piuttosto che sul decorso.
Le diverse dimensioni dell’esito che abbiamo analizzato, si pongono quindi su un ideale continuum
che va da quelle ‘oggettivamente’ misurabili (i sintomi e, con minore
affidabilità, il funzionamento) a quelle che attengono alla sfera
soggettiva e che sono oggetto di crescente interesse: soddisfazione,
benessere, qualità della vita auto-percepita. L’interesse verso queste
ultime non riflette solo l’intenzione dei ricercatori di ampliare il
campo dell’indagine alle dimensioni più ‘soft’, ma rappresenta anche il
segno della tendenza a un maggiore coinvolgimento del paziente come
agente attivo nel trattamento.
Un contributo importante in questo campo lo offre uno studio
osservazionale recente che ha tentato di confrontare il giudizio di
remissione ottenuto da valutatori indipendenti, con quello espresso
dagli psichiatri curanti, dagli stessi utenti e dai loro familiari.
Sono emerse differenze molto significative e clinicamente rilevanti: a
fronte di una concordanza elevata fra la valutazione standardizzata e
quella espressa dagli psichiatri (80%), la concordanza con
l’autovalutazione fornita dai pazienti era solo del 43% e con quella
dei familiari del 52%. Complessivamente, il giudizio di remissione
espresso da psichiatri, familiari e pazienti è risultato sovrapponibile
solo nel 18% dei casi. Il fattore che sembra aver maggiormente
influenzato la valutazione dei pazienti è il benessere soggettivo,
mentre per gli psichiatri è la minore gravità dei sintomi e per i
familiari una combinazione di entrambi i fattori. Queste evidenze hanno
permesso agli autori di concludere che le valutazioni di remissione
standardizzate “giocano un ruolo solo secondario per i pazienti e i
familiari” e che una più attenta considerazione dei loro punti di vista
dovrebbe essere sempre integrata al giudizio meramente clinico,
indirizzando le decisioni sui trattamenti in un modo più ampio e
condiviso.
Abbiamo visto, nel tentativo di comporre il puzzle delle definizioni e
della valutazione dei processi di guarigione della schizofrenia, come
nel corso delle ultime decadi sia stata data un’enfasi sempre maggiore
alle dimensioni funzionali dell’esito, nonché, più recentemente, alle
dimensioni soggettive ritenute ancor più significative soprattutto dai
pazienti e dai familiari.
Questo ampliamento dell’orizzonte sembra riconducibile a un insieme di
processi che si sono dipanati lungo la seconda metà del secolo scorso e
che hanno peraltro costituito, spesso interagendo o sovrapponendosi, il
terreno da cui la ‘nuova’ accezione del concetto di recovery,
di cui si parlerà più avanti, ha tratto legittimità e consistenza, fino
a dar luogo a ciò che essa attualmente rappresenta nell’ambito della
salute mentale. Ci sembra pertanto utile, a questo punto, accennare
brevemente alle tendenze trasformative più rilevanti e i cui effetti
sono rintracciabili nello scenario attuale.
In questo ampio arco temporale che copre più di mezzo secolo, i
concetti di salute, malattia e disabilità sono stati oggetto di
profonde revisioni e ri-concettualizzazioni che hanno prodotto riflessi
importanti anche nel campo dell’assistenza psichiatrica.
Non possiamo qui richiamare sistematicamente tutte le componenti di
questo fenomeno complesso, ma alcuni aspetti rilevanti vanno pur
sinteticamente ricordati. Può essere di aiuto, in questo senso,
utilizzare come filo conduttore le posizioni espresse dall’OMS nel
corso delle ultime decadi, che si può assumere riflettano il clima
culturale e le istanze trasformative che hanno prodotto i mutamenti a
cui si è accennato.
Su un piano generale si può intanto ricordare il progressivo
spostamento del focus verso una concezione positiva della salute,
intesa come “condizione di pieno benessere fisico, psichico e sociale”,
piuttosto che mera assenza di malattia. L’OMS ha più volte ribadito
questo orientamento, già presente nella sua costituzione.
Contemporaneamente, le implicazioni sociali delle malattie croniche e
della disabilità sono divenute oggetto di crescente interesse e
approfondimento in ambito di salute pubblica, anche per effetto
dell’incremento della prevalenza di queste condizioni nelle
popolazioni; di conseguenza, anche le complesse relazioni fra malattia
e disabilità sono state sottoposte a decisive revisioni. Ciò ha
contribuito, fra l’altro, allo sviluppo del modello dell’OMS che ha
ridefinito le conseguenze delle malattie croniche e che ha
rappresentato il riconoscimento esplicito del fatto che tali
conseguenze possono estendersi dalla sfera medica a quella sociale. In
particolare, la distinzione tra malattia, menomazione, disabilità e
handicap, proposta dall’OMS nel 1980, ha contribuito, insieme
all’influenza del paradigma bio-psico-sociale, a far delineare,
nell’ambito della psichiatria, la prospettiva di un campo autonomo
rispetto alla clinica. Sulla base della distinzione fra la disabilità,
derivante dalla malattia, e l’handicap, risultante dall’interazione tra
il soggetto malato e il contesto sociale, si è andato delineando
l’oggetto di una nuova disciplina, la riabilitazione psichiatrica. Da
un insieme di pratiche dettate dal buon senso e da uno spirito
umanitario, spesso applicate in contesti istituzionali comunque
segreganti, la riabilitazione psichiatrica si è andata evolvendo sia in
senso tecnologico, coprendo un dominio distinto da quello della terapia
in senso stretto, col suo ambito d’intervento, le sue tecniche
formalizzate, i suoi statuti, le sue figure professionali; sia in senso
strategico, come un processo che deve fornire agli individui che
abbiano una disabilità o un handicap dovuto a una malattia mentale
tutte le opportunità per raggiungere un livello ottimale di
funzionamento indipendente nella società. Quest’ultimo passaggio, che
può essere tradotto in termini di restituzione di potere all’utente, è
stato poi esplicitato dall’OMS con il Mental Action Plan del 2005 per l’Europa, in cui è sottolineato che la carenza di empowerment
è di ostacolo al trattamento e alla riabilitazione. Nella stessa
direzione si sono orientate le posizioni dell’OMS relative al concetto
di ‘responsività’ (responsiveness), che riassume la capacità di
un servizio di rispondere agli aspetti etici e non clinici
dell’interazione fra il paziente e il sistema sanitario: da un lato il
rispetto per la dignità, l’autonomia, la riservatezza; dall’altro la
garanzia della pronta accessibilità, di un adeguato comfort ambientale
e della possibilità di poter esprimere il proprio punto di vista e le
proprie preferenze. La responsività è riconosciuta come un obiettivo
fondamentale dei servizi sanitari, al di là della mera appropriatezza
degli interventi specialistici, sulla base della valorizzazione dei
fattori psicosociali, culturali e ambientali come fondamentali
determinanti di salute. In continuità con questa posizione è il
supporto dell’OMS all’approccio centrato sulla persona (people-centred health care),
considerato come uno dei sei attributi che definiscono la qualità
dell’assistenza sanitaria. Si tende così a superare la vecchia
tradizione del paternalismo medico, ma anche la ‘modernità’
rappresentata dal predominio tecnologico e burocratico in salute
pubblica e nel rapporto medico-paziente. Se focalizziamo ora
l’attenzione all’estrema eterogeneità dei decorsi e degli esiti che con
tali criteri sono stati valutati; al fatto che il profilo di ogni caso
risulta unico e non generalizzabile; alle diverse dimensioni dell’esito
e ai livelli di gravità dei sintomi e dei deficit funzionali che si
possono combinare in ciascun paziente nel modo più differente e per di
più variare imprevedibilmente nel corso del tempo; alle controversie e
alle ambiguità tuttora irrisolte circa i criteri di valutazione e,
infine, se si considerano le amplissime e sorprendenti divergenze che
si evidenziano nel confronto fra le valutazioni dei clinici e quelle
dei pazienti, resta l’impressione netta e sconcertante che quando
parliamo di processi di guarigione della schizofrenia ci sia qualcosa
di essenziale che sfugge alla comprensione.
John S. Strauss, un’autorità mondiale nel campo degli studi sull’esito
dei disturbi schizofrenici, riporta in modo drammatico questa
impressione.
"Quando, seduto sul pavimento del soggiorno, iniziai a riesaminare
tutte le elaborazioni grafiche relative ai soggetti inclusi nella
ricerca, rimasi affascinato dalle cifre e dalla meravigliosa
precisione. Ma non riuscivo a riconoscervi le persone che avevo
intervistato e conosciuto. Non ero più in contatto con loro.
Riflettendo sul decorso del disturbo e osservando i grafici sparsi sul
pavimento, mi sentivo sconcertato e mi rendevo conto che, più di ogni
altra cosa, andava perduta la singola persona, con la sua specifica
volontà. Mi resi conto che avevo a che fare con due diverse dimensioni:
quella della persona, con la sua ricca e profonda esperienza umana; e
quella del mondo dei dati, con la sua attendibilità e validità.
[Qualche tempo dopo] durante uno studio di follow-up che prevedeva
interviste ripetute, una paziente mi disse: “Dottore, ma perché non mi
chiede mai cosa faccio io per aiutare me stessa?”. Sto ancora cercando
di rispondere compiutamente a questa domanda. La paziente stava
sollevando la questione della soggettività. Non considerava sé stessa
unicamente una vittima della sua malattia, un oggetto i cui sentimenti
e le cui azioni fossero irrilevanti al fine di misurare il
peggioramento o il miglioramento. Mi stava chiedendo perché io, noi
professionisti della salute mentale, non includiamo questi aspetti
soggettivi nelle teorie, nelle pratiche, nella ricerca. […] Molti
pazienti dicono: “Ciò che più mi ha aiutato è essermi sentito preso sul
serio”. In un caso è la madre del paziente, in un altro un assistente
sociale, in un altro un amico. Sono cose che si sentono spesso, se si
fanno domande e si è interessati a risposte che si pongono al di fuori
delle usuali preoccupazioni scientifiche."
Certamente non è semplice ‘misurare’ l’esperienza
soggettiva, ed è certamente vero che le facili e incaute
interpretazioni di essa possono produrre effetti discutibili o
fuorvianti. Ma ci si dovrebbe anche chiedere se l’esperienza vissuta
dal paziente nello sforzo di volontà messo in atto nel tentativo di
superare le conseguenze della malattia, al di là di quanto tale sforzo
possa apparire dall’esterno ancora ostacolato e imbrigliato nella
dimensione psicopatologica, non sia invece davvero una chiave
fondamentale per comprendere la schizofrenia e la sua prognosi.
Nello stesso periodo in cui Strauss e altri iniziavano ad approfondire
il tema della fenomenologia della soggettività nella schizofrenia
attraverso metodi qualitativi, cominciava a vedere la luce una serie di
resoconti scritti (first-person accounts) di persone con esperienza diretta di malattia e di recovery
della schizofrenia. L’esperienza vissuta della malattia per come emerge
da queste narrazioni è descritta innanzitutto in termini di perdita: di
identità, di potere, di scelta, di valori personali, di ruolo sociale.
Questi first-person accounts
cominciarono ad attirare l’attenzione di sempre più numerosi
rappresentanti del mondo professionale e accademico, che iniziano a
sostenere che le sfide più intensamente vissute e sofferte da chi fa
esperienza della malattia mentale sono lo stigma che pervade
profondamente il senso di sé, gli effetti iatrogeni degli ambienti di
trattamento, la mancanza di opportunità di autodeterminazione, gli
effetti negativi di non avere un lavoro, i sogni infranti. La malattia
mentale è definita come evento catastrofico: ma non tanto per la sua
dimensione clinica, quanto per le disastrose conseguenze che essa ha
prodotto sull’esistenza della persona. Riprendersi da un evento
catastrofico non modifica il fatto che l’evento sia effettivamente
accaduto, che i suoi effetti siano ancora presenti, che la propria vita
sia cambiata per sempre. Ma superare questi effetti vuol dire riuscire
ad attribuire a essi un significato diverso, che permetta di andare
avanti, di proiettarsi verso altri interessi e attività.
L’autentica novità di questa visione è nel suo spingersi al di là della
sfera della clinica nel tentativo di restituire alle persone con
disturbi mentali gravi e persistenti opportunità analoghe a quelle di
cui possono disporre le persone affette da gravi e disabilitanti
malattie fisiche.
Il concetto di recovery,
per come è utilizzato nel caso di malattie fisiche che comportano
disabilità, non implica necessariamente che la sofferenza sia
scomparsa, che i sintomi siano totalmente rimossi e che le funzioni
siano interamente ripristinate. Per esempio, una persona con paraplegia
può ‘guarire’ anche se la lesione del midollo spinale permane.
Analogamente, una persona con malattia mentale può ‘guarire’ anche se
la malattia non è ‘guarita’.
In questa accezione, recovery
è qualcosa che ‘trascende’ la dimensione clinica e che si realizza a
partire dal ‘risveglio’ di una dimensione dell’identità a lungo
mortificata e sclerotizzata dall’esperienza della malattia e delle sue
conseguenze. Essa può essere quindi definita come un processo
autenticamente personale di sviluppo di un nuovo senso e di una nuova
finalità della propria vita, che possa evolvere al di là degli effetti
catastrofici della malattia mentale.
Un approccio che intenda promuovere e favorire questo processo dovrebbe
tener presente che esso si attiva sostanzialmente dall’interno, prima
che come effetto di azioni esterne (e perciò può aver luogo grazie al
trattamento ma anche indipendentemente da esso), che non è vincolato a
una particolare ipotesi eziopatogenetica della malattia, che può
interrompersi e riprendere in modo non-lineare, che ha un percorso
unico per ogni individuo. Di conseguenza, le prassi dei servizi non
dovrebbero essere basate solo sul trattamento, sull’intervento nella
crisi, sulla riabilitazione, sul case management,
ma dovrebbero anche attivamente promuovere il diritto alla speranza,
alla scelta e all’autodeterminazione e fornire opportunità e sostegni
concreti ai bisogni fondamentali, in modo da creare e mantenere le
condizioni più facilitanti per i percorsi di recovery.
Il concetto di recovery
così riformulato si comincia perciò a delineare come un costrutto
complesso e multidimensionale che sfugge alla misurabilità e alla
standardizzazione; è un processo più che un esito; una visione, un
principio-guida, più che un modello d’intervento.
La letteratura sulla recovery
si è arricchita progressivamente e in varie direzioni (esperienze
soggettive, studi qualitativi, approcci e pratiche dei servizi,
politiche di riforma dei sistemi di assistenza psichiatrica). L’effetto
di questa espansione, nonché la natura olistica, prevalentemente
soggettiva e non-lineare dei processi di recovery, hanno comportato, inevitabilmente, un rischio di ambiguità e contraddittorietà nei tentativi di concettualizzazione.
Una prima approssimativa delimitazione del concetto viene fatta
emergere dalla tensione fra differenti paradigmi: al paradigma
‘scientifico’, inerente ai criteri standardizzati per la valutazione
degli esiti dei trattamenti e che informa le pratiche orientate alla
riduzione dei sintomi e della disabilità, viene contrapposta la
riformulazione di recovery per come scaturisce dall’esperienza vissuta. Alla recovery come esito clinico, perciò, si contrappone la recovery
‘personale’, guidata dal paziente, centrata sul paziente, basata sul
diritto all’autodeterminazione e all’inclusione nella vita della
comunità, malgrado la persistenza della malattia.
Sul fronte dei tentativi di concettualizzazione, occorre tener presente
che non vi è in alcun modo una definizione formalizzata e
universalmente condivisa. Piuttosto, una serie di ‘temi’ o ‘componenti’
fondamentali che ricorrono frequentemente, convergono in una visione
abbastanza omogenea e riconoscibile. Ma la particolare enfasi conferita
ora a una ora all’altra componente può generare delle differenze e dare
un’impressione complessiva di indeterminatezza.
Si potrebbe dire, in questo senso, che i processi di recovery
si attivino innanzitutto, e ‘spontaneamente’, nell’individuo, a partire
dall’esigenza di superare gli effetti catastrofici della malattia e
recuperare un’identità positiva, la quale, per effetto della
internalizzazione dello stigma, era stata soppiantata da quella di
malato mentale o avviluppata in essa. Il recupero di qualcosa che a
causa della malattia era andato perduto (che è peraltro uno dei
significati del termine ‘recovery’) può avvenire anche in
assenza di specifici interventi esterni (e perciò restare fuori dal
campo dell’osservazione clinica) e accadere come un fatto ‘privato’
nella biografia del paziente. Ma nelle storie dei ‘sopravvissuti’ il
risveglio della speranza di recuperare un’identità positiva, sulle cui
basi ‘ricostruirsi una vita’, è possibile, o quanto meno facilitato, se
la ‘nuova’ identità venga riconosciuta, rispettata e valorizzata
nell’ambito di un contesto interpersonale. Questo processo di
riconoscimento sembra svolgersi su due piani: quello socio-politico, in
termini di esplicita restituzione di diritti, e che quindi ha a che
fare con aspetti di sistema (legislazione, risorse, pianificazione e
organizzazione dei servizi), e quello più strettamente
interpersonale/terapeutico (attitudini degli operatori, cambiamenti di
mentalità, riformulazione dell’alleanza terapeutica eccetera) quale
dominio autenticamente umano in cui, nell’atto del riconoscimento, si
arricchiscono di valore entrambi i partner della relazione e aumenta il
capitale sociale delle comunità. Su entrambi i piani, pertanto, si
realizza un’azione di empowerment, poiché l’accettazione e la
valorizzazione dell’identità positiva comporta la restituzione del
potere di scelta e controllo, di competenza e di valore, di autonomia e
responsabilità. Il percorso, unico e irripetibile, lungo il quale tale
processo può aver luogo, è tipicamente non-sequenziale, poco
prevedibile e soggetto a battute d’arresto, sospensioni e riprese;
ciononostante, i processi di recovery per come a questo punto emergono, risultano essere descrivibili e concettualizzabili.
Un primo importante impatto di questa spinta propulsiva sulle pratiche
dei servizi si riflette sulla dicotomia fra evitamento sistematico del
rischio e assunzione/gestione del rischio. Se è l’utente a definire i
suoi obiettivi e a reclamare la ‘dignità del rischio’ e il ‘diritto di
sbagliare’ come parte essenziale dell’esercizio di autodeterminazione (agency),
occorrerà allora una ridefinizione della responsabilità dei servizi e
delle ‘soglie’ di rischio accettabile? Certamente, l’evitamento
sistematico del rischio comporta l’adozione di prassi difensive da
parte dei servizi e restrittive dell’autodeterminazione dell’utente, o
giustifica interventi più o meno palesemente coercitivi, agendo nel
complesso come potente fattore di dis-empowerment. Si distingue
perciò il rischio nocivo, correlato a comportamenti illegali, violenti
o autolesivi, da una accezione positiva del rischio come parte
integrante dei processi di crescita, cambiamento, resilienza, sviluppo
e consolidamento dell’identità. Si tratta, quindi, di una tensione
immanente e inevitabile, che un servizio recovery-oriented
dovrebbe tener presente e affrontare caso per caso, attraverso la
ricerca di un equilibrio non delegata a un solo operatore, ma quanto
più possibile allargata e condivisa fra più operatori, l’utente e i
familiari.
Un’altra importante implicazione che l’orientamento alla recovery
comporta per i servizi, connessa alla precedente, si rivela nella
tensione fra gradualità e tempestività. Essa è specialmente evidente
nei percorsi riabilitativi, classicamente impostati sui due assi della
‘restituzione sociale’ della disabilità psichiatrica, abitazione e
lavoro, e che tipicamente prevedono programmi articolati in fasi
successive, vincolate al raggiungimento di obiettivi parziali nel
recupero del funzionamento personale e sociale. In entrambi gli assi,
lungo tali percorsi a fasi successive che si attuano generalmente in
contesti istituzionali separati dal resto della comunità, la
prospettiva di una reale uscita dal circuito viene sistematicamente
differita, il paziente rischia di strutturare ulteriormente lo stigma
interno e prolungare la dipendenza istituzionale, mentre il sistema nel
suo complesso tende verso una prospettiva di re-istituzionalizzazione.
In questi ambiti, l’orientamento alla recovery implica invece
l’assunzione che le persone apprendono dalle esperienze reali quando
queste sono concretamente disponibili, non dopo aver dimostrato un
miglioramento dei sintomi e del funzionamento.
In questo senso, rientrano nella tipologia delle prassi recovery-oriented gli approcci all’housing basati sull’abitazione indipendente con supporto flessibile (Supported Housing) e i modelli di inserimento lavorativo supportato (Individual Placement and Support), che hanno dimostrato risultati molto più convincenti dei modelli tradizionali).
Altri aspetti delle prassi dei servizi che l’orientamento alla recovery mette potenzialmente in questione riguardano le complesse relazioni fra aderenza al trattamento (compliance), consapevolezza di malattia (insight)
e stigma. La carenza di consapevolezza nei disturbi schizofrenici è
riportata in circa la metà dei casi ed è generalmente considerata come
un fattore prognostico negativo in quanto è associata a una minore
aderenza al trattamento e a esiti sfavorevoli. Insight e compliance
sono quindi in relazione circolare in quanto si potenziano
reciprocamente, e tale potenziamento diviene esso stesso un obiettivo
fondamentale degli interventi terapeutici. Ma se l’elemento cruciale
dei processi di recovery è, come abbiamo visto, l’esercizio dell’autodeterminazione (agency),
come si può conciliare con la ricerca della passiva aderenza al
trattamento? Studi qualitativi su gruppi di utenti scarsamente
collaborativi hanno messo a fuoco questo clinical dilemma: lo
psichiatra che è disposto, per esempio, a ridurre o interrompere il
trattamento farmacologico, aderendo a una richiesta del paziente, è da
questi percepito come autenticamente rispettoso del suo punto di vista
e ciò consolida l’alleanza terapeutica; ma, allo stesso tempo e su un
altro piano, lo psichiatra potrebbe così disattendere le linee guida e
le raccomandazioni della psichiatria evidence-based.
Anche in merito all’insight, l’attenzione ai processi di recovery
apre questioni inedite. Se è vero che la consapevolezza del paziente,
contrapposta al diniego della malattia, facilita la collaborazione e la
continuità terapeutica, è altrettanto vero che ad alti livelli di insight
corrispondono vissuti soggettivi di depressione, disperazione e
tendenze suicidarie, connesse allo stigma internalizzato, cioè al
riflesso che lo stigma sociale di malato mentale produce sul senso di
sé e sull’identità.
Un’ulteriore implicazione dell’orientamento alla recovery
è rappresentata dall’imprescindibilità di un riequilibrio
dell’esercizio del potere nella relazione terapeutica. Se i processi di
recovery sono prevalentemente autodiretti e ‘di proprietà’
dell’utente, lo status e l’autorità dell’operatore tendono a venire
ridimensionati. E ciò può essere vissuto come una minaccia all’identità
sociale e all’autostima dei professionisti della salute mentale. In
questo senso, si può prospettare la necessità di un processo di ‘recovery
degli operatori’, cioè di un’elaborazione critica dei pregiudizi verso
la malattia mentale che sembrano sopravvivere negli addetti ai lavori
in misura perfino più pesante che nella popolazione generale. Questo
tema richiama strettamente la delicata questione, già delineata a suo
tempo da Castelfranchi, del ‘rapporto tutorio’, continuamente
riconoscibile nel rapporto servizio-utente. Di fronte alla disabilità
psichiatrica, specialmente quando in essa predominano aspetti
‘negativi’ apparentemente immodificabili (apatia, ritiro, rifiuto),
l’operatore e il servizio mettono in atto strategie per contrastare
l’impotenza attraverso l’attribuzione al paziente di scopi e percorsi
sostanzialmente eterodiretti e spesso standardizzati. L’orientamento
alla recovery implica invece una sorta di rinuncia preliminare
a tale attribuzione arbitraria di scopi (e alla pretesa che essa
rappresenti la risposta a ‘richieste implicite’ di aiuto) e un lavoro
molto più impegnativo di ascolto, pazienza, tolleranza dei limiti,
flessibilità, al fine di creare le condizioni per l’emergenza di spunti
autentici di autodeterminazione.
Certamente il concetto di recovery
ha una natura idiografica più che nomotetica e come tale può apparire
comunque sfuggente e può prestarsi a facili entusiasmi così come ad
atteggiamenti critici. Questi ultimi si concentrano prevalentemente
sulla sua potenziale elusività e sul sospetto di ideologia che potrebbe
celare, ma anche sul rischio di suscitare aspettative irrealistiche per
i pazienti e i familiari.
Non possiamo oggi prevedere se, quando e in che misura il paradigma della recovery
potrà effettivamente incidere sulla cultura e sulle prassi dei servizi
di salute mentale o se invece esso subirà un destino analogo ad altre
‘mode’ e slogan della psichiatria del passato. Certamente non si può
negare che si sia innescato un processo di dimensioni notevoli. Se la
ricerca prevarrà sulla retorica, esso potrà realmente dar luogo a
decisive trasformazioni dell’assistenza psichiatrica.
Per ulteriori approfondimenti, si veda: Recovery. Nuovi paradigmi per la salute mentale, a cura di Antonio Maone e Barbara D’Avanzo. Raffaello Cortina Editore, 2015.

Alcune caratteristiche della terapia occupazionale
 Matthias Moeller MScOT, insegnante di terapia occupazionale
Matthias Moeller MScOT, insegnante di terapia occupazionale
Premessa
La terapia occupazionale in Italia è una professione
giovane ed è conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella
riabilitazione neurologica. Tuttavia, ha le sue radici nella
psichiatria, e sull’arco dei cento anni della sua storia internazionale
si è sviluppata diversamente per quanto concerne l’ambito psichiatrico.
Il testo seguente vuole dare un’essenza di ciò che caratterizza il
ruolo della professione nella cura di persone affette da malattia
psichica.
Alcuni presupposti generali
L’idea centrale della terapia occupazionale vede l’uomo come 'essere
occupazionale' (Wilcock, 2015) che intrinsecamente vuole fare, agire,
essere produttivo. 'Occupazione' non vuol dire solo lavoro. Alcuni
esempi di occupazione sono il tempo utilizzato per l’igiene personale,
preparare un pasto, la gestione delle finanze, dipingere un quadro,
frequentare un corso in comunità per il tempo libero e socializzare con
altri. Quando, in un momento determinato della propria vita e per
qualsiasi motivo, la capacità d’agire è compromessa, la persona vive
momenti e/o periodi di perdita, d’interruzione e/o di alterazione della
sua performance occupazionale. In altre parole: non si sente più capace
o effettivamente non è più capace di 'fare'. Lo scopo della terapia
occupazionale s’indirizza a queste capacità perse e/o interrotte.
La terapia occupazionale ingloba principi della psicologia umanistica
(Kielhofner, 2004) come l’approccio centrato sulla persona, che
costruisce la relazione terapeutica su concetti come partenariato,
scelta, motivazione, responsabilità e autodeterminazione, ossia
concetti per la potenziale auto-realizzazione (Rogers, 1959). In
accordo con queste premesse epistemologiche, negli ambiti della salute
mentale e della psichiatria, la terapia occupazionale riconosce la
complessità della persona (Creek & Lawson-Porter, 2007) come essere
occupazionale, e accompagna l’individuo nel suo percorso di cura, ossia
nel crearsi un (nuovo) progetto di vita dopo la manifestazione della
patologia psichiatrica.
L’approccio del terapista occupazionale, tra l’altro, si basa
fortemente su tre idee umanistiche:
● Empowerment:
concetto che enfatizza l’aspetto del fare assieme, della giustizia
individuale e della partecipazione attiva (Brown & Stoffel, 2011).
● Recovery Model:
concetto che sostiene l’idea che si può vivere bene anche senza
guarigione (COT 2006, 2008, 2010). Si tratta quindi per il terapista di
accompagnare la persona con problemi di salute mentale in un percorso
di guarigione e di trasformazione, sostenendola nel vivere una vita
significativa in una comunità di sua scelta, sforzandosi di raggiungere
il proprio potenziale.
● Salutogenesi: concetto
sviluppato da Aaron Antonovsky (1996) in termine di promozione della
salute: è la persona stessa che determina dove attualmente si colloca
nel continuum tra salute e malattia, ed è la persona stessa a
determinare quando e come l’aspetto occupazionale diventa necessario
per il proprio stato d’essere.
Tuttavia, laddove non è indicato o possibile seguire un approccio
non-direttivo, il terapista occupazionale è altresì in grado di
integrare quadri teorici diversi nella sua proposta d’intervento
terapeutico che seguono altre scuole psicologiche come il pensiero
psicoanalitico, i principi della terapia cognitiva, comportamentale, o
cognitivo-comportamentale, o di gruppo (Hagedorn, 2001). Nonostante la
diversità degli approcci, i terapisti occupazionali collaborano con
persone in modo tale da cercare a promuovere la speranza, la
motivazione e la responsabilizzazione, così come il cambiamento, per
sostenere ogni persona nel partecipare e nello svolgere con successo le
occupazioni auto-selezionate.
Valutazione e trattamento
L’American Occupational Therapy Association
(AOTA) ha definito otto aree occupazionali nelle quali il terapista
occupazionale può intervenire indipendentemente dall’ambito medico:
1. Attività di base della vita quotidiana (BADL), come lavarsi o vestirsi
2. Attività strumentali della vita quotidiana (IADL), come usare i mezzi pubblici o fare la spesa
3. Educazione/istruzione
4. Lavoro (volontario e retribuito)
5. Gioco
6. Riposo e sonno
7. Tempo libero
8. Partecipazione sociale
Quando si lavora con una persona con un problema di salute mentale, il
terapista occupazionale applica una varietà di valutazioni per creare
un profilo occupazionale personale. Nello specifico, il terapista
occupazionale valuta:
● Le abitudini i ruoli sociali e le routine quotidiane
● La comunicazione e le competenze di interazione
● La capacità e i processi cognitivi e mentali
● Le capacità legate ai processi motori
● L’impatto dei vari ambienti (per esempio, culturale, fisico, spirituale)
● Le richieste occupazionali (analisi fenomenologica) delle attività
● I fattori specifici della persona (per esempio, difficoltà dovute a strutture del corpo o funzioni, appoggiandosi sulla ICF)
● L’auto-valutazione occupazionale della persona
La terapia occupazionale assume importanza nel processo del trattamento
in salute mentale in generale. Di seguito sono elencati alcuni
interventi comuni:
● Life skills training (training delle competenze per la vita)
● Riabilitazione cognitiva
● Training sociale e delle capacità interpersonali
● Sostegni durante scuola e studio
● Sostegno al posto di lavoro
Il terapista occupazionale collabora con molti altri professionisti per
aiutare gli individui al loro recupero fornendo un contributo teorico e
clinico al team curante, nell’ottica di una presa 1n carico globale ed
integrata.
Il focus è quindi posto sui problemi occupazionali della persona, ossia
i problemi che la persona ha nello svolgimento delle attività della
vita quotidiana significative per lui/lei. Il metodo principale del
terapista occupazionale (Creek, 2003) ha struttura predefinita ed è
flessibile allo stesso tempo: in base alle assunzioni filosofiche della
professione sviluppa, assieme alla persona presa in carico e in accordo
con le premesse del team curante, una proposta d’intervento che mira al
miglioramento delle capacità d’agire e/o della performance
occupazionale considerando tutti gli aspetti inerenti ad essa.
Per prima cosa, tramite osservazione, colloquio, strumenti di
valutazione standardizzata e non standardizzata, e strumenti di
autovalutazione, il lavoro diagnostico del terapista occupazionale si
concentra sulla formulazione della diagnosi occupazionale, ossia
dell’estrapolazione dei problemi reali nel fare delle cose della
persona causati dall’interruzione o alterazione della performance
occupazionale. Si formulano degli obiettivi d’intervento chiari,
realistici, comunicabili, e centrati sull’occupazione al fine di
garantire la raggiungibilità e il successo dell’intervento di terapia
occupazionale (Mayor et al., 2014). Questi obiettivi s’inseriscono nel
processo della terapia occupazionale che comprende quattro fasi
maggiori:
1. la valutazione della persona con un focus sul suo profilo
occupazionale e l’esame dello stato attuale della performance
occupazionale e dell’impatto dell’ambiente;
2. la pianificazione dell’intervento rendendo comprensibile piano, programma e mezzi per raggiungere gli obiettivi posti;
3. lo svolgimento della terapia in un’ottica della valutazione continua di tutti i parametri predefiniti, e
4. la valutazione conclusiva con gli strumenti analoghi alla
valutazione iniziale, per identificare e misurare i risultati ottenuti
(Mayor et al., 2014).
Le quattro fasi con le rispettive tappe sono certamente parzialmente
intrecciate tra loro, ma seguono anche una determinata logica
cronologica. Tuttavia, si tratta di un percorso circolare piuttosto che
lineare. Legato a ogni fase del processo di terapia occupazionale, si
usano diverse forme di ragionamento clinico (Mattingly e Fleming, 1994)
che plasmano tutto l’intervento terapeutico. All’interno del processo
di terapia occupazionale s’integrano gli strumenti di valutazione e i
metodi di trattamento specifici ed appropriati, cercando di creare il
setting più idoneo possibile per la persona presa in carico. Il mezzo
terapeutico del terapista occupazionale può essere qualsiasi attività
della vita quotidiana. In questo senso, l’attività allo stesso tempo
può essere sia mezzo che fine (Gray 1998). La terapia occupazionale
considera la storia, lo stato attuale e l’identità occupazionale della
persona nel suo approccio, riconoscendoli come potenziali risorse per
migliorare la sua performance occupazionale in un processo che
idealmente è il più auto-guidato possibile. Le finalità dell’intervento
di terapia occupazionale sono per esempio il benessere psico-fisico, la
qualità di vita, la partecipazione sociale, e infine l’inserimento in
contesti e/o progetti di vita che siano autodeterminati dalla persona
stessa e in cui quest’ultima possa svolgere le attività per lei/lui
significative. Le attività della vita quotidiana hanno un potenziale
terapeutico immenso, perché
● aiutano a dare struttura alla giornata, alla settimana, ed infine a
tutto il tempo della persona incluso il ritmo riposo e sonno;
● sono le basi per la cura di sé non solo in senso dell’igiene
personale, ma anche in termini di auto-percezione di corpo, mente e
anima come mezzi per riconoscere, vivere, esprimersi e percepirsi nei
propri movimenti, pensieri, sensazioni ed emozioni;
● aiutano a percepirsi come capace nella gestione della propria vita
quotidiana nei contesti in cui la persona si muove (educazione, lavoro,
tempo libero);
● aiutano a sentirsi in grado di avere controllo sulla propria vita.
Il termine 'attività' è centrale per ogni essere umano, in quanto
descrive in modo generale ciò che si vuole fare, senza però attribuire
un valore o significato personale ad essa. Per esempio, tutti abbiamo
un’idea abbastanza concreta quando parliamo dell’“andare a mangiare la
pizza”. È il significato soggettivo che la persona attribuisce a
quest’attività che la trasforma così da un’attività descritta
genericamente e conosciuta da tutti in un’attività idiosincratica,
ossia un’occupazione, che, per definirla in termini della terapia
occupazionale, consiste in ogni attività che ha un significato,
un’importanza, un valore personale, e un modo personale di svolgerla
(Townsend & Polataijko, 2007).
Per questo, nella terapia occupazionale, il solo “gli faccio fare” non
è un approccio di scelta, perché non coerente alle basi filosofiche
della professione. Come primo principio, non si sforza la persona a
svolgere delle attività. Piuttosto la persona è invitata a stare in
compagnia, anche solo a guardare, e sentirsi libera di decidere quando
vuole attivarsi. Come dicono Le Granse, Kinebanian, & Josephsson
(2006): “Il terapista occupazionale non è la persona che determina il
contenuto della vita quotidiana dell’altro, ma è la persona che crea le
condizioni che rendono l’altro capace di determinare il contenuto della
sua vita quotidiana” (p. 153).
È competenza e compito del terapista occupazionale di analizzare i
momenti e/o periodi d’interruzione o d’alterazione della performance
occupazionale (Law et al. 1997). Assieme alla persona e in
considerazione della sua identità personale e occupazionale, si
sviluppano delle strategie per affrontare possibilità di recupero,
ripristino, adattamento o compensazione della capacità d’agire, ossia
per migliorare anche in termini misurabili la performance
occupazionale.
In conclusione, la relazione paziente – terapeuta è di fondamentale
importanza; tuttavia, nella terapia occupazionale deve essere
l’attività stessa/ l’occupazione stessa il motivo per la persona a
mobilizzarsi e a svolgerla, e non lo dovrebbe fare per il terapeuta,
per evitare al massimo il rischio di dipendenza della persona dallo
stesso. In altre parole: l’attività non si fa perché la terapista
occupazionale è così “bella, carina, gentile” o perché il paziente
vuole fare un favore a lei. L’attività si svolge perché la persona la
vuole svolgere grazie al potenziale motivazionale che l’attività
comporta per sé stessa, e grazie alla propria motivazione e al
significato personale che fa sì che l’attività si trasformi in
un’occupazione.
A livello metodologico, ci sono alcuni principi di base che il
terapista occupazionale considera in forma di metodi d’intervento:
oltre all’utilizzo delle attività di base e strumentali della vita
quotidiana come metodo a sé stante, tutte le attività hanno potenziale
terapeutico a diverso indirizzo. Ci sono delle attività che
s’indirizzano alle competenze pratiche della persona, oppure alla sua
percezione corporea. Altre attività promuovono automaticamente
l’interazione con altri, altre attività ancora sostengono le capacità
della persona di esprimere sensazioni ed emozioni. Molto spesso
un’attività determinata combina più di uno degli aspetti elencati;
comunque, il terapista occupazionale cerca di considerare il carattere
tipico delle attività riguardo ai termini cura di sé, competenza,
percezione, interazione ed espressione (Kubny-Lüke, 2003). Ecco alcuni
esempi.
In generale, per quanto concerne l’intervento di terapia occupazionale
con persone affette da malattia psichica, tutti questi metodi sono
applicabili e applicati:
● In fase acuta, spesso il focus delle attività è posto sulle
competenze in combinazione con le BADL e IADL, perché per la persona in
crisi si tratta di ritrovare e ricreare ordine, struttura e sicurezza,
e si utilizzano tecniche con materiali chiari, strutturati e
strutturanti. Alla fine dell’attività spesso vi è oggetto concreto come
risultato tangibile.
● l’aspetto della percezione corporea si aggancia al tema delle
competenze, perché svolgendo delle attività inevitabilmente la persona
sente il proprio corpo, anche se eventualmente in modo alterato, oppure
l’aspetto corporeo viene completamente ignorato. Si utilizzano tecniche
con materiali che offrono chiare e diverse qualità di percezione
tattile e propriocettiva.
● Quando la persona è più stabile e le richieste dell’ambiente possono
essere più complesse, entrano in gioco le attività che hanno un
potenziale per creare momenti di interazione con altri. Queste tecniche
preparano la persona al transito dal setting individuale al setting di
gruppo.
● Alla fine, quando la persona idealmente è sempre più stabile, tramite
delle attività espressive ci si può focalizzare sull’espressione di
sensazioni ed emozioni tramite tecniche e materiali che aiutano la
persona ad riorientarsi anche in questo settore del suo essere uomo.
Per queste attività tipicamente il processo diventa più importante
dell’oggetto tangibile.
Conclusione
Piuttosto che focalizzarsi su aspetti meramente funzionali dove
applicando una visione non-olistica si allenano le funzioni specifiche
in modo separato, il terapista occupazionale, appena possibile, dà
sempre precedenza alle attività intere. Idealmente, queste attività
hanno le caratteristiche dell’occupazione per essere utilizzate come
mezzo terapeutico. Va ricordato quanto detto all’inizio: lo scopo del
terapista occupazionale è rendere possibile “vivere la vita al massimo”
(AOTA, 2015).
Per raggiungere questo scopo, il terapista occupazionale utilizza
qualsiasi attività della vita quotidiana come mezzo terapeutico. Con i
suoi strumenti e metodi specifici, il terapista occupazionale si deve
inserire nell’offerta terapeutica del team curante, perché la cura in
salute mentale e in psichiatria richiede uno sforzo di collaborazione
di molte persone – l’individuo stesso, i suoi caregiver, i medici, gli
infermieri, gli psicologi, gli insegnanti, i curatori, i terapisti
occupazionali e gli assistenti sociali.
Questo processo di collaborazione permette a tutti di lavorare insieme
per raggiungere un obiettivo specifico: migliorare la qualità di vita
della persona identificando e sviluppando abilità e comportamenti
appropriati.

Autonomia… caro tesoro!
 Mariana Parera animatore, Gabriele Beghini collaboratore
Mariana Parera animatore, Gabriele Beghini collaboratore
 L
avoro da anni nella gestione dell’area 'Animazione' in residenze per
anziani non autosufficienti. Sono in stretto contatto con gli abitanti
della casa, frequentandoli ogni giorno ho riflettuto a lungo sulla loro
condizione e i loro stati d’animo, soprattutto per quanto concerne
l’argomento oggetto di questo numero del Faro: l’autonomia.
L
avoro da anni nella gestione dell’area 'Animazione' in residenze per
anziani non autosufficienti. Sono in stretto contatto con gli abitanti
della casa, frequentandoli ogni giorno ho riflettuto a lungo sulla loro
condizione e i loro stati d’animo, soprattutto per quanto concerne
l’argomento oggetto di questo numero del Faro: l’autonomia.
Vediamo cosa dicono al riguardo e come definiscono il termine ‘autonomia’ le fonti convenzionali:
(Da Wikipedia, l’enciclopedia libera) "Con il termine 'autonomia' (dal greco antico, parola composta da auto e nomos,
‘legge’, ovvero ‘legge propria’) si intende la possibilità per un
soggetto di svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o
condizionamenti da parte di terzi".
(Da Enciclopedia Rizzoli Larousse) "Per estensione o senso figurato si
associa con l’idea di indipendenza: autonomia di giudizio, autonomia
economica… Nel diritto privato si intende per autonomia la capacità del
privato di decidere liberamente quale miglior tutela dare ai propri
diritti o interessi".
Sorge spontanea la seguente domanda: "Siamo veramente consapevoli del
valore che rivestono queste potenzialità o lo scopriamo solo quando le
stiamo perdendo?".
Autonomia, autosufficienza, autogestione della propria esistenza,
indipendenza… si tratta di concetti che, nonostante le piccole
sfumature di significato, presentano affinità e possiamo considerarli
congiuntamente. Nel mondo dell’anziano la perdita dell’autonomia
coincide con l’insorgere o con l’aggravarsi di patologie di carattere
degenerativo. Rientrano in una realtà di progressivo ma inarrestabile
degrado della condizione fisica della persona, spesso accompagnato da
patologie che coinvolgono la psiche. Se interessano gli arti si parla
di perdita della mobilità, nel caso della psiche di perdita
dell’orientamento, può altresì trattarsi di altre patologie gravi che
costringono il soggetto a chiedere l’aiuto esterno.
Invecchiando, si perdono le proprie funzionalità, in alcuni casi si
tratta di problemi circoscritti, in altri si determina un quadro
complessivo in cui le problematiche si interconnettono producendo un
risultato inequivocabile: la persona ha bisogno di aiuto. E in questo
stato di fatto l’anziano rappresenta l’involontario protagonista, che
però normalmente non decide. Intervengono parenti, assistenti sociali,
geriatri, amministratori eccetera, attori esterni al soggetto decidono
per lui/lei. Qualcuno a vario titolo chiamato in causa interviene e
sancisce che l’anziano non è più autosufficiente. Le misure vanno dalla
badante al centro diurno fino al ricovero permanente in una struttura
residenza. Il momento esatto in cui sia opportuno applicare questi
interventi è un tema arduo e molto dibattuto. Anche dal punto di vista
giuridico non è facile stabilire quando cessi il diritto
dell’individuo, per anziano che sia, di decidere per sé stesso e quando
invece sia opportuno e corretto che qualcun altro decida per lui/lei.
Far lasciare il proprio mondo e ricoverare una persona con buone
capacità psichiche in una struttura può rappresentare un vero e proprio
dramma, se questi non è consenziente, e può comportare l’insorgere di
serie problematiche di diversa natura. Talvolta si fa credere che si
tratti di misura temporanea, che poi tornerà tutto come prima. La
realtà, purtroppo, è rappresentata da un capitolo che si chiude per
sempre. Si apre un periodo in cui la propria sfera di discrezionalità
si riduce drasticamente. Ogni momento dell’esistenza non sarà più
prerogativa del singolo, ma sarà influenzata o del tutto gestita da
interventi esterni alla persona.
Dalla mia esperienza di lavoro con anziani posso affermare senza ombra
di dubbio che questa situazione, la perdita di potenzialità, è fonte di
profondi disagi. Produce effetti devastanti sulle aspettative del
soggetto anziano e sulla fiducia in sé per quanto attiene il proprio
rendimento. Spesso trovano conferma dai segnali provenienti dal mondo
che li circonda: parenti, amici, conoscenti e altre figure che
interagiscono con l’anziano talvolta concorrono involontariamente, con
comportamenti che vanno dall’atteggiamento troppo protettivo alla
scarsa sensibilità, ad aumentarne la situazione di disagio. La
progressiva perdita di autonomia dell’anziano istituzionalizzato si
traduce in tristi emozioni, talvolta rabbia, tingendo di grigio la vita
interiore di colui che ha perso completamente o in parte il controllo
della sua preziosa autonomia. In altre parole, non è più l’interessato
a prendere le decisioni sulla propria esistenza. E questa perdita di
potere decisionale si verifica in tutte le aree di attività, compreso
il piano economico. Si ridisegna il ruolo e il sistema di rapporti.
Persone che in passato erano note per una forte personalità e
ammirevoli doti, vedono perdere giorno dopo giorno le proprie qualità.
Divengono dipendenti e devono accettare un ruolo subordinato. Da un
lato è comprensibile … ma … riusciamo ad entrare in sintonia con
l’anziano per aiutarlo con una strategia di approccio allineata alla
sua problematica?
Di fatto, quando una persona fa ingresso in una struttura per anziani
non autosufficienti vuol dire che “non ce la può più fare da sola”,
questo è il messaggio forte. Talvolta non è nemmeno consapevole di
questa sua realtà il che aggiunge ancora più sconforto. Entra in un
mondo molto diverso dal suo, che contrasta con lo stile di vita
precedente, diviene parte di una quotidianità comunitaria. Condivide
con tante altre persone gli spazi e i suoi tempi anche quando non lo
desidera; dopotutto sono stati altri a riprogrammare la sua vita
pensando alla sua salute e alla sua sicurezza. A questo punto
interventi esterni alla sua sfera si alternano e riempiono tutto l’arco
della sua giornata. Si tratta di figure professionali che concorrono al
benessere dell’anziano ma che possono anche costituire interferenze non
sempre gradite. Noi animatori, per le mansioni che siamo chiamati a
svolgere, tocchiamo con mano questa particolare realtà perché gli
anziani raccontano le loro esperienze e le loro emozioni. Lo fanno
attraverso il linguaggio verbale di senso più o meno logico a seconda
del grado di disorientamento, naturalmente riveste un ruolo
fondamentale il linguaggio del corpo. Anche nel caso del più profondo
disorientamento spesso si sente invocare il desiderio di tornare a
casa. In molti soggetti è vivo il ricordo della propria casa, dei
vicini e delle persone care, degli oggetti che facevano parte della
loro quotidianità, delle loro abitudini che sono difficili da
riprodurre in una struttura.
Per questo motivo ha un importanza decisiva implementare procedure le
cui fondamenta poggino sulla comprensione del dramma vissuto da coloro
che hanno dovuto allontanarsi dalle loro case più o meno consapevoli,
in maggior parte ignari di non rientrare mai più. Il ruolo
dell’animazione, quando ben inserita e valorizzata all’interno delle
strutture, può dare un gran contributo al fine di migliorare la qualità
di vita dell’anziano e rendere piacevole la sua permanenza nel nuovo
contesto abitativo. Mi sto riferendo all’animazione socio culturale
svolta da professionisti con la qualifica di animatore.
Leggiamo alcuni punti del mansionario che descrive il Sistema regionale
delle qualifiche dell’Emilia Romagna per avere una prima idea delle
aree di intervento:
“L’Animatore sociale è quella figura professionale in grado di
realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa,
attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico-fisico e
relazionale di persone e gruppi/utenza e stimolando le potenzialità
ludico-culturali ed espressivo - manuali”. Si parte da una descrizione
sintetica del profilo professionale che, in realtà, preannuncia la
complessità del ruolo. Chi fosse interessato può ulteriormente
documentarsi e comprenderà che non si tratta di un ruolo nel quale si
possa assolutamente improvvisare. L’animatore, per riprendere i nostri
argomenti, si trova a fronteggiare una realtà dolorosa per l’anziano:
la perdita dell’autonomia e dell'autosufficienza per gestire la propria
esistenza in un nuovo contesto. È chiamato a favorire il processo di
adattamento alla vita istituzionalizzata. Gli viene incontro per
aiutarlo ad affrontare ed accettare un cambiamento drastico dello stile
di vita e per dare al contempo sostegno, perché possa assimilare con
minor sofferenza le condizioni ora fisiche ora mentali in cui si trova.
Lavora intensamente sulla sfera emozionale del soggetto facendo uso di
tutte le risorse a disposizione. Soprattutto si avvale della propria
formazione, per quanto attiene alla modalità di approccio nella
relazione di aiuto. Fa forza sull’interessamento per le persone e mette
passione in ciò che fa: la voglia di incontrare l'anziano, con il
deciso proposito di fare in modo che costui possa dare un senso alla
propria giornata e quanto meglio, un senso di conforto e gradimento! Si
perfeziona sull’ascolto e sulla capacità di tradurre i suoi bisogni,
emozioni e comportamenti attraverso l’incontro empatico. Procede
attraverso il dialogo individualizzato, durante la socializzazione e le
attività di gruppo. Crea contesti di agio e mette a disposizione delle
altre figure professionali informazioni ricavate per coinvolgerle nella
costruzione di strategie condivise, specie nei casi in cui è possibile
il lavoro di squadra. Del resto, si prende atto che il recupero totale
dell’autonomia è un impresa in pratica difficilmente realizzabile.
Casomai ci sarà un recupero parziale delle potenzialità e la
possibilità di offrire un contesto abitativo più gradevole nel quale la
persona possa tornare a sentirsi parte attiva e utile perlomeno nel qui
e ora dell’intervento di animazione, creato anche per mantenere in
esercizio capacità residue … o se vogliamo, i residui di autonomia …
Un pensiero ricorrente tra le mie prime riflessioni di quando iniziai
il mio percorso nel campo dell’animazione nelle Strutture Residenziali:
“… questa potrebbe diventare la mia… la nostra casa in futuro” e sono
ancora convinta di tale possibilità, perciò questo articolo non ha
altro proposito che invitare i lettori a riflettere insieme a me su una
realtà che la società stessa ci porta a negare, vale a dire, la
senilità e le sue ‘sventure’ e, d’altra parte, sulla necessità di
figure professionali sempre più pronte a dare una risposta articolata
al vissuto interiore degli anziani istituzionalizzati.
Fonti e Bibliografia:
Rizzoli Larousse - Enciclopedia Universale
Leopoldo Salvarezza, La vejez “Una mirada gerontológica actual, Paidós
Franco Nanetti, Assertività, Pendragon
www.regione.emilia-romagna.it : Sistema Regionale delle Qualifiche
|
|
|

LO SVILUPPO DEL BAMBINO E LA PERSONALITÀ
di Paul Mussen, John Conger, Jerome Kagan (1994)
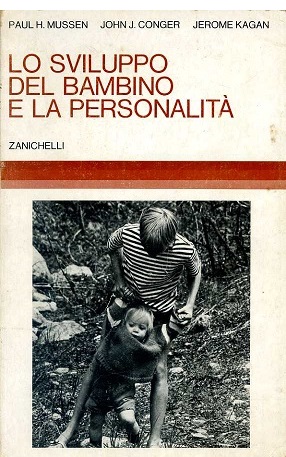 P
er questo numero del Faro che
parla di autonomia ho voluto fare una specie di ricerca documentandomi
con un vecchio libro di pedagogia “Lo sviluppo del bambino e la sua
personalità”.
P
er questo numero del Faro che
parla di autonomia ho voluto fare una specie di ricerca documentandomi
con un vecchio libro di pedagogia “Lo sviluppo del bambino e la sua
personalità”.
Ho pensato infatti di affrontare un tema molto importante: l’autonomia
dell’adolescente nei confronti dei genitori. Ho analizzato quindi il
rapporto tra genitori e figli nell’adolescenza. I genitori possono
assumere vari tipi di atteggiamento: autocratico, autoritario,
democratico o autorevole, egualitario, permissivo.
Atteggiamento autocratico: i genitori si limitano a dire ai figli che
cosa devono fare. Atteggiamento autoritario: gli adolescenti possono
partecipare alla vita familiare ma non hanno voce in capitolo quando si
prendono delle decisioni.
Atteggiamento democratico o autorevole: il giovane porta liberamente il
proprio contributo nelle discussioni concernenti questioni importanti
relative al suo comportamento e può proporre delle scelte, anche se il
potere decisionale resta ai genitori.
Atteggiamento egualitario: la differenziazione dei ruoli fra genitori e
figli è minima. Atteggiamento permissivo: il giovane è libero di
ottemperare ai desideri dei genitori o di non tenerne alcun conto.
Numerose ricerche compiute negli Stati Uniti hanno preso in esame le
relazioni esistenti tra le pratiche educative adottate dai genitori e
alcuni aspetti della personalità e del comportamento adolescenziale,
quali l’autostima, l’indipendenza, la competenza e il senso di
identità.
I genitori democratici e autorevoli considerano importate sia
l’autostima sia la disciplina, incoraggiano gli scambi di idee e quando
esercitano il principio di autorità nella forma delle richieste e delle
proibizioni forniscono tutte le motivazioni necessarie. Questi
tentativi di legittimare l’esercizio dell’autorità sono molto
importanti, specialmente per i figli adolescenti che stanno
raggiungendo la maturità cognitiva e sociale e si preparano ad assumere
la responsabilità della propria vita.
 L’autorità
basata su di un ragionevole interesse per il benessere dei giovani
viene generalmente accettata di buon grado, mentre l’autorità
‘irrazionale’ , arbitraria, basata sul desiderio dell’adulto di
dominare l’adolescente viene respinta e produce sentimenti di collera e
in alcuni casi depressione. I genitori autoritari infatti non si
sentono in alcun modo obbligati a motivare le direttive che
impartiscono e considerano una virtù l’obbedienza cieca. In alcuni casi
questa posizione deriva da un senso di ostilità e dal rifiuto di
fornire spiegazioni. Gli adolescenti con genitori autoritari hanno meno
fiducia in sé stessi e non sanno pensare e agire da soli. Neppure i
genitori permissivi, che trascurano i figli o presuppongono un falso ed
esagerato egualitarismo, forniscono il tipo di aiuto di cui hanno
bisogno gli adolescenti. Alcuni lasciano che se la cavino da soli,
perché non sentono alcun coinvolgimento emotivo o perché non vogliono
occuparsene. L’autorità
basata su di un ragionevole interesse per il benessere dei giovani
viene generalmente accettata di buon grado, mentre l’autorità
‘irrazionale’ , arbitraria, basata sul desiderio dell’adulto di
dominare l’adolescente viene respinta e produce sentimenti di collera e
in alcuni casi depressione. I genitori autoritari infatti non si
sentono in alcun modo obbligati a motivare le direttive che
impartiscono e considerano una virtù l’obbedienza cieca. In alcuni casi
questa posizione deriva da un senso di ostilità e dal rifiuto di
fornire spiegazioni. Gli adolescenti con genitori autoritari hanno meno
fiducia in sé stessi e non sanno pensare e agire da soli. Neppure i
genitori permissivi, che trascurano i figli o presuppongono un falso ed
esagerato egualitarismo, forniscono il tipo di aiuto di cui hanno
bisogno gli adolescenti. Alcuni lasciano che se la cavino da soli,
perché non sentono alcun coinvolgimento emotivo o perché non vogliono
occuparsene.
Io non sono ancora madre, però penso che l’atteggiamento migliore tra
madre e figlio sia quello autorevole che stimola l’adolescente ad avere
più fiducia in sé stesso e quindi ad essere più autonomo.
|
|
|
|
LO SFOGATOIO
Pensieri autonomi
Qua nel
silenzio del mio appartamento, interrotto solo ogni tanto dal passaggio
di qualche macchina e dal ticchettio dell'orologio, mi rendo conto di
non avere più dei pensieri. Anzi, ce li ho, ma sfuggono nella mia mente
con la leggerezza di un soffio d'aria. Questi miei pensieri sfuggenti
non sono superficiali, ma contengono il peso della leggerezza che ho
dentro di me e così non mi danno il tempo di metterli su un foglio di
carta, perché già ne ho altri che li seguono. Sono pensieri autonomi,
che mi fan sembrare tutto superficiale e inutile, tanto che faccio
fatica a dare il giusto peso alle cose. A volte me la prendo troppo per
cose da poco e altre volte passo sopra a cose importanti. Con
quest'anima in subbuglio dovrei affrontare la lotta della vita, ma so
già che con un animo così perderò. Perché le lotte si fanno quando si
ha un animo calmo, capace di pensare a ciò che è meglio per riuscire a
vincere le battaglie. Così passo le mie giornate in solitudine,
rinchiusa tra queste quattro mura e ogni tanto mi ricade il peso sul
cuore di questa mia solitaria esistenza. Senza lavoro, senza amici,
solo una gatta che ogni tanto si sveglia per chiedere il suo tributo in
cibo. Sento ogni tanto il rimbombare dei passi pesanti di mia madre che
fa la scala e a volte spero che le venga la voglia di venirmi a
chiedere come sto, senza rinfacciarmi la mia dipendenza a lei. Ma
questa rimane solo una mia inutile fantasia, perché lei è una persona
troppo concreta per pensare che il mio abitare da sola non appaga la
mia voglia di autonomia. Tiro la cinghia fino allo stremo e, a volte,
faccio scelte che se potessi non farei, per dimostrare che adesso che
abito da sola ho acquisito almeno in parte un po’ di autonomia nel
vivere, ma soprattutto nel pensare, con la speranza sempre di essere
rivalutata e guardata per quella che sono, senza dovermi nascondere
dentro a un gioco di ruoli, come ho sempre fatto. Ma è arrivato il
momento in cui devo pagare di tasca mia l’errore di non essermi
costruita una mia autonomia per affrontare il mondo e le cose che
riguardano solo me ed essermi sempre affidata ciecamente agli altri.
Certo, era più comodo stare adagiata sulle cose, lasciare che gli altri
decidessero per me e non prendere in mano la mia vita. Fino a poco
tempo fa certe cose le delegavo agli altri perché non avevo voglia di
comprenderle. Ora che gli errori fatti dagli altri a nome mio si
ripercuotono sulla mia vita, ho intenzione di capire e di
distaccarmene, acquisendo una mia autonomia per gestirla a modo mio. A
me non hanno mai spiegato come si fa ad essere autonoma, perché chi mi
stava intorno aveva già deciso come dovevo essere, cosa dovevo pensare
e, a volte penso, che vita dovevo vivere. Sono sempre stata considerata
una ribelle perché sentivo quel richiamo di autonomia che era dentro me
e non mi faceva rientrare nei loro schemi. Schemi che ti facevano dire
solo sì, senza porti dei perché e se era giusto così. Ora ho trovato il
coraggio di non restare paralizzata dalla paura davanti alla vita e di
affrontarla con le mie idee, cercando nel profondo di me stessa quelle
doti che mi possono rafforzare e far sentire più sicura di me.
Man a mano che passa il tempo mi rendo conto di quanto sia difficile
conquistarsi un’autonomia e di quanto essa sia legata al lato venale
della vita. Credevo che l'autonomia e la libertà che ne consegue
fossero solo una questione mentale, ma scontrandomi con la vita reale
capisco che per me è stato solo un miraggio, visto che spesso dipendo
economicamente da mia madre, e su questo lei fa leva per tenermi ancora
al ‘guinzaglio’. Cerco di liberarmi da questo ‘guinzaglio’ per fare in
modo che la mia autonomia non sia solo la libertà di poter mangiare,
rientrare a casa o andare a dormire quando mi pare senza dover dare
spiegazioni. Voglio che la mia autonomia si sappia raffrontare con la
realtà della vita, facendomi mantenere la mia dignità personale, così
come deve essere nel senso più puro del termine: non dipendere da
nessuno. Per fare ciò rinuncio alle cose superflue e mi limito a ciò
che mi permettono i miei scarsi mezzi. Non mi importa fare dei viaggi,
ho un mondo dentro di me da esplorare. Le mangiate con gli amici, le
rimando ad altre occasioni. I vestiti alla moda… l'importante è che non
sono nuda (se no, sai lo schifo). E se il frigo ‘piange’ perché troppo
vuoto, che importa! Grassa come sono, un po’ di digiuno mi fa bene.
L'importante è che, per avere questo poco di autonomia, non debba
dipendere da nessuno per riconoscenza o sensi di colpa. Fare in modo
che il mio pensiero resti libero ed autonomo. Perché quando si ha un
modo di pensare libero e autonomo, si ha una personalità propria, non
facilmente intaccabile da quelle altrui e si arriva quasi a comprendere
qual è il senso della vera libertà.
Stefy
Non sono né Manzoni né Dante
Mi
piacerebbe sapere chi sono quelli che pensano che io son così
presuntuosa da credermi Manzoni o Dante! Han capito proprio poco di me
dalle mie parole che ho scritto! Se avessero capito qualcosa di me,
saprebbero che se ero Manzoni, Renzo e Lucia li avrei fatti divorziare
in malo modo già da un bel pezzo. E se fossi stata Dante, Beatrice
l'avrei messa all'Inferno a patire le sofferenze di chi non si sa
gustare il lato carnale dell'amore. A sua volta, Paolo e Francesca li
avrei messi in Paradiso, dove non avrebbero avuto dei rompiscatole che
facevano una tragedia per un bacio. Al Conte Ugolino facevo aprire una
macelleria, così sfruttava in modo costruttivo il suo peccato e a
Caronte facevo aprire un'agenzia di viaggi. Ma non sono né Manzoni né
Dante e non ho mai preteso di lasciare la mia impronta nella
letteratura! Solo esporre i miei pensieri, scritti in un italiano
decente per essere compresi. Ma d'altronde che italiano ci si può
aspettare da un'autodidatta che ha letto dei gran libri nel tempo che
aveva tra un bucato e una cottura di ragù? Con queste vostre
malelingue, voi non avete aperto il libro de L'Orlando Furioso, ma
scatenato la Stefania Incazzata! Vi dà fastidio che metta i miei
pensieri su un foglio di carta e non li lasci dissolvere nel vento come
voi? Siete dei Nobel per la Letteratura o qualche Premio Campiello per
potervi permettere di lanciare i vostri dardi? No, volete solo far fare
della ginnastica alla vostra linguaccia, che vi consiglio, per una
prossima volta, di piantarvela nel @#$% !!!
Stefy Avvelenata
|
|
|
LA NOTTE DI NOTE
 Giovanni Romagnani
Giovanni Romagnani
feedback a: romagnani.gio@gmail.com
Una lettera ad Angelo Fioritti
Rispetto
all'importanza del percorso biografico che secondo me ogni utente deve
fare, parto da un presupposto (asserzione di per sé vera ma
indimostrabile): nessuno vuole sentirsi dire di essere malato. Per il
mondo che c'è, profondamente ipocrita, nove volte su dieci è una
condanna definitiva. Permanente. Da cui lo stigma. Per chi ti incontra
- lo so sulla mia pelle, penso di essere uno degli utenti psichiatrici
più esposti di Bologna, compresa comparsata al TG3 Regionale - è
facile. Hai una categoria di appartenenza: ‘utente psichiatrico’. Nove
volte su dieci si perde il mistero. I mondi rimangono separati:
Normale/Non-Normale. Che poi volendo non vuol dire niente, perché nega
e non aggiunge. Io in genere me la gioco sulla curiosità, spostando
l'attenzione di chi mi ascolta o incontra su altre parti di me. Uso il
mio ruolo ‘utente psichiatrico’ come punto di partenza.
Ma non per tutti è così. Per molti è il capolinea. Per i motivi che ti
dicevo prima mi considero un privilegiato. In Pepoli mi conoscono
tutti. E l'essere utente psichiatrico mi dà sobri margini di bizzarria.
Paradossalmente diventa un vantaggio. Mi posso permettere uno scarto
percettivo. O un angolo di disagio, come ho scritto a Vincenzo Trono.
In cui fumo Marlboro. Però una sana biografia può andare sotto la
malattia, che spesso diventa una sub-personalità bilanciata dai
farmaci. Bisogna scavare ancora, essere malati non basta ! C'è di più,
c'è comunque di più.
La frequentazione di un gruppo di lavoro su Gurdjeff mi ha permesso di
capire anni fa l'importanza dei mondi sommersi. Dei nostri universi di
senso più reconditi. E l'importanza della meditazione. La pratico dal
1997. Se fatta bene ti permette di osservare i pensieri percependoli
come altro da te, senza identificartici troppo, o proprio per niente se
si è molto bravi. In questo senso il pensiero più nero può diventare
‘luciferino’, cioè portatore di luce. O rimanere semplicemente una
reazione chimica da non seguire. Per cui credo che la psichiatria debba
ritrovare l'immaginazione dell'utente portandolo al terzo occhio, che è
la sede della fantasia.
L'immaginazione, o kundalini in Oriente, ha rapporto con la storia
personale e soggettiva, la fantasia, o terzo occhio appunto, è invece
la sede della ‘ghianda dell'anima’, come dice James Hillman. È lungo il
percorso dell'immaginazione dalla caverna al superuranio, però la
scintilla della visione crea quell'intuizione di verità che solo la
meditazione può tenere in asse congiungendo il pensiero laterale con
l'estasi. Questo l'ho letto in Mircea Eliade.
Si parla di principio attivo degli psicofarmaci. Si dovrebbe parlare di
principio attivo del curriculum. Abbiamo parlato spesso dei buchi neri.
Periodi di pausa che non si riesce a motivare. In più. Una persona di
mia conoscenza, che non vuole essere citata ha accettato di svolgere
uno stage. Da quando l'ha finito, continue proposte di lavoro. Il suo
curriculum è tornato attivo. E non era un progetto Ausl.
Da qui l' importanza dell' IPS dove la figura del tutor è di profilo.
|
|
|
SULL’AUTONOMIA
 Laboratorio di Narrativa – RTP Casa Mantovani
Laboratorio di Narrativa – RTP Casa Mantovani
L’essenziale è invisibile agli occhi.
Antoine de Saint-Exupéry
Cos’è l’autonomia per noi? Libertà,
indipendenza, autostima, fiducia in sé stessi?Tutti questi concetti
sono fondamentali per ciascuno di noi per sentirsi vivi, persone
integrate a pieno nella società.
Concetto complesso quello dell’autonomia, abbiamo scelto una poesia sul
matrimonio di Kahlil Gibran e degli scrittori Betty Friedan e Antoine
de Saint-Exupéry, una frase per aiutarci a descrivere ciò che pensiamo:
Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:
Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.
Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.
Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,
Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.
Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,
Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.
E siate uniti, ma non troppo vicini;
Le colonne del tempio si ergono distanti,
E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.
Kahlil Gibran
Mariangela - L’autonomia è una cosa molto importante ed io sto
dimostrando di essere in grado di non dipendere sempre e di contare
sulle mie forze; non è facile ma le risorse sono dentro di noi e, a
volte, abbiamo solo bisogno di tirarle fuori. Altre volte abbiamo
bisogno di qualcuno che ci aiuti a vederle. Secondo me Gibran vuol dire
questo: abbiamo bisogno di un altro a noi vicino per diventare
autonomi.
Davide - Io sono molto attaccato di solito alla persona che amo,
però ho capito che se eccedo in queste cose riportate da Gibran
trasformo il mio legame, il mio sentimento, in un attaccamento morboso
che mi crea dipendenza. A volte ci attacchiamo troppo perché abbiamo
paura di perdere l’altro, ma se non mostriamo autonomia, forse, lo
perdiamo comunque.
Althea - Sono un’anima sola. Piacerebbe anche a me avere un
amore come quello descritto in questa poesia. Non so se riuscirò mai ad
essere autonoma.
Alessandro - Autonomia è aiutarsi e supportarsi nella reciprocità, ma bisogna mantenere la distanza.
È più facile vivere con qualcun altro che completare da soli sé stessi.
La libertà è una palla di piombo e pianificare la propria vita da soli
è spaventoso se non l’avete mai fatto prima.
Betty Friedan
Davide - La parola autonomo non significa non cercare gli altri
e fare tutto da sé. L’autonomia non deve essere un principio, ma
rispettare sé stessi.
Stefano - L’autonomia è libertà, ma non la si raggiunge se non si è responsabili.
Mariangela - Autonomia è vicinanza, ovvero supporto reciproco senza per forza essere in simbiosi.
 Gli uomini», disse il piccolo principe, coltivano cinquemila rose nello
stesso giardino... e non trovano quello che cercano... e tuttavia
quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po'
d'acqua... ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore.
Gli uomini», disse il piccolo principe, coltivano cinquemila rose nello
stesso giardino... e non trovano quello che cercano... e tuttavia
quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po'
d'acqua... ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore.
Antoine de Saint-Exupéry
Althea - Bisogna aver chiaro quali sono i propri obiettivi ed i propri bisogni altrimenti tutto, compresa l’autonomia, è vano.
Elisa - Avere autonomia e avere libertà è importante, ma è
terribile non avere la capacità di guardare nel proprio cuore. Non è
autonomia essere nell’irrequietezza che porta ad andare sempre alla
ricerca di qualcosa che non c’è. Autonomia è vicinanza. Stiamo vicini
autonomamente.
Giorgia - Io non riesco a pensare alla mia vita, autonoma e
felice, senza la vicinanza e il supporto delle persone a cui voglio
bene. Io non mi sento più fragile se chiedo aiuto. L’autonomia, intesa
come “faccio tutto da me e non ho bisogno di nessuno” è, in realtà, una
delle bugie più grandi del nostro secolo.
SCRITTURA DI GRUPPO SULL’AUTONOMIA
Il destino è l’insieme complesso di condizioni, storie e desideri che
si intrecciano e che determinano il nostro essere persone.
La nostra vita è costituita dai legami che creiamo, dalle relazioni che
stabiliamo con il mondo e da come ci collochiamo in esso.
L’autonomia non è una lotta con la nostra debolezza: è frutto di
mediazioni, di accettazione di fragilità, di ricerca di felicità che
non ci pongono necessariamente nella condizione di essere dipendenti
dalle relazioni, affetti con i quali condividiamo la nostra vita.
I legami non sono un limite, ma una forza! In tal senso, per noi,
l’autonomia non esiste… è un concetto troppo astratto… esiste la
libertà di incontrarsi.
I Narrativi
|
|
|

L’AUTONOMIA: PARLIAMONE
 Associazione UmanaMente
Associazione UmanaMente
Brainstorming
Cosa significa e cosa viene in mente con la parola autonomia?
Antonio:
la parola autonomia può significare uno stato emotivo della nostra
quiete, di vivere liberamente i nostri pensieri, le nostre parole i
nostri sentimenti, i nostri sensi. È il motore che ci consente di fare
le cose.
Oriano:
l’autonomia la ricollego subito ai libri, al mio essere autonomo
nell’andare in biblioteca e poter scegliere tutti i libri che voglio da
leggere.
Maurizio:
per me autonomia significa essere indipendenti,
realizzare quello che ti piace fare, senza bisogno di aiuti e di
consigli, fare quello che piace in libertà.
Tiziana:
l’autonomia per me sarebbe il poter vivere senza dipendere da nessuno.
Sia economicamente sia riguardo alla salute, senza dover essere
ricoverati.
Antonio:
secondo me l’autonomia è agire in libertà senza
obblighi e catene. Nella vita non dobbiamo avere vincoli e farci
mettere al muro per essere giudicati. La libertà è sempre un perdono
che serve a non far ripetere gli sbagli.
Nadia:
a me la parola autonomia ricorda la mia nuova vita, libera dalla
schiavitù della depressione e capace di vivere da sola, di essere
indipendente e riuscire ad essere felice.
Yon:
autonomia è vivere da solo, non dipendere da nessuno, essere autonomo in tutte le cose che vuoi fare.
Antonella:
autonomia è libertà prima di tutto. L’autonomia è
il polo opposto della dipendenza. Un insieme di autonomie dove l’ideale
sarebbe di vivere in una società di libertà e autonomie. A volte il
'voglio fare' può essere anche una trappola.
Stefano:
l’autonomia a me fa venire in mente il movimento di
Autonomia operaia, movimento contro i padroni che schiavizzavano gli
operai. È un movimento politico sindacale degli anni ’70.
Antonio M.:
autonomia si collega a noi giovani soprattutto.
Al giorno d’oggi chi fa esperienza lavorativa, scolastica e sportiva di
vario genere, mano a mano cresce e raggiunge un’autonomia e si pone
degli obiettivi che vuole raggiungere nella vita. Solo una persona
matura può raggiungere una certa autonomia nella vita. Fare esperienze
aiuta ad essere autonomo.
Che cos’è l’autonomia e che cosa è la libertà?
Maurizio:
la libertà è quello che fai senza vincoli,
l’autonomia è più ristretta perché quando devi fare una cosa sei libero
però rispettando delle regole. La libertà è una cosa assoluta,
l’autonomia è una libertà più limitata.
Oriano:
l’autonomia è una sorta di autogestione. Anche se non è un termine appropriato.
Tiziana:
la libertà è una cosa che vogliamo tutti, ma l’autonomia non tutti la vogliono.
Maurizio:
è più stretta l’autonomia. Uno che ha avuto una malattia tipo il
Parkinson o la sindrome di Dawn può essere libero ma non autonomo.
Quindi la libertà non sempre coincide con l’autonomia.
Tiziana:
in carcere si perde la libertà ma si rimane autonomi.
Antonio:
la libertà alla fine è una croce di cui hai portato
il peso fino alla fine e poi ti riposi e sei in libertà, mentre
l’autonomia è stare senza obblighi e catene. Sono tutte le cose che
fai, che riesci a realizzare nell’ambito della tua vita: portare a casa
il pane… se non ti vuoi sposare, è un po’ un casino, perché non si sa
bene come fare.
Nadia:
per quella che è la mia esperienza di vita non avere
autonomia è non avere libertà. Ho avuto un compagno per venticinque
anni che mi faceva da infermiere, e quando non è stato più così ho
trovato la mia libertà e la mia autonomia. Libertà e autonomia
coincidono. Io non pensavo di essere autonoma, adesso sono felice, sono
libera.
Yon:
Puoi essere libero, ma non essere autonomo. Libertà è
quasi autonomia, si può essere liberi e non autonomi. Io adesso sono
libero, ma non autonomo, dipendo da mia madre economicamente.
Antonella:
la libertà è un valore di tipo più ideale, mentre
l’autonomia e da vedere più nella vita concreta. Si può essere liberi
interiormente ma non ancora in grado di reggersi autonomamente e
prendersi delle responsabilità.
Stefano:
per essere autonomo devi avere un lavoro per pagare
l’affitto, le bollette e la spesa. Io non posso permettermi di farmi
mantenere da mio padre. La libertà non è bere birra o fare qualche
altra cosa. È poter viaggiare il più possibile. Non il viaggio mentale,
ma con l’aereo.
Antonio:
per me ci sono due tipi di autonomia: una economica
e una del carattere. Autonomia e libertà sono cose diverse anche se
possono andare in parallelo e arrivare a coincidere. la libertà è più
morale e simbolica. Ci si illude di aver raggiunto la libertà, ma è
un’illusione. Noi siamo dentro un sistema e non è possibile essere del
tutto liberi, puoi però pensare di esserlo, ma è solo un concetto
astratto. Non si può essere completamente liberi dai vincoli della
società.
RIFLESSIONI SULL’AUTONOMIA
 Alessandro Falcone
Alessandro Falcone
Non c’è amore sufficientemente capace di colmare
il vuoto di una persona che non ama sé stessa
Irene Orce
Che cos’è l’autonomia, se non l’eterna
sfida nella quale il nostro avversario non è qualcun altro, ma noi
stessi? L’autonomia è una conquista, che ogni persona acquisisce
proseguendo per il tortuoso sentiero della vita attraverso le sue fasi
evolutive ed educative. Nessuno può dire di conoscere l’autonomia
appena nato. Quando si nasce, di ‘autonomo’ abbiamo il sistema nervoso,
che autonomamente modula le nostre attività fisiologiche. Le persone,
come altri animali, sono nate in un mondo che non hanno creato, che non
controllano. Dopo un periodo passato nel grembo materno, durante il
quale i bisogni vengono automaticamente soddisfatti, fanno ingresso nel
mondo. I bambini arrivano nel mondo in una condizione di impotenza, di
dipendenza. Autonomia significa essere e la modalità dell’essere ha,
come prerequisiti, l’indipendenza, la libertà e la presenza della
ragione critica. Essere significa diventare, ovvero dare espressione
alle proprie capacità e facoltà, alla molteplicità di doti che ogni
essere umano possiede. Ciò richiede volontà e passione,
autodeterminazione per orientare il proprio comportamento
nell’affrontare positivamente il mondo circostante. Se cerco
all’interno del vocabolario di psicologia il termine ‘autonomia’ lo
trovo affiancato al termine ‘eteronomia’: “Polarità di termini,
autonomia-eteronomia, che designano rispettivamente la condizione di
chi ha la norma del proprio comportamento in sé (autonomia morale) e in
altri (eteronomia).
La psicologia evolutiva con Piaget distingue tre fasi: ‘anomia’, dove
il proprio punto di vista è assunto come unico, senza alcuna
considerazione dei punti di vista altrui; ‘eteronomia’, dove il valore
delle azioni risiede nell’autorità di chi le prescrive; ‘autonomia’,
dove ha luogo l’interiorizzazione dell’obbligo e la consapevolezza
delle esigenze altrui.
Vi sono diversi tipi di autonomia: quella personale, con cui si intende
lo sviluppo e il mantenimento di tutta una serie di abilità che danno
all’individuo la possibilità di autogestirsi durante l’arco della
giornata (igiene personale, sapersi vestire, cucinare, mangiare
autonomamente). Collegata ad essa vi è l’autonomia domestica, che
consiste nell’abituarsi a vivere adeguatamente nella propria casa,
collaborando nelle faccende domestiche, riconoscere e soddisfare le
proprie necessità. L’autonomia operativa corrisponde all’indipendenza
prassica e lavorativa. Al completamento dell’adolescenza è importante
riuscire ad ‘arrangiarsi da soli’. Essere indipendenti significa saper
gestire e risolvere i problemi che la realtà pone di volta in volta,
avere capacità di organizzazione, di orientamento e ri-orientamento,
raggiungere una sufficiente autonomia economica.
Naturalmente vivere una vita autonoma non significa non chiedere mai
aiuto, ma significa soprattutto riconoscere i propri limiti e saper
chiedere aiuto quando da soli non ce la facciamo, saper chiedere
un’informazione quando siamo per strada: questa autonomia viene
chiamata sociale. L’autonomia intellettiva corrisponde alla capacità
critica: saper giudicare, confrontarsi, mettere e mettersi in
discussione, avere opinioni e convinzioni fondate sulla realtà, la
società, la storia.
Lo sviluppo dell’autonomia affettiva avviene fin dai primi mesi di vita
nel rapporto con la madre, quando il bambino vive in simbiosi ed è
completamente dipendente. Winnicot, introduce l’idea della capacità del
bambino di “essere solo in presenza della madre”, per cui è gli
possibile passare dalla simbiosi allo sviluppo di un senso di sicurezza
di sé anche in assenza della madre, in quanto figura interiorizzata
come sufficientemente buona. Una volta assunta questa sicurezza
dell’ambiente esterno il bimbo può rilassarsi e volgere lo sguardo
internamente, scoprendo la propria vita personale, sviluppando progetti
affettivi e sessuali. Sentirsi come figure separate, e quindi autonome,
implica un livello intrapsichico dove vi sia un lavoro di elaborazione
della separazione e della solitudine. Si prende consapevolezza che la
realtà non è troppo pericolosa o minacciosa, che può essere gestita e
controllata, ci si può sentire sicuri di sé e non avere paura
dell’altro. Questo rappresenta l’autonomia psicologica. La vita è
costituita da tappe: infanzia, adolescenza, adultità. Nell’infanzia
nessuno si aspetta che il pargolo sia già autonomo, e nell’adultità vi
è l’esigenza di essere autonomi. Ma è nell’adolescenza che si sviluppa
un senso interno di autonomia e la formazione del carattere,
acquisizione di un sé stabile, perdita di forza della moralità edipica;
maggiore stabilità di autostima e minore dipendenza dalla realtà
oggettuale.
Per essere autonomi e quindi indipendenti bisogna saper accettare la
dipendenza. Ognuno di noi è dipendente in qualche misura dagli altri,
tutti noi abbiamo bisogno di approvazione, empatia, conferme e
ammirazione da parte degli altri, per sostenerci e per regolare la
nostra autostima. La vera indipendenza non è possibile e nemmeno
auspicabile. Quando la dipendenza non è sana, la persona non è in grado
di prendere delle decisioni da sola, ha un comportamento sottomesso
verso gli altri, ha bisogno di rassicurazioni e non è in grado di
funzionare se non vi è qualcuno che si prende cura di lei.
L’AUTONOMIA DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO
 Maurizio Scarabanti
Maurizio Scarabanti
Il concetto di autonomia secondo il
diritto pubblico viene storicamente posto all’epoca della nascita degli
ordinamenti comunali, corporativi, monarchici. Da questi ultimi nacque
il concetto del rex in regno suo est imperator che è la prima definizione dell’autonomia.
La moderna teoria generale distingue un’autonomia normativa, una
istituzionale, e una organizzatoria: la prima consiste nel potere
riconosciuto ad enti non sovrani di emanare una propria normativa. La
seconda, assai discussa e dubbia, comprenderebbe le varie ipotesi di
relazione tra ordinamenti giuridici, avente lo scopo di stabilire il
grado di autonomia di ciascuno rispetto agli altri. L’ultima è un
semplice rapporto di organizzazione intercorrente tra soggetti.
Le autonomie sono raggruppabili in due categorie: le autonomie
pubbliche e quelle dei privati. Le prime sono quelle politiche e quelle
proprie degli enti pubblici non territoriali e degli enti locali. Le
seconde sono quelle degli individui ovverossia le cosiddette libertà
civili, o dei diritti inviolabili dell’uomo. Questi diritti sono
sanciti e tutelati nei primi articoli della prima parte della nostra
Costituzione, come l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,
secondo l’art.3, la libertà di pensiero, di religione, di domicilio, di
circolazione eccetera.
La Costituzione Italiana attualmente vigente fissa all’art.5 il
principio fondamentale dell’autonomia e del decentramento alle cui
esigenze la Repubblica deve adeguare i principi e i metodi della sua
legislazione. In pratica la Repubblica Italiana è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato, ente supremo. Questi sono riconosciuti come enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni. Sono dotati di un'autonomia
legislativa, patrimoniale, concessa loro dallo Stato per realizzare i
loro fini, e finanziaria, potendo imporre autonomamente dei tributi
sempre però nei limiti percentuali stabiliti dallo Stato stesso. Dalla
nozione di autonomia che risulta dal contesto politico-costituzionale,
che riconosce al pari dello Stato pubblici poteri esercitati dagli enti
o autonomie territoriali locali, si contrappone il principio del
decentramento, secondo il quale gli uffici degli enti locali di
maggiore dimensioni debbono essere geograficamente dislocati nel luogo
più vicino alla fruizione dei servizi da parte dei cittadini.
In linea generale, con l’espressione autonomia si vuole indicare un
determinato grado di libertà e indipendenza di un soggetto
nell’esercizio di determinate attività politiche o giuridiche.
C’è un’autonomia negoziale che è una specificazione del più generale
principio dell’autonomia privata, che è il potere dei privati di
autoregolamentazione dei propri interessi e rapporti patrimoniali
mediante negozi giuridici (art 1322 c.c.).
Il concetto di autonomia privata è di difficile definizione.
Nell’accezione filologica la parola autonomia deriva dal greco e
significa darsi delle regole, impegnarsi, autovincolarsi. Di qui, la
definizione di autonomia privata come sinonimo di ‘libertà di
contrarre’. Un concetto correlato a quello di ‘negozio giuridico’, che
non riguarda solo il settore privato ma anche quello pubblico quindi di
natura ibrida, riconducibile nell’area dello ius commune.
Secondo il diritto privato avere autonomia significa essere un soggetto
titolare di diritti e obblighi ovvero una serie di situazioni
giuridiche soggettive attive e passive. Ne sono titolari persone
fisiche, alle quali è attribuita la capacità patrimoniale e negoziale,
e giuridiche, cioè le associazioni riconosciute e non e le società. Il
riconoscimento delle associazioni deve essere richiesto al Presidente
della Repubblica nella forma di un atto pubblico mentre per la seconda
categoria è solo previsto il contratto quale elemento costitutivo
dell’associazione. Non è esclusa la possibilità della stipulazione del
contratto di adesione preparato dai soggetti preparatori
dell’associazione e sottoscritto da coloro che vogliono aderire
all’associazione stessa.
L’autonomia patrimoniale è il grado di separazione del patrimonio di un
soggetto rispetto a quello di altri soggetti. Il patrimonio di quel
soggetto è detto patrimonio autonomo.
L’autonomia patrimoniale si distingue in perfetta o imperfetta a
seconda che il patrimonio sia o meno vincolato da vicende ad esso
variamente collegate. Per esempio le società di persone godono di
un’autonomia patrimoniale imperfetta, perché il patrimonio dei soci
risponde anche dei debiti della società, mentre le società di capitali
godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, perché rispondono solo
dei debiti della società con il suo patrimonio. Un’autonomia
patrimoniale imperfetta si riscontra in quelle società di persone in
cui i soci rispondono delle obbligazioni sociali illimitatamente e
solidamente, mentre i creditori particolari dei soci non possono agire
sul patrimonio sociale. Si tratta delle società in accomandita
semplice, nelle quali sono solo i soci amministratori della società a
rispondere delle obbligazioni sociali illimitatamente e solidamente.
Nelle associazioni riconosciute l’autonomia patrimoniale è perfetta
mentre in quelle non riconosciute è imperfetta.
AUTONOMIA IN PSICOLOGIA DEL LAVORO
 Fiorinto Scirgalea
Fiorinto Scirgalea
Per autonomia in generale s’intende la
possibilità per un soggetto di svolgere le proprie funzioni senza
ingerenze o condizionamenti da parte di terzi. La dimensione
dell’autonomia nella psicologia del lavoro è legata al bisogno di
partecipare alla formulazione degli obiettivi del proprio lavoro, ossia
alla possibilità di determinare autonomamente opzioni differenti per il
loro raggiungimento, nei limiti degli obiettivi e funzioni più
generali. Questa dimensione fa dunque riferimento alla fase di problem
setting, nella quale deve essere il lavoratore a definire il quadro
decisionale entro cui dovrà svolgere il suo lavoro materiale. Un lavoro
per il quale è predeterminato l’obiettivo produttivo da raggiungere, ma
anche i tempi e le modalità procedurali da utilizzare a tal fine, ossia
un lavoro che non ammette discrezionalità, risulta dunque di bassa
qualità in termini di autonomia. L’autonomia porta a una migliore
produttività soprattutto quando il lavoro è complesso e richiede
creatività. Ma anche in un lavoro basato sulla routine, sebbene
l’autonomia non riesca ad avere molto impatto sulla produttività, può
comunque aumentare la soddisfazione, il che porta ad altri risultati
positivi. Quando la direzione aziendale prende decisioni su come
organizzare il lavoro, deve sempre tenere presente l’effetto positivo
dell’autonomia sulle persone.
La libertà nelle scelte può assumere forme diverse: i responsabili
possono consentire ai dipendenti di impostare i propri programmi, di
scegliere come fare il loro lavoro o anche di lavorare da casa. Non
importa come viene definita l’autonomia, quando le persone sentono di
avere libertà di scelta i risultati sono impressionanti. I potenziali
benefici sono un maggior rispetto dei propri impegni, migliori
prestazioni e maggiore produttività. Il concetto di autonomia, però,
varia da cultura a cultura: ciò che le persone di un determinato paese
percepiscono come libertà sul posto di lavoro, può essere invece intesa
da soggetti di altre culture come semplice disorganizzazione.
Non esiste una ricetta unica di autonomia lavorativa. Per esempio, in
alcune culture, i responsabili non possono chiedere il parere ai propri
subalterni, perché questo li farebbe apparire deboli. E così i manager
in questi ambienti devono trovare altri modi per far sentire i
lavoratori autonomi.
UN LAVORO DI SCRITTURA CREATIVA
ESERCIZI, RACCONTI, INTERVISTE, CONDIVISIONI
Introduzione
Autonomia e mezzi di trasporto sono legati
concettualmente, perché i mezzi di trasporto consentono l’autonomia.
Avere la possibilità di spostarsi e muoversi in libertà vuol dire avere
autonomia. I mezzi di trasporto sono tanti, dai più semplici come lo
skate fino all’aeroplano e all’astronave. Anche i mezzi di trasporto
hanno una loro autonomia da considerare, come l’automobile: se buchi
una gomma o finisci la benzina, l’autonomia termina.
 Autore: Oriano
Autore: Oriano
Scelta dell’immagine: motorino
Scelta dell’età: vent’anni
Poemi di Oriano
Mi chiamo Oriano e ho vent’anni. Mi piace molto il motorino. Ho
lasciato Clara. Clara era la mia musa: mi ha ispirato tante poesie.
Adesso ho smesso di scrivere. Panta rei (tutto scorre)! Ho intenzione
di scrivere un poema. Amo questo momento perché mi sento autonomo. Il
mio connubio è questo: libri e amore.
Autore: Nadia
Scelta dell’immagine: motorino (su ispirazione dello scritto di Oriano)
Scelta dell’età: tredici / quattordici anni
Finalmente il motorino
Mi chiamo Nadia ho tredici anni vivo
due kilometri fuori dal paese. Ogni volta che devo incontrarmi con i
miei amici devo usare la bici o farmi accompagnare da mio padre in
auto. Finalmente, compiuti i quattordici anni, i miei genitori mi
comperano il motorino. Ora lo uso per andare dappertutto e sono
veramente autonoma.
 Autore: Antonio
Autore: Antonio
Scelta dell’immagine: pullman
Scelta dell’età: ventun’anni
Lo scuolabus
Sono Antonio ho ventun anni guido il pulmino
della scuola materna di Bologna da tre anni e presto servizio alla
Cosepuri dove si prende un buono stipendio. Sono contento di questo
lavoro perché è un mestiere che dà molte soddisfazioni. Mi piacerebbe
avere un camion per conto mio per lavorare nelle cave di terra. Lavo
autonomamente il pulmino ogni venerdì della settimana, dopo di che
riposo sabato e domenica e sono pronto per ritornare lunedì a lavorare.
Maurizio intervista Antonio sul suo scritto
Dove vorresti andare con il pulmino?
Io vorrei con il
pulmino della Cosepuri portare i ragazzi della terza istituto tecnico
di agraria Serpieri al museo delle piante e delle erbe aromatiche a
Granarolo nell’Emilia. Nei pressi di tale luogo c’è la fabbrica della
Granarolo latte. Farei una piccola sosta pranzo al sacco per poi
ritornare nel pomeriggio tardi per riaccompagnare i ragazzi a casa.
Perché il tuo pulmino rappresenta un'autonomia?
Il mio pulmino Leoncino, lo ritengo un mezzo di trasporto con molta
autonomia: ha il vantaggio di consumare poco pur avendo un serbatoio di
molti litri di carburante per fare tanta strada.
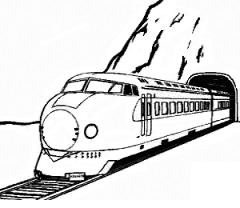 Autore: Nadia
Autore: Nadia
Scelta dell’immagine: treno
Scelta dell’età: diciott’anni
(Nome: Arianna)
Il primo viaggio
Ricordo la prima volta che ho preso il treno
da sola. Avevo appena compiuto diciotto anni e sono andata a Milano a
trascorrere due giorni con una cara amica conosciuta durante le vacanze
marine. Mi ha accompagnato la mamma, che quando mi ha visto salire i
gradini del treno si è visibilmente commossa. In quel momento mi sono
sentita come non mai: ho capito che ero cresciuta e che in quel momento
stavo conquistando un’importante fetta della ‘torta’ della mia
autonomia. Mi sono sentita felice di essere diventata grande e in grado
di viaggiare da sola.
Autore: Oriano
Scelta dell’immagine: treno (su ispirazione dello scritto di Nadia)
Scelta dell’età: adulta
Il nichilismo ferroviario
Sul treno ho conosciuto una
ragazza. Abbiamo parlato di filologia classica. Era una ragazza
logorroica. I suoi occhi erano azzurri. Con lei mi sono sentito libero.
Mi ha ispirato tante poesie. Mi sono sentito autonomo perché non mi
censurava per quanto riguarda la dialettica. Il treno mi ha ispirato
anche dei poemi. Sono autonomo perché sono un nichilista.
 Autore: Maurizio
Autore: Maurizio
Scelta dell’immagine: bicicletta
Scelta dell’età: quindici anni
La mia inseparabile bicicletta
È una giornata di sole. Come
al solito dopo aver guardato fuori dalla finestra, mi sono vestito per
andare a fare una passeggiata in bicicletta, la mia bicicletta alla
quale sono affezionato fin da piccolo. Scendo in cantina per andare a
prenderla ed esco di casa. Monto in bicicletta, faccio una
scampanellata forte cosi che tutti mi sentono ed inizio ad attraversare
i campi sudando sotto il sole. Arrivo in una fattoria dove faccio una
piccola siesta, bevendo un bicchiere di vino per ristorarmi un poco e
pronto per ritornare a casa felice di avere fatto una passeggiata con
la mia inseparabile bicicletta.
Antonio intervista Maurizio sul suo scritto
Cosa fai con la tua bicicletta? Io con questa bicicletta alla
quale sono molto affezionato vado in campagna per trovare mio fratello
che mi aspetta da molto tempo... Quando sono andato a trovarlo ho fatto
un suono con il campanello e mio fratello mi è corso incontro
abbracciandomi e dopo avermi chiesto come stavo, perché ero molto
sudato, mi ha dato da bere e da mangiare e ci siamo raccontati un po’
di cose. Poi nel pomeriggio sono rimontato in bicicletta per ritornare
a casa contento di avere rivisto mio fratello dopo tanto tempo.
Perché è il tuo mezzo di locomozione? Per me la bicicletta
rappresenta un’autonomia perché mi permette, montandoci sopra, di fare
un po’ di fatica ma poi di essere contento di essere arrivato dove
volevo, anche se per arrivarci ho sudato un po’.
 Autore: Davide
Autore: Davide
Scelta dell’immagine: vespa
Scelta dell’età: quattordici anni
Una storia di autonomia
Ho quattordici anni e il mio
desiderio più grande è comprarmi quella vespa che mi piace tanto, ma i
miei mi hanno detto che se la voglio devo lavorare quando non studio…
Così io me la sono comprata col lavoro estivo e questo mi ha aiutato ad
essere più indipendente, poter girare dove voglio senza problemi di
trasporto. Penso che questo sia un primo passo verso l’autonomia.
 Autore: Jon
Autore: Jon
Scelta dell’immagine: macchina
Scelta dell’età: vent’anni
Ora vado al lavoro in auto
Sono Stefano, ho vent’anni, da due
ho preso la patente e adesso sto lavorando. Il lavoro è lontano da
casa, così con la macchina sono autonomo nel recarmi al lavoro, mentre
prima ci andavo in autobus. Adesso che ho il lavoro sono riuscito a
comprarmi la macchina e mi sento più autonomo di prima. Penso che
l’autonomia sia molto importante, adesso mi sento più libero di poter
fare altre cose. Come ad esempio di poter fare la spesa al supermercato
più grande e lontano da casa.
|
|
|
L’AUTONOMIA
 Centro Diurno di Casalecchio di Reno
Centro Diurno di Casalecchio di Reno
L’autonomia
è la libertà del fare. Quando si è autonomi si possono decidere le cose
senza che nessun altro si intrometta… si può rimanere sé stessi. Nei
rapporti con gli altri si decide liberamente che cosa fare. Io mi
ritengo abbastanza autonomo, sicuramente lo sono nelle piccole attività
quotidiane (andare a fare la spesa, pulire la casa, guidare la macchina
e andare dove voglio…); potrei esserlo di più nel fare conoscenza con
gli altri, ma mi sono chiuso. Vivo una sorta di handicap sociale: la
mia paura nel rapportarmi agli altri e il disagio nel conoscere nuove
persone, legati anche al mio carattere, mi limitano nella mia
autonomia… è come se avessi una autonomia non vissuta. Desidererei
essere più disinvolto nel conoscere gli altri, anche se scelgo spesso
di rimanere solitario e in questo mi sento autonomo.
L’autonomia è la realizzazione piena delle proprie aspirazioni senza un tramite.
M.
L’autonomia è vivere per degli ideali veramente autentici e tradurli in
pratica… Vorrei realizzare il mio desiderio di mettermi in contatto con
gli altri mentre spesso non riesco a convertire il ‘dire’ in ‘fare’ ed
è questo il più grave ostacolo nella comunicazione con le altre persone
e in definitiva un ostacolo alla mia autonomia; vorrei maggiormente
prendere in considerazione che viviamo in un tessuto sociale a cui
siamo vincolati, mentre spesso vivo da eremita in mezzo agli altri. Nel
mio passato sono stato circondato da varie presenze (alcuni familiari e
altre persone esterne alla famiglia) che avevano la pretesa di aiutarmi
a raggiungere una maggiore autonomia e che, invece, hanno posto le
premesse per una forma di ‘schiavitù’, limitando proprio l’essenza
della reale autonomia. Sollecitato con coercizione a studiare, sono
diventato una persona culturalmente e scolasticamente che sa un po’ di
tutto ma in maniera alquanto confusionaria… una persona frustrata e
disadattata. Mi hanno fatto un immenso dono, costituito da un involucro
maestoso, ma che ha racchiuso una misera sostanza. Credo che la
malattia abbia inficiato la mia autonomia e allo stesso tempo che
un’autonomia ben guidata avrebbe potuto scongiurare la mia malattia e
permettermi di comunicare di più con gli altri.
G.
Economicamente parlando, l’autonomia si realizza
con una certa autogestione del proprio lavoro in una qualunque impresa,
statale o privata che sia. Più genericamente l’autonomia si può
ottenere attraverso l’apprendimento di concetti differenti: l’uomo è
certo un animale che è determinato dall’istinto, ma è soprattutto un
animale cosiddetto ‘di cultura’, non solo il frutto della genetica, ma
anche autosufficiente per mezzo di quello che apprende. Per me
l’autonomia deriva dall’apprendimento di nozioni che mi rendono appunto
autosufficiente, perché imparando molte nozioni posso superare i limiti
ereditari e quindi emanciparmi dal passato. L’uomo, a differenza delle
altre specie animali, può superare le sue caratteristiche genetiche
grazie all’apprendimento di molte informazioni.
L.
|
|
|
|
COS’È PER I VELISTI L’AUTONOMIA
L’autonomia per me è essere autonomi dai familiari, farcela nei bisogni quotidiani, autonomia nell’abitare.
Paradosso: autonomia è poter decidere insieme agli altri.
La
considero in tre ambiti: medico- l’opportunità lontana di gestire la
malattia non dipendendo dalle strutture; economico- condurre la propria
vita senza aiuti esterni; relazionale- la capacità di stare da soli
senza cadere in depressione.
Autonomia: non solo agire da sé, muoversi indipendentemente e
liberamente, non solo indipendenza economica ma da tutto ciò e, dalle
relative conseguenze, anche e soprattutto la possibilità e capacità di
esteriorizzarsi, guardarsi allo specchio e assumere fiducia e
consapevolezza della propria espressione fisica ed emotiva, sia
‘positive’ sia ‘negative’.
|
|
|
LA STORIA DI ASDRUBALE
 Alberto Melega gruppo La Vela
Alberto Melega gruppo La Vela
A
sdrubale partì per la strada di briciole, era una notte carica di
comete nel cielo e il cane della torre del castello si era perso in un
bicchier di vino.
Così, solo perché lo voleva il destino, procedeva nei secondi del tempo
per vedere il mondo come non lo aveva mai visto. Giunto ad una casa
fatta di petali di fiori incontrò la regina dei pomodori che gli
raccontò una storia molto strana di mostri e sottane. Stupito e curioso
rise per due ore del mondo e della luna poi si nascose per un po’ sotto
una pietra gialla ad aspettare le nuvole che passavano. Gesti di gioia
di due gatti dispettosi e pioggia saltellante lo destarono per
proseguire il cammino. La strada era bella come un fiocco di ragazza e
sembrava portare al tempo che non poteva più fuggire! Oh mia realtà,
disse, se non cambi per seguire le briciole sarai sempre come un
palloncino che fugge nel cielo... Voleva un mondo conquistato dai poeti
e ogni attuale sopruso sarebbe stato ripagato… Asdrubale era un tipo
strano, portava le emozioni come pillole contro il male di vivere, e
proprio una vipera gli si parò davanti. Con una voce simile a un sibilo
il serpente iniziò a parlare. Gli chiese se aveva paura e Asdrubale
rispose di sì. “Io sono colui che porta il veleno del male degli esseri
viventi. Non troverai nessuno disposto a passare nel mondo con me, mi
cibo anche di topi e della paura della gente”, disse la vipera e
Asdrubale rispose: “I topi, i topi …. e la paura di affrontare il mondo
con il carattere necessario per reggere la pressione di tutto ciò che
esiste, e l’inadeguatezza, proprio come se un timore di non riuscire a
farcela ci invada senza scusa… Sì, proprio tutto ciò, non è la strada
di briciole e tu vipera dell’inferno, scompari dalla mia strada”. Il
serpente strisciò via lentamente, la strada fu di nuovo libera e
Asdrubale cominciò a camminare e pensare. Si chiedeva chi fosse
veramente e se mai un giorno quel velo di oscurità che il serpente gli
aveva lasciato sarebbe scomparso. Quello era il veleno di vivere, lo
sconforto di un'esistenza senza centro, la disperazione di scommettere
sulla vita senza emozioni e carte da giocare. Quello no, non doveva
lasciare il segno, ed era la strada con tutto il suo ovvio fascino che
lo chiamava. Ma pensò che la strada era come un racconto, la vita
rimane come una casa che deve essere vissuta. Si era perso nella
concretezza, che è ciò che rimane e fa della realtà una sequenza di
esistenze pietrificate, pesanti, bloccate ed effettivamente senza
libertà, ma ciò che esiste, esiste per davvero e l’insoddisfazione non
era un capriccio di bambino. Forse il motivo per esistere non esisteva
proprio, ma Asdrubale camminava ed era leggero come un sorriso.
|
|
|
|
|
|
|
LA “FASE 1” DELL’IPS
OSSIA LA FASE DI RICERCA DEL LAVORO: PROPOSTE PER UN’INDENNITÀ
 Mario Mazzocchi presidente di Nessuno Resti Indietro
Mario Mazzocchi presidente di Nessuno Resti Indietro
 L
’IPS (Individual Placement and Support,
ossia supporto al collocamento individuale) è, fra tutti gli altri,
quello che a più pieno titolo può definirsi “Percorso di inserimento
lavorativo”. Gli altri percorsi (tirocini formativi, tirocini
inclusivi, corsi di formazione) hanno finalità formative o
socio-riabilitative e, almeno di norma, non aprono la strada a veri
contratti di lavoro.
L
’IPS (Individual Placement and Support,
ossia supporto al collocamento individuale) è, fra tutti gli altri,
quello che a più pieno titolo può definirsi “Percorso di inserimento
lavorativo”. Gli altri percorsi (tirocini formativi, tirocini
inclusivi, corsi di formazione) hanno finalità formative o
socio-riabilitative e, almeno di norma, non aprono la strada a veri
contratti di lavoro.
Questo va premesso perché sia chiaro che, come associazione, noi
apprezziamo l’impegno che il Dipartimento si è assunto per inserire
l’IPS fra i percorsi d’inserimento lavorativo; anzi, non lo ha solo
inserito fra gli altri, lo sta anche promuovendo come il principale e
più evoluto fra essi.
Tuttavia, l’IPS ha una criticità che può impedire a certuni di
intraprenderlo, oppure può imporre loro di abbandonarlo una volta che
lo hanno intrapreso. Questa criticità consiste nella mancanza di una
qualsiasi entrata economica durante quella che chiameremo Fase 1, in
cui la persona, col supporto dell’operatore IPS, si orienta nella
ricerca, cerca effettive occasioni di lavoro, prepara il proprio
curriculum e si prepara per i colloqui di lavoro; tutto ciò dovrebbe
terminare con un autentico contratto di lavoro. Ma per tutta la durata
di questa Fase 1, che può essere anche molto lunga, la persona non
percepisce alcunché. La successiva Fase 2 consiste di fatto nello
svolgimento del lavoro trovato durante la Fase 1, ma rientra anch’essa
nell’IPS perché la persona può ancora ricorrere, ad esempio per
colloqui di sostegno o verifica, al supporto dell’operatore IPS.
Naturalmente, durante questa Fase 2 dell’IPS, la persona lavora e,
dunque, percepisce la relativa retribuzione.
Va osservato che anche durante un tirocinio (formativo o inclusivo), la
persona percepisce almeno una indennità di partecipazione. Anche certi
corsi di formazione prevedono una indennità di presenza. Ne deriva che
alcune persone, che hanno bisogno di riscuotere almeno un’indennità,
dovranno preferire all’IPS un altro percorso, generalmente un
tirocinio, formativo o inclusivo. Anche le persone che abbiano già
intrapreso l’IPS saranno costrette ad abbandonarlo se la Fase 1 si
prolunga troppo. È esclusa la possibilità di intraprendere
contemporaneamente l’IPS e un tirocinio, perché i due percorsi sono
considerati incompatibili, come vedremo. Per ovviare a questa mancanza
di una qualsiasi entrata economica, Nessuno Resti Indietro ha presentato tre diverse ipotesi. Di queste, quella che giudichiamo preferibile è la 3.
1. Possibilità di svolgere un tirocinio contemporaneamente alla Fase 1 dell’IPS
Questa possibilità è al momento esclusa perché non prevista, come si è
detto, dalla metodologia IPS. In proposito si sostiene che l’utente non
possa essere in grado di fare due cose insieme. Si sostiene anche, più
in generale, che il modello IPS deve essere applicato così com’è,
perché così è stato sperimentato che funziona. Entrambe queste
affermazioni sono in realtà discutibili 2. Questa ipotesi ha comunque
una controindicazione: fare due percorsi insieme è indubbiamente molto
gravoso, fermo restando che chi se la sente deve essere libero di
provare, almeno se non toglie il posto a qualcun altro.
2. Partecipazione alla Fase 1 dell’IPS come requisito per riscuotere un sostegno al reddito
Questa è in realtà un’ipotesi proposta dal Dipartimento e sarebbe
un’ottima soluzione, ma non senza controindicazioni: perché questo si
realizzi è necessaria un’intesa fra organi diversi nell’ambito della
gestione di risorse finanziarie stanziate a beneficio di vari soggetti;
ammesso che questo avvenga, alcune persone potrebbero comunque restare
escluse da altri titoli richiesti; in più, l’operazione non sarebbe a
costo zero.
3. Inserimento della Fase 1 dell’IPS in un tirocinio (formativo o inclusivo)
Durante la Fase 1 dell’IPS, l’utente apprende determinate abilità:
cercare aziende o altri enti che abbiano determinate caratteristiche;
preparare curriculum; prepararsi per i colloqui. Inoltre, della sua
attività può anche restare una traccia fruibile per altri utenti,
magari se crea o implementa una banca dati delle aziende cercate.
Queste competenze potrebbero essere riconducibili a un profilo
professionale: in questo caso, il tirocinio potrebbe essere formativo;
in caso contrario, il tirocinio potrebbe almeno essere inclusivo.
L’operazione potrebbe anche essere a costo zero o sarebbe comunque a
basso costo: per un tirocinio, formativo o inclusivo, in più presso un
CSM con queste finalità, ce ne sarebbe verosimilmente uno in meno
presso un’altra sede e con finalità diverse. Questa è per noi l’opzione
preferibile.
Va osservato in proposito che l’indennità di partecipazione percepita
dai tirocinanti è a carico, almeno di norma, dall’ente promotore del
tirocinio stesso, ossia dall’Asl. Quindi i ‘soggetti ospitanti’, che
ospitano tirocini (aziende, cooperative o altro) fruiscono
gratuitamente dell’operato dei tirocinanti. Nei casi migliori, il
tirocinante viene trattato per quello che è, ossia come persona che è
lì per apprendere, più che essere produttiva. In questi casi, positivi,
il modesto vantaggio produttivo derivato dall’apporto del tirocinante è
superato dall’aggravio organizzativo dovuto al fatto di ospitare un
tirocinio. Dunque, sempre in questi casi, la disponibilità dei soggetti
ospitanti nell’avviare tirocini è apprezzabile. Ma possono esserci
anche casi in cui i soggetti ospitanti si avvantaggiano eccessivamente
dell’apporto produttivo del tirocinante, trattato di fatto come un
lavoratore, ma non retribuito. Di conseguenza, potrebbe essere
opportuno ridurre il numero dei tirocini ‘esterni’, ossia svolti presso
un soggetto ospitante diverso dall’Asl o dal Dipartimento, aumentando
il numero dei tirocini ‘interni’, ossia svolti presso un soggetto
ospitante riconducibile all’Asl o al Dipartimento.
NOTE
1 Questo articolo fa seguito a “Un tavolo di lavoro sugli Inserimenti
lavorativi (IPS)”, pubblicato in precedenza su Il Faro, nel quadro del
tavolo di lavoro recentemente aperto fra Nessuno Resti Indietro e il
Dipartimento di Salute Mentale. Nessuno Resti Indietro è
un’associazione di promozione sociale che intende promuovere la
partecipazione attiva degli utenti dei servizi di Salute Mentale alle
politiche di recovery e welfare.
2 Quanto alla prima affermazione, già da tempo il DSM stesso promuove,
almeno nell’ambito dei percorsi di inserimento lavorativo, il
protagonismo responsabile dell’utente, combattendo quella mentalità
assistenziale e tutelante che ben si riassume nella parole “so io quel
che è meglio per te”. Ma, dando per scontato che l’utente non possa
essere in grado di fare due cose insieme, quel “so io quel che è meglio
per te”, scacciato dalla porta, rientra dalla finestra travestito da
“io so che non ce la fai a fare due cose insieme”. Quanto alla seconda
affermazione, sono già stati apportati adattamenti alla metodologia
originaria dell’IPS. Secondo questa metodologia originaria, è l’utente
che decide di intraprendere il percorso e non spetta a nessun operatore
del CSM di selezionarlo o indirizzarlo, o almeno così dovrebbe essere.
In realtà è lo stesso Dipartimento ad ammettere che il desiderio
dell’utente di intraprendere l’IPS deve essere ‘condiviso’ dal CSM o
dall’equipe. Tra l’altro, gli opuscoli informativi che erano stati
approntati in coincidenza del penultimo workshop sugli inserimenti
lavorativi, “Protagonismo e responsabilità dell’utente negli
Inserimenti lavorativi”, non sono ancora nella disponibilità degli
utenti. Potrebbe dunque essere informato dell’esistenza dell’IPS solo
l’utente già selezionato per l’IPS stesso.
|
|
|
IPS E DIAGNOSI FUNZIONALE
 Raffaele Menini
Raffaele Menini
Vorrei premettere che considero l’IPS
un ottimo strumento: è riconosciuto a livello internazionale, può
aiutare chi vuole affrontare un vero percorso di recovery ed entrare
nel mondo del lavoro per migliorare la propria indipendenza.
Occorrerebbe però informarsi correttamente, anche sui rischi che si
potrebbero correre nel caso si ometta di dichiarare l’invalidità, la
diagnosi funzionale (d’ora in avanti indicata come DF), la tipologia e
quantità di farmaci assunti.
Nei Centri di Salute Mentale di Bologna e provincia utenti e operatori
IPS stilano in genere due curriculum; uno che prevede la dichiarazione
di appartenere alle categorie protette (per chi ha l’invalidità) e uno
identico dove l’invalidità viene omessa. Questo viene fatto per dare la
possibilità, legittima, di entrare nel mondo del lavoro a pieno titolo.
Vorrei analizzare un ipotetico caso in cui una persona venga chiamata
al lavoro in seguito al percorso IPS, avendo presentato un curriculum
dove è stata omessa l’invalidità. Facciamo un esempio: si viene
chiamati ad un colloquio e si inizia a lavorare senza aver dichiarato
la propria invalidità, dopo qualche settimana generalmente si va a
visita dal medico del lavoro, al quale si sarebbe tenuti (per legge) a
dichiarare DF (e/o percentuale di invalidità se ci pare) e i farmaci
che si assumono. Il medico del lavoro è tenuto alla riservatezza sulla
tipologia di farmaci e di patologia, ma è tenuto (come il lavoratore) a
dichiarare la DF perché questa va rispettata per legge, o si rischia
che in caso di infortunio, non vengano riconosciute indennità o ancor
peggio andare incontro a problemi medico/legali per la persona e per il
datore di lavoro. Quindi il medico del lavoro comunicherà la DF al
datore di lavoro che può anche, e a ragione, non assumere o licenziare
il lavoratore perché la DF non era stata dichiarata al momento
dell’assunzione o nel curriculum. Mi chiedo cosa ancora potrebbe
capitare se non si dichiara al medico del lavoro il tipo di farmaci che
si stanno assumendo, e succeda un incidente per causa nostra ad un
collega.
Naturalmente se si inviano curriculum solo per lavori compatibili alla
propria DF, il problema si riduce, occorre solamente essere informati e
informare correttamente tutti i soggetti, giusto per mettersi l’anima
in pace (in questo caso la mia).
Ridurre la Diagnosi Funzionale?
La DF sarebbe da sottoporre periodicamente a revisione, ma mi viene da
pensare che comunque, chi prende un certo tipo di farmaci qualche
limitazione l’avrà sempre. Psichiatra e commissione valutativa della DF
conoscono i parametri valutativi delle limitazioni e possono avere voce
e responsabilità in capitolo, di certo è che più psicofarmaci si
assumono e più alta sarà la limitazione della DF.
Sarebbe forse il caso che gli psichiatri rivedessero un poco le
terapie, anche per permettere la riduzione della DF, e quindi per fare
un percorso IPS e lavorativo più sereno e teso veramente alla recovery?
Mercoledì 21 settembre ho partecipato alla giornata conclusiva del
corso di formazione per operatori IPS: uno dei temi del corso era “8°
principio - contatti con il datore di lavoro”.
A Bologna il metodo per contattare i datori di lavoro nei percorsi IPS
ricalca quello classico usato dai centri per l’impiego: compilazione
curriculum, ricerca delle offerte di lavoro, ricerca di aziende che
potrebbero essere interessate alle competenze del lavoratore e invio
dei curriculum, nessun contatto diretto operatore IPS - datore di
lavoro. Durante il corso di aggiornamento è stata presentata invece
l’esperienza di Piacenza, che prevede come primo passo la ricerca e il
contatto diretto di educatori e operatori IPS con più datori di lavoro
(compresi enti, confederazioni, cooperative, eccetera) disposti ad
assumere una o più persone con disagio psichico, e in un secondo tempo
far incontrare direttamente la domanda e l’offerta, che si potranno
conoscere ed accordare a quattr’occhi. L’esperienza di Piacenza
comporta un grande e impegnativo lavoro da parte degli operatori, ma è
evidente che questo modello può andare nella direzione utile a non
perdere energie per inviare centinaia di curriculum che nessuno leggerà
(la realtà del lavoro in Italia è questa).
Non sarà facile trovare datori di lavoro disposti a contribuire alla
lotta allo stigma consapevolmente, cosa che possono fare solo gli
operatori. Agli utenti il compito di confermare con il loro lavoro, la
loro serietà e dedizione, che questa lotta sia realista.
Bologna-Piacenza 0-1?
|
|
|

HOLASCIATICA! (ME LE MIE RENI CANTANO ANCORA)
 Teresa Nicoletti tratto da CapoHorn n° 10, settembre 2006
Teresa Nicoletti tratto da CapoHorn n° 10, settembre 2006
La vita, i dolori, le difficoltà, i sogni e le speranze di una donna che tenta un percorso di autonomia.
Il peso del mondo è amore
A. Ginsberg
Ho trascorso i miei più brutti giorni
di malattia, fino a poco tempo fa, nel Gruppo Appartamento che
attualmente è la mia casa, condivisa con altri quattro ragazzi. Spero
di essermi lasciata definitivamente alle spalle la febbre alta, la
sciatica, le vertigini ed il vomito, anche se non so come ho fatto
finora. In certi momenti, addirittura, penso di avere qualche fattura
addosso! E pensare che avevo trovato quel posticino di lavoro in
palestra. Mi piaceva tantissimo. Anche se ripenso a quanta fatica
facevo per andare e quante paure dovevo superare... Beh, allora non so
se varrà la pena proseguire con questo impegno, che ogni giorno diventa
più pesante. E pensare, poi, che avevo anche proposto ai miei amici di
Asiamente di fare una romantica gita a Venezia… E invece ho trascorso i
miei più brutti giorni di malattia! E invece holasciatica! Che è quasi
diventata una tiritera, un’ossessione e un mio modo di sentire e non
(solo) una parolaccia. Però, bene o male, me la sto cavando da sola e,
anche se ogni tanto i miei genitori passano a casa nostra, ormai, posso
dirlo, vivo finalmente fuori casa. E dunque... Coraggio! In effetti ho
continuato a fare quello che è necessario fare in casa, soprattutto
cucinare. Il risotto alla milanese, le polpette con i piselli al ragù,
il polpettone, il dolce con il cacao e il pan di Spagna, sicuramente
sono meglio dell’aspirina e del Voltaren, avendo anche un buon effetto
antidepressivo. Così adesso non so se sono stanca, perché ho i dolori
della sciatica, oppure perché lavoro tutto il giorno. Spero solo di
ritrovare la forza di cantare, perché quando ero ragazzina quello era
il mio sogno. Diventare una grande, bella e splendida cantante!
|
|
|
PER CASO A CASA
 Opola Resonive
Opola Resonive
 Un bel dì, era settembre inoltrato, ero
nella mia umile casa sull‘Himalaya. Sulla cima a ottomila metri.
Dicevano che non ci si poteva abitare, ma io avevo deciso di
trasferirmi in alta quota, aspettando gli ignari scalatori che
arrivavano sulla cima e con una grande sorpresa mi trovavano ad abitare
così in alto. Ma questo era possibile solo con la bella stagione, con
la neve sarei dovuto scendere. Ormai era giunto il momento di ritornare
alle terre più basse: in alta quota il maltempo, il freddo e la neve
imperversavano. Le ultime carovane di avventurieri erano finite, la
montagna stava diventando sempre più pericolosa ed avversa alla vita
umana. Io col mio falco Tochy eravamo in procinto di scendere a valle.
Il contatto radio con la base era ancora attivo... Nell’ultima
trasmissione dissi: “Noi torniamo alla base, è ora di riposare, un
lungo riposo che possa darci quella carica, che una lunga esperienza ha
prosciugato...”. La neve era su di noi, nuvoloni neri e spaventosi
circolavano sulle alte cime delle montagne, Tochy volava in circolo,
desiderando solamente tornare a casa. Io e il falco eravamo su da ormai
tre mesi e l‘inverno era alle porte. La Tv inglese trasmetteva notizie
rassicuranti sulla mia avventura. Tutto: infatti ero stato
sponsorizzato da un canale di Londra, un’avventura pericolosa che
potesse dare speranza di una vita al limite del possibile, ben diversa
da quella quotidiana del cittadino inglese moderno. Quando venivano su
le spedizioni, tutti erano contenti di vedere un volto amico che
potesse dare loro un sorriso e una rassicurazione sulla facilità di una
via, che poteva sembrare difficile, ma che in realtà… lo era! Il
destino che mi avvolgeva in questa pazza esperienza mi donava
sicuramente l’amore della distanza dalla civiltà, portandomi in un
viale illuminato solo da torce...
Un bel dì, era settembre inoltrato, ero
nella mia umile casa sull‘Himalaya. Sulla cima a ottomila metri.
Dicevano che non ci si poteva abitare, ma io avevo deciso di
trasferirmi in alta quota, aspettando gli ignari scalatori che
arrivavano sulla cima e con una grande sorpresa mi trovavano ad abitare
così in alto. Ma questo era possibile solo con la bella stagione, con
la neve sarei dovuto scendere. Ormai era giunto il momento di ritornare
alle terre più basse: in alta quota il maltempo, il freddo e la neve
imperversavano. Le ultime carovane di avventurieri erano finite, la
montagna stava diventando sempre più pericolosa ed avversa alla vita
umana. Io col mio falco Tochy eravamo in procinto di scendere a valle.
Il contatto radio con la base era ancora attivo... Nell’ultima
trasmissione dissi: “Noi torniamo alla base, è ora di riposare, un
lungo riposo che possa darci quella carica, che una lunga esperienza ha
prosciugato...”. La neve era su di noi, nuvoloni neri e spaventosi
circolavano sulle alte cime delle montagne, Tochy volava in circolo,
desiderando solamente tornare a casa. Io e il falco eravamo su da ormai
tre mesi e l‘inverno era alle porte. La Tv inglese trasmetteva notizie
rassicuranti sulla mia avventura. Tutto: infatti ero stato
sponsorizzato da un canale di Londra, un’avventura pericolosa che
potesse dare speranza di una vita al limite del possibile, ben diversa
da quella quotidiana del cittadino inglese moderno. Quando venivano su
le spedizioni, tutti erano contenti di vedere un volto amico che
potesse dare loro un sorriso e una rassicurazione sulla facilità di una
via, che poteva sembrare difficile, ma che in realtà… lo era! Il
destino che mi avvolgeva in questa pazza esperienza mi donava
sicuramente l’amore della distanza dalla civiltà, portandomi in un
viale illuminato solo da torce...
Vita, passione, una vita vissuta con la passione per la montagna, fin
da piccolo rincorrevo i caprioli sulle cime dei monti... Amare il mio
falco trovato ferito un’ala e curato. Lui si è affezionato a me, io mi
sono affezionato a lui, la storia continua, una storia di un legame
profondo che ci lega.
Vivere in alta quota è un problema, un piccolo rifugio creato sulla
cima più alta del mondo, una vita fuori dai limiti, in cerca di cosa...
Io in fondo non ho mai avuto una casa dove mi trovassi a mio agio, in
cerca di un posto dove poter vivere sicuro e realizzato dei miei più
profondi sentimenti di pace e silenzio. Il silenzio non manca, tornare
a casa a vivere una vita frenetica, cos‘è la mia casa adesso… non
riesco più a pensarlo, desidero amare le persone che mi circondano
senza darle per scontate, un profondo legame mi ha unito alle varie
spedizioni giunte sulla cima. Un legame di fraternità. Cercare sempre
il massimo da tutte le cose a cui mi sono dedicato. Cercare il massimo
senza per questo raggiungerlo, dare di più del limite che gli altri mi
pongono, superare me stesso senza riserve.
Tochy vola nel cielo, lui vola anche un po’ per me, vede cosa succede
dall’alto, l’aria è molto rarefatta, la vegetazione scarsa, le rocce
tante, il vento tira forte...
Amo il tintinnio della pioggia sulle piccole pareti della casetta in
legno che mi protegge, l’amore è desiderio di realizzare una vita con
altre persone, animali o cose. Io amo vivere la vita come se fosse
l’ultimo giorno, cercare di fare il massimo per non rinchiudermi in una
scatola dorata, ma rincorrere il sale che ci dà amore e felicità.
Stiamo tornando verso la valle, un’altra esperienza finita, dove andrò
a vivere adesso? Non sono abituato alle persone, alla Tv, alla stampa,
la mia esperienza avrà sicuramente un riscontro mediatico. Voglio, non
voglio, desidero, non desidero ho necessità di una vita che mi dia
tanto, ma non esagerando, un’amicizia profonda verso il genere umano,
un grande desiderio di libertà si ripercuote suoi miei sensi senza
aspettare che mi fermi...
Stop, sono sceso dal monte, Tochy si è svegliato per il clima a lui
molto sfavorevole, io mi dirigo verso il primo aereoporto che posso
trovare, direzione a caso...
Ma mi domandano i fotografi ed intervistatori: “Lei adesso tornerà a
casa dopo questa lunga esperienza?”… E io ripondo: “Penso che andrò per
caso a casa... Non saprei dove altro dirigermi, un posto sicuro dove
poter piangere, ridere, rincorrere i sogni e riposare”.
La casa dopo una lunga esperienza ti può rendere la vita più piacevole,
l‘importante è trovare una propria autonomia. Ho vissuto ad alta quota;
ma bisogna anche riuscire a vivere a bassa quota, me l‘ha insegnato
Tochy, rincorrere i propri desideri poi riposarsi, riposarsi, riposarsi
e riprendere a seguire i propri desideri..
|
|
|
|
|
|
HO VISSUTO UN SOGNO
 Mirna Zucchini
Mirna Zucchini
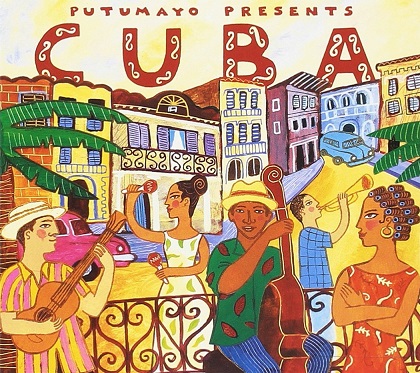 Ho vissuto un sogno, sono stata a Cuba.
Nell’ormai lontano 1989 presi l’aereo per la prima volta e volai a
Cuba. Un mese esatto prima della mia partenza era precipitato un aereo
di partenza proprio da quell’isola, non vi dico con quale stato d’animo
partii! Arrivata all’aeroporto dell’Avana e scesa dall’aereo, provai
una sensazione di malessere, dovuta alla percezione di un forte calore
e di una elevata umidità e pensai: “Io quindici giorni qui non li
sopporto!”. Ci recammo successivamente con il pullman e un autista
spericolato all’hotel di Varadero, dove per fortuna c’era l’aria
condizionata.
Ho vissuto un sogno, sono stata a Cuba.
Nell’ormai lontano 1989 presi l’aereo per la prima volta e volai a
Cuba. Un mese esatto prima della mia partenza era precipitato un aereo
di partenza proprio da quell’isola, non vi dico con quale stato d’animo
partii! Arrivata all’aeroporto dell’Avana e scesa dall’aereo, provai
una sensazione di malessere, dovuta alla percezione di un forte calore
e di una elevata umidità e pensai: “Io quindici giorni qui non li
sopporto!”. Ci recammo successivamente con il pullman e un autista
spericolato all’hotel di Varadero, dove per fortuna c’era l’aria
condizionata.
Il mattino seguente, una volta uscita, non provai affatto la stessa
sensazione della sera precedente, anzi cominciai a vedere quanto fosse
bello il panorama. La sera andammo in un ristorante per cenare e lì
conoscemmo Willy, personaggio cubano che ci accompagnò, insieme ad
alcuni ragazzi di Verona, per tutta la settimana. Con loro cominciarono
le nostre avventure. Ci incontravamo tutti alla piscina dell’hotel dove
c’era sempre musica. Una sera, non avendo cenato, domandammo a Willy se
ci andava a prendere da mangiare e lui si presentò con riso e fagioli,
pollo e patate fritte in una busta di plastica e mangiammo tutti dalla
busta con le mani. Un’altra sera si presentò con tre ballerine, che
provarono disperatamente a insegnarmi a ballare il cha cha cha, ma il
risultato fu veramente scarso! Un’altra sera ci trovammo alla solita
piscina e Willy dimenticò i suoi documenti sul tavolo dove ci eravamo
accomodati e lo fermarono i poliziotti (a Cuba i Cubani non possono
parlare con i turisti!) a quel punto non sapevamo più come fare, in
quanto se glieli portavamo capivano che ci conosceva e se non glieli
portavamo rischiava di essere fermato, per fortuna tutto è bene ciò che
finisce bene. Finito il subbuglio dei documenti ci accordiamo per il
giorno dopo: escursione per l’isola in dune buggy
con guida locale: Willy! Il mattino seguente partiamo, giriamo le varie
località e giunti alla Baia dei Porci ci fermiamo per il pranzo:
coccodrillo e banane. Durante il ritorno dal tour vediamo un aranceto
ed io che non avevo mai mangiato un’arancia staccata dall’albero chiesi
di fermarci, fui accontentata! Mentre raccogliamo le arance arriva un
ragazzo con la bicicletta di gran corsa, allora noi pensiamo: via, via
che arriva il padrone! E questi per tutta risposta ci dice: “Amigos non
lì, più avanti son migliori!”. Quella stessa sera mentre accompagnavamo
a casa Willy cominciamo a sentire dei gran tuoni e Willy: “No, no, non
piove!”, ma dopo averlo scaricato sulla via del ritorno comincia un
temporale tropicale mentre noi eravamo in dune buggy! Un’altra
volta Willy aveva piacere di farci mangiare qualcosa di cucinato dalla
madre e anche lì abbiamo dovuto mangiare la cernia con le mani.
Terminata la prima settimana comincia la seconda: destinazione Campo
Largo. Sull’aereo di transizione, dall’Avana a Campo Largo, conoscemmo
dei ragazzi di Cesena con i quali trascorremmo altre bellissime
giornate. Ad esempio, durante un’escursione in barca vedemmo un
barracuda enorme a un metro di distanza da noi, lo spavento fu talmente
grande che non posso raccontarlo! Inoltre ci lasciarono soli
sull’atollo fino al tramonto! Devo dire che anche in questa occasione
il coraggio era venuto a mancare! Fa seguito a questa avventura una
seconda escursione sempre in barca, dove tutti fummo attrezzati di
canne da pesca. Uno di noi riesce a pescare un grande pesce che ci fu
servito a pranzo: crudo! Ma ciò che più conta in questa meravigliosa
avventura è che ho conosciuto l’amicizia, quella vera: ancora oggi quei
ragazzi di Cesena sono i miei migliori amici! Mi piacerebbe inoltre
potervi trasmettere lo stesso calore umano che ho ricevuto io da quella
popolazione.
|
|
|
POI CI SONO I PAGANELLI
 Costanza Tuor
Costanza Tuor
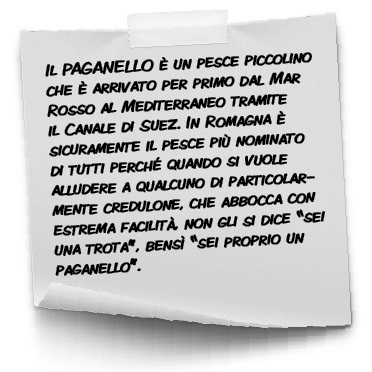 Sapete, mio padre è un pescatore! Ci
mette tutto il suo impegno e le sue fatiche, ma io, che lo seguo da un
bel po’ di tempo, ho piacere di raccontarvi una storia. Quando era
molto giovane, mio padre amava andare con gli amici a pescare nei
fiumi. Non ha mai raccolto grossi bottini in fatto di pesi e misure, ma
si è molto molto divertito. Partivano insieme la mattina presto,
viaggiavano per arrivare al luogo che avevano scrutato sulla mappa e
arrivati sull’argine posizionavano gli strumenti e via di pazienza e
risate. Una preghiera semplice di fronte alle meraviglie del creato.
Sapete, mio padre è un pescatore! Ci
mette tutto il suo impegno e le sue fatiche, ma io, che lo seguo da un
bel po’ di tempo, ho piacere di raccontarvi una storia. Quando era
molto giovane, mio padre amava andare con gli amici a pescare nei
fiumi. Non ha mai raccolto grossi bottini in fatto di pesi e misure, ma
si è molto molto divertito. Partivano insieme la mattina presto,
viaggiavano per arrivare al luogo che avevano scrutato sulla mappa e
arrivati sull’argine posizionavano gli strumenti e via di pazienza e
risate. Una preghiera semplice di fronte alle meraviglie del creato.
Poi gli amici hanno messo su famiglia, avevano pescato dei pesci
importanti e hanno cominciato a lavorare lontano dall’acqua. I figli, o
meglio, le figlie erano birbanti. C’era da fare parecchio e la pesca
restava un’idea, un’ipotesi, un’utopia quasi. A dire il vero nel caso
di mio padre ci fu una parentesi peschereccia che piantò nel suo cuore
quella malinconia speciale, una sorta di onda leggera che si ripropone
con i suoi tempi. Io e una mia sorella andammo alcune volte con lui a
pescare in mezzo al mare con una barchetta che ci fu affidata per un
certo tempo. Questa volta fu il mare che prese il cuore del mio papà.
Il sogno sfociò in albe ancora piuttosto fredde, prima dell’arrivo del
sole. E quello, sì, scaldava! Sotto il sole aspettavamo indicazioni per
capire come meglio posizionare l’esca e tirare su qualcosa. Be’… quello
che ho raccolto io sono immagini irripetibili, paesaggi mozzafiato e
l’allegria ancora assonnata di chi si alza presto la mattina e parte
senza sapere bene dove si stia dirigendo. È strana la sensazione che ti
coglie quando dalla penombra della mattina presto ti vedi scaraventato
nella luce del sole del mattino inoltrato.
Al momento comunque dopo più di trent’anni da allora io inoltro solo
missive di poco conto, ma mio padre ha deciso di riprovarci. Vuole
pescare nel mare. Si è organizzato tutto l’armamentario, ma da solo non
se la sentiva di fare la prima escursione e così sono andata con lui,
non dopo parecchia insistenza. Siamo partiti, abbiamo raggiunto il molo
del porto, l’unico molo su cui si può davvero pescare in questo nostro
mare. Uno strano molo che pare sia stato opera di un vescovo. Mi sono
sempre chiesta cosa c’entrasse un vescovo con un molo! Quel giorno il
molo era chiuso, così giunti alla meta mio padre decise di dirigersi su
di una piccola scogliera artificiale. Io non riuscii a raggiungere la
cima, il bordo estremo, avevo il terrore di venire risucchiata dalle
onde. Mio padre si fece avanti e tentò l’impresa vicino a un ramo secco
che sembrava la speranza di un albero. Non contento, senza avere
pescato niente, mi portò in porto. Quando era molto piccolino pescava
nel porto e forse questo lo faceva stare bene. Comunque nel porto
giunse la sorpresa… pescò un pesce! Ma cosa immaginate? Sì, un pescetto
di non più di dieci centimetri. Si mise a ridere e mi disse tutto
fiero: “Sai cos’è questo?”. Tacqui, perché mi veniva troppo da ridere e
non volevo che ci rimanesse male. “Questo è un paganello!”. L’aveva
pescato davvero il suo pescetto nel mare… “Ma per fare una frittura ce
ne vogliono almeno dodici o tredici, papà!” e lui mi ha risposto con la
faccia soddisfatta: “Ma a me intanto piace questo”.
Da allora mio padre ha pescato orate, ombrine, sgombri, cefali, non
molti per la verità, ma belli grossi. Ma io ho sempre in mente quel
primo piccolo pescino che ha tirato su tutto fiero, quel paganello. C’è
un mese dell’anno in cui pare se ne possano pescare ceste piene, quello
non era il mese giusto, ce n’era giusto uno piccolo piccolo, che si
faceva un giretto per conto suo e ha incontrato il mio papà. Eh sì, mi
sa che lo devo dire… mio padre usa delle buone esche, anche fuori
stagione.
|
|
|
GITA DELLA TROTTOLA A CERVIA
 Michele Ferri
Michele Ferri
Quest’anno l’ultimo incontro degli
amici della Trottola, ha avuto luogo il 16 luglio scorso: indovinate
dove? Ma a Pinarella di Cervia, naturalmente, diventata ormai da
quattro edizioni una consuetudine. Dopo esserci ritrovati alla Casa
della Conoscenza di Casalecchio, ci siamo mossi con un pulmino e
quattro macchine private, visto che eravamo in venticinque. Il viaggio,
che a causa del periodo ha subito dei rallentamenti frequenti, è stato
piuttosto lungo. Giunti, finalmente a destinazione, ci siamo divisi in
due gruppi a seconda delle preferenze, così alcuni sono rimasti in
pineta, per sopportare meglio il gran caldo della giornata, altri
invece si sono diretti verso la spiaggia libera; poiché durante la
notte c’era stata una gran mareggiata, l’acqua era piuttosto torbida e
la spiaggia ricoperta da alghe, nessuno ha osato fare il bagno così, il
sottoscritto compreso, ci siamo incamminati lungo la battigia facendo
una lunghissima passeggiata. Alle 13 circa abbiamo fatto ritorno al
parcheggio per raggiungere La Pantofla, ristorante gestito da una
cooperativa di pescatori dove, solitamente. come in questa occasione,
prenotiamo il pranzo.

Il menù, naturalmente a base di pesce, è stato ottimo ed abbondante,
quest’anno, addirittura, oltre ai due primi e alla frittura, hanno
servito, per lo stesso prezzo, anche un mega antipasto a base di cozze.
Dopo pranzo, durante un giro in paese, il sottoscritto, ha addirittura
incontrato un paesano nonché amico di Ponte Ronca, che stava
trascorrendo un periodo di vacanze a Pinarella: “È proprio piccolo il
mondo!”. Ovviamente non sono mancate le foto, alcune delle quali
Floriano le ha scattate nel vecchio mercato del pesce attiguo alla
darsena. Tutto sommato, abbiamo trascorso una giornata un po’ faticosa
ma molto allegra, piacevole ed appagante. Sono queste le giornate
migliori; a volte i giovani, come a suo tempo il sottoscritto, pensano
di poter trasformare certe giornate in qualcosa di elettrizzante,
speciale, facendo uso di sostanze, in realtà, così facendo, non si fa
altro che nascondere la cenere sotto al tappeto. Il disagio e le
sofferenze non vanno via, come erroneamente si crede, ma addirittura si
amplificano e si aggravano. Voglio lanciare un messaggio: Chiedete
aiuto alle persone ed ai servizi competenti perché, nonostante tutto,
LA VITA È BELLA.
|
|
|
GITA IN PORTOGALLO
 Concetta
Concetta
 Premessa: il gruppo vacanze in Europa,
quest’anno è approdato in Portogallo. A differenza delle edizioni
precedenti, la destinazione non è stata concordata dal gruppo dei
partecipanti, ma è stata la risposta ad un invito che, lo scorso anno,
una specializzanda in psichiatria, Lija Maia, venuta a Bologna per un
tirocinio di tre mesi, ha rivolto alla sottoscritta per il bellissimo
rapporto venutosi a creare, non solo dal punto di vista professionale.
Oporto è una città splendida, le peculiarità del centro storico,
divenuto da qualche anno patrimonio dell’UNESCO, sono gli azulejos,
mattonelle riconducibili, anche se con dimensioni molto più grandi,
alle tessere utilizzate per fare i mosaici, dai colori che comprendono
tutte le sfumature dell’azzurro, da cui il nome. Le
raffigurazioni.fatte con gli azulejos sono di eventi sacri e
non, poste ad ornamento rispettivamente di chiese o edifici pubblici
(stazione ferroviaria, palazzi pubblici, enti eccetera). La chiesa che
più di ogni altra mi ha colpito è quella di San Francesco, che
contrariamente al pensiero e alla vita del ‘Poverello’ di Assisi è
letteralmente sovraccarica di oro, circa duecento Kg se si considerano
gli oggetti sacri e lo spessore del prezioso metallo che ricopre le
sculture lignee poste sui diversi altari. Alle bellezze artistiche
vanno a sommarsi le bellezze naturali e le bontà culinarie: Oporto
infatti oltre ad essere attraversata dal fiume Douro che nasce in
Spagna e dopo circa duecento Km sfocia nell’Oceano Atlantico, è
circondata da colline lussureggianti, con coltivazioni per lo più di
ulivi e vigneti che producono il famoso vino da dessert, il Porto, che
ben si accompagna, contrariamente all’abbinamento che si fa in Italia,
non solo ai dolci, ma anche alle pietanze a base di carne e pesce come
il famoso bacalhau (baccalà).
Premessa: il gruppo vacanze in Europa,
quest’anno è approdato in Portogallo. A differenza delle edizioni
precedenti, la destinazione non è stata concordata dal gruppo dei
partecipanti, ma è stata la risposta ad un invito che, lo scorso anno,
una specializzanda in psichiatria, Lija Maia, venuta a Bologna per un
tirocinio di tre mesi, ha rivolto alla sottoscritta per il bellissimo
rapporto venutosi a creare, non solo dal punto di vista professionale.
Oporto è una città splendida, le peculiarità del centro storico,
divenuto da qualche anno patrimonio dell’UNESCO, sono gli azulejos,
mattonelle riconducibili, anche se con dimensioni molto più grandi,
alle tessere utilizzate per fare i mosaici, dai colori che comprendono
tutte le sfumature dell’azzurro, da cui il nome. Le
raffigurazioni.fatte con gli azulejos sono di eventi sacri e
non, poste ad ornamento rispettivamente di chiese o edifici pubblici
(stazione ferroviaria, palazzi pubblici, enti eccetera). La chiesa che
più di ogni altra mi ha colpito è quella di San Francesco, che
contrariamente al pensiero e alla vita del ‘Poverello’ di Assisi è
letteralmente sovraccarica di oro, circa duecento Kg se si considerano
gli oggetti sacri e lo spessore del prezioso metallo che ricopre le
sculture lignee poste sui diversi altari. Alle bellezze artistiche
vanno a sommarsi le bellezze naturali e le bontà culinarie: Oporto
infatti oltre ad essere attraversata dal fiume Douro che nasce in
Spagna e dopo circa duecento Km sfocia nell’Oceano Atlantico, è
circondata da colline lussureggianti, con coltivazioni per lo più di
ulivi e vigneti che producono il famoso vino da dessert, il Porto, che
ben si accompagna, contrariamente all’abbinamento che si fa in Italia,
non solo ai dolci, ma anche alle pietanze a base di carne e pesce come
il famoso bacalhau (baccalà).
|
|
|
IN AUTONOMIA A OPORTO
 Andrea e Susanna
Andrea e Susanna
 P
rima della partenza eravamo preoccupati di non essere all’altezza della
situazione e cioè di non riuscire a superare tutti gli ostacoli del
viaggio. Siamo partiti il 4 settembre, con Concetta, Lucio e Antonio,
dal punto di ritrovo, la stazione centrale. Abbiamo raggiunto
l’aeroporto Guglielmo Marconi in aerbus. Susanna era al suo primo volo,
era decisamente preoccupata e in ansia per le possibili reazioni
durante il viaggio, per fortuna tutto è andato benissimo, tanto che
Concetta le ha chiesto se nella precedente vita avesse fatto la
hostess. Quello che ad Oporto ci ha colpito molto, sono state gli azulejos
della stazione ferroviaria e la cattedrale che si erge maestosa su di
una collina. È stata bellissima la gita in traghetto sul fiume Douro,
la risalita dal fiume al centro città con la funicolare e la sosta
sugli scogli dell’Oceano, dove è stato possibile prendere un po’ di
sole nonostante le onde altissime che sbattevano contro gli scogli con
abbondanti spruzzi sui bagnanti. Un ringraziamento va a Concetta e
indirettamente all’amica che l’ha invitata, per averci dato
l’opportunità di fare questa nuova esperienza durante la quale abbiamo
acquisito altre autonomie e competenze.
P
rima della partenza eravamo preoccupati di non essere all’altezza della
situazione e cioè di non riuscire a superare tutti gli ostacoli del
viaggio. Siamo partiti il 4 settembre, con Concetta, Lucio e Antonio,
dal punto di ritrovo, la stazione centrale. Abbiamo raggiunto
l’aeroporto Guglielmo Marconi in aerbus. Susanna era al suo primo volo,
era decisamente preoccupata e in ansia per le possibili reazioni
durante il viaggio, per fortuna tutto è andato benissimo, tanto che
Concetta le ha chiesto se nella precedente vita avesse fatto la
hostess. Quello che ad Oporto ci ha colpito molto, sono state gli azulejos
della stazione ferroviaria e la cattedrale che si erge maestosa su di
una collina. È stata bellissima la gita in traghetto sul fiume Douro,
la risalita dal fiume al centro città con la funicolare e la sosta
sugli scogli dell’Oceano, dove è stato possibile prendere un po’ di
sole nonostante le onde altissime che sbattevano contro gli scogli con
abbondanti spruzzi sui bagnanti. Un ringraziamento va a Concetta e
indirettamente all’amica che l’ha invitata, per averci dato
l’opportunità di fare questa nuova esperienza durante la quale abbiamo
acquisito altre autonomie e competenze.
|
|
|
|
OPERE DEGLI ARTISTI IRREGOLARI BOLOGNESI
Gilda
Maria Losanna Pappalardo nasce a La Chaux De Fonds (Svizzera) il 24
Febbraio 1961. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera
(scultura) e Bologna (scultura e pittura) dove si è diplomata.
Attualmente vive e lavora a Bologna.
I dipinti riprodotti qua sotto sono dell’artista Gilda Pappalardo







|
|
|


