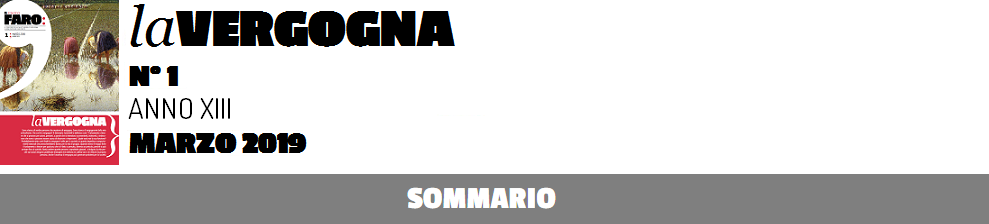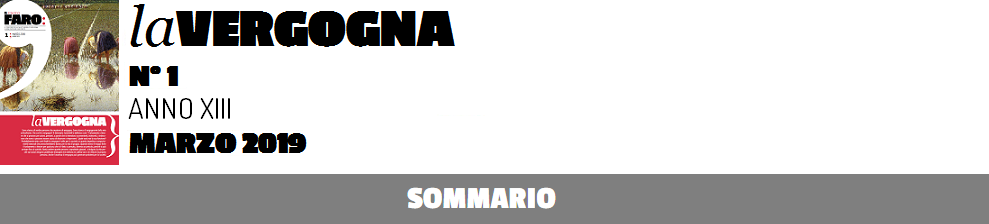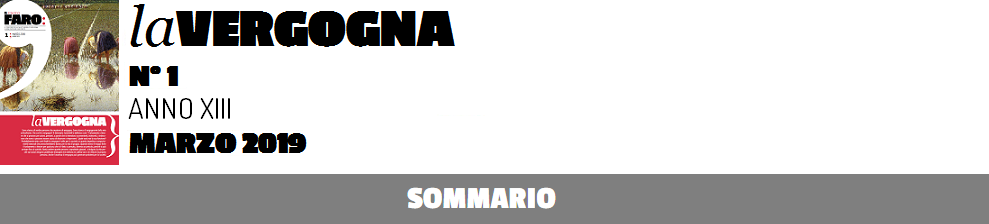ANGELO MORBELLI:
“Per 80 centesimi”
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti

A
ngelo Morbelli (Alessandria 1853 - Milano 1919), verista preciso e
paziente, ottenne i risultati più clamorosi con opere di tematica
sociale o pietistica (mondine e vecchi poveri ospitati nel “Pio Albergo
Trivulzio” di Milano). La tecnica divisionista fu quella che adottò
nella maturità, per confrontarsi e per capire il vero. Divisionista e
progressista! La tela Per 80 centesimi
è tra le sue opere più frequentemente esposte, forse anche perché
tratta del lavoro femminile. Fu eseguita dopo che il pittore aveva
visto scene simili nei dintorni di Casale. La sequenza di schiene curve
è rifl essa nell’acqua e si ripete in lontananza. Tutta la superfi cie
del quadro è occupata dal prato irriguo. Morbelli non ha dato nessuno
spazio al cielo, a diff erenza di opere di altri artisti sul tema (sia
dipinti che fotografi e). È proprio questo ridursi alla sola risaia che
rende così ‘forte’ questa apparizione di schiene - che sembra molto
polemica - in una natura di certo non benevola. La stampa progressista
ravvisò nel quadro una sorta di manifesto pittorico che denunciava lo
sfruttamento delle lavoratrici, ma forse a Morbelli interessava ancor
di più la presa d’atto del vero. Per 80 centesimi sorprende per
la magistrale resa dell’acqua e dei verdi, ma quanta fatica! L’ostinata
convinzione del pittore della possibilità di ottenere unità e massima
resa luministica con piccole pennellate divise comportava di provare e
riprovare, riprendendo più e più volte il lavoro. A Morbelli non
mancarono i riconoscimenti internazionali. Esposto insieme ad altri
quadri di divisionisti, Per 80 centesimi vinse la medaglia
d’oro a Dresda nel 1897. È da ricordare soprattutto la medaglia d’oro
vinta nel 1900 all’esposizione universale di Parigi con Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio, tela del 1892. In quell’occasione a Morbelli fu conferita anche la ‘legion d’onore’.
|
|
|
EDITORIALE
 Fabio Tolomelli
Fabio Tolomelli
S
ono stanco di sentire persone che muoiono di vergogna. Sono stanco di
vergognarmi della mia schizofrenia. Che cos’è la vergogna? Il
dizionario Zanichelli la definisce così: “Turbamento e timore che si
provano per azioni, pensieri, o parole che si intendono sconvenienti,
indecenti, o indecorose che sono o possono essere causa di disonore o
rimprovero”. Quale sarà mai la sua funzione? Probabilmente entro certi
limiti la vergogna è utile per la società, in quanto impedisce
comportamenti immorali che provocherebbero danno per la vita di gruppo.
Quando invece è troppo forte il turbamento o timore per qualcosa che si
è fatto o pensato, diventa un pericolo, perché si può arrivare fino al
suicidio. Basta vedere quante persone, soprattutto giovani , si tolgono
la vita perché sui social vengono pubblicate immagini che mettono in
cattiva luce o in ridicolo la propria persona. Anche l’assenza di
vergogna può generare problemi per la società. Da Wikipedia: “In
contrasto con la vergogna è il non avere vergogna, ovvero comportarsi
senza il ritegno di offendere gli altri”. Il ritegno che ne consegue
permette di mantenere nel gruppo quella correttezza che se mancasse
darebbe vita all’anarchia e alla violenza. Mia nonna Bianca quando
facevo qualche marachella mi diceva: “Vergogna!” … Io allora avevo
circa dieci anni e non capivo pienamente il significato del termine, ma
ero conscio di aver fatto qualcosa di sbagliato. Mio padre, invece,
forse per tutelarmi, mi ha inculcato un tipo di vergogna che mi ha
nuociuto: non voleva che io parlassi del mio mal di testa. Si tratta di
un’emicrania con aura, un dolore lancinante e battente in metà del
cranio, accompagnato da fotomi, formicolii e afasia. Questa mia
patologia me la sono diagnosticata da solo, dopo molti anni che ne
soffrivo, perché i medici, o per ignoranza, o perché la scienza non
l’aveva ancora classificata, mi avevano lasciato nell’incertezza.
Questo fece crescere in me una forte vergogna e paura di essere
diverso. Sui quaderni scrivevo di nascosto: “Sono pazzo”. Ma
soprattutto avevo il terrore di perdere l’autocontrollo, perché
l’afasia che mi prende in quei momenti, mi porta a dire cose diverse da
quelle che voglio pronunciare. Faccio un esempio, voglio dire: “Mamma,
chiama il dottore!” e invece dico: “Sono stato a pescare”. Tra la
vergogna, il terrore e l’incertezza mi sono dovuto tenere dentro queste
cose fino ad ora. Come vergogna in senso stretto, la più grande e
terribile per me è stata sicuramente quella della schizofrenia. Un po’
per lo stigma, un po’ per l’auto-stigma , mi sono rinchiuso in me
stesso, nascondendo questa mia patologia a tutti e in una certa misura
anche a me. Ricordo la prima volta che entrai nel Centro di Salute
Mentale di San Lazzaro di Savena. Quando vidi il cartello “Igiene
mentale”, mi crollò il mondo addosso. Fu per me come per Dante nella
Divina Commedia entrare all’inferno. Per molto tempo rifiutai la
diagnosi di psicosi, poi col tempo ne presi atto e ora ci convivo
abbastanza bene. Allo stesso modo entro ed esco dai Centri di Salute
Mentale in tutta disinvoltura. Per fortuna questa vergogna è stata
vinta, insieme a quella di tutte le malefatte che ho combinato nella
mia vita. Sì, scrivendo mi sono tolto un grande peso o per lo meno il
dolore, più o meno latente, legato alla vergogna. Dolore che può
diventare esagerato, tanto da non vedere, non sentire e non elaborare
la realtà in modo corretto. Dolore che può spingere al suicidio. So che
esistono diverse cause di suicidio: tutti hanno il loro perché e sono
anche difficili da gestire, sia psichiatricamente che psicologicamente,
perché il dolore può diventare veramente insopportabile. Ma il tempo e
le cure possono aiutare. A chi soffre per vergogna mi sento di dire che
la vita può cambiare e chi non ha mai peccato scagli la prima pietra.
Per questo leggete Il Faro e vedrete che illuminerà la vergogna da una prospettiva diversa, dandole, tra gli estremi, il giusto equilibrio.
|
|
|
PUNTI DI VISTA
 Paolo Arata
Paolo Arata
D
a un immaginario e surreale dialogo:
- Vergogna! Ma che vergogna! Vergognati! Devi solo vergognarti! Sei
la vergogna di tutti noi! Sì, dico proprio a te, svergognato! Ma
proprio non ti vergogni di quel che fai e di quel che ti passa per la
testa?
- No, aspetta un momento, vergogna per che cosa? Perché dovrei
vergognarmi? Me lo hai già detto altre volte, ma stavolta ho letto lo
Zingarelli e lì c’è scritto che la vergogna è “un turbamento o timore
che si provano per azioni, pensieri o parole che sono o si ritengono
sconvenienti”.
- Sì, appunto, la definizione calza a pennello per tutte le cose di
cui devi vergognarti. Te ne ricordo solo qualcuna e non venirmi a dire
che non sono vere:
- Vai in giro nudo, senza nulla addosso! / Ma qui siamo in un campo per soli nudisti…
- Hai mangiato carne di maiale ieri sera! / Ma io non sono di religione musulmana…

- Ti metti le dita nel naso! / Ma ho solo cinque anni e poi nelle auto ferme al semaforo lo fanno tutti…
- Hai mangiato il polpaccio di quel poveraccio morto in battaglia! / Ma per la nostra tribù mangiare il nemico valoroso significa acquisire le sue virtù…
- Mi hai mandato “a quel paese” chiudendo due dita a cerchio! / Ma per noi occidentali quello significa “OK”…
- Ti sei fatto la cacca addosso! / Ma avevo due anni di età e non c’erano i pannolini…
- Hai due mogli contemporaneamente! / Ma la nostra religione ne permette fino a tre…
- Sei arrivato tardi all’appuntamento!/ Ma siamo a Roma, mica in Svizzera…
- Hai detto una volgarità! / Veramente ho detto che mi piace molto la Passerina di Gigi, che è il più famoso produttore di quell’ottimo vino d’Abruzzo…
- Hai rubato una pagnotta e mezzo litro di latte al supermercato! / Ma ho perso il lavoro ed era una settimana che i miei figli non mangiavano…
- Tua sorella va in giro con la gonna sopra il ginocchio! / Guarda che le gonne lunghe non le fabbricano più da oltre sessant’anni…
- Hai toccato il sedere di quella mia amica! / Ma sono un chirurgo plastico e le ho fatto la liposuzione…
- Hai un fratello “diverso”! / Eh no, in questo caso semmai mi vergognerei di vergognarmi…
- Insomma, trovi tutte le scuse per non vergognarti…
Ma allora, la vergogna esiste o è un’invenzione di qualcuno a cui fa
comodo metterci in soggezione? Sì, certo, esiste e ha una notevole
valenza sociale, ma come tutte le cose è relativa e sorge solo se quel
che si fa, si pensa o si dice è ‘sconveniente’ nella percezione delle
persone con cui ci relazioniamo e se di tale ‘sconvenienza’ ci rendiamo
conto. Potremmo infatti fare qualcosa di cui vergognarci ma non
rendercene conto (e quindi non vergognarcene) perché non ci accorgiamo
di urtare la sensibilità dei nostri interlocutori o, viceversa,
potremmo avere il timore (e quindi vergognarci) di aver fatto qualcosa
che a nostro avviso è ‘sconveniente’, che però non lo è affatto per i
nostri interlocutori (un fragoroso rutto a fine pranzo è decisamente
una cosa ‘vergognosa’ per la nostra cultura, ma in Cina può essere una
vergogna non farlo perché significa che non abbiamo apprezzato il
cibo).
Prima di fare o dire (o pensare) qualcosa, dovremmo pensare al contesto
in cui ci troviamo, alle persone che abbiamo intorno e a cosa vogliamo
comunicare: ridurremo il rischio di doverci vergognare o di mettere in
imbarazzo i presenti (o, al contrario, lo incrementeremo
esponenzialmente perché il nostro intento è proprio quello di
scandalizzare gli altri, ma almeno non potremo dirci sorpresi per le
ovvie reazioni che otterremo).
BURP!
|
|
|
UN SENTIMENTO COMPLESSO
 Patrizia Degli Esposti
Patrizia Degli Esposti
H
 o
chiesto a mia madre di anni ottantotto cosa è per lei la vergogna, mi
ha risposto “Qualcosa di cui si potrebbe anche fare a meno”. o
chiesto a mia madre di anni ottantotto cosa è per lei la vergogna, mi
ha risposto “Qualcosa di cui si potrebbe anche fare a meno”.
La vergogna come disagio, come senso di inferiorità, una sorta di
umiliazione per qualche cosa di detto o fatto che non è esattamente
quello che volevamo dire o fare. La timidezza, l’insicurezza ci blocca
e crea quel senso di vergogna nell’affrontare il prossimo e fa sì che
ci sentiamo impacciati e ridicoli. L’educazione ricevuta fin
dall’infanzia e la cultura della società in cui viviamo ci trasmettono
messaggi che inducono a provare vergogna. La vergogna è un sentimento
complesso che ci pervade e può bloccare le nostre azioni, è associata
al giudizio che gli altri possono dare su di noi, ma parte dalla
percezione che abbiamo di noi stessi e dal nostro sentirci
inadatti.Muoversi in un ambiente dove gli occhi sono puntati su noi, un
colloquio di lavoro, un esame, parlare in pubblico o, semplicemente,
entrare in un negozio per chiedere il prezzo di un oggetto possono
generare sensi di vergogna e in alcuni casi creare un blocco fisico e
la rinuncia a compiere una certa azione.
Ho un ricordo legato al senso di vergogna che ho provato. Ero una
ragazzina di quattordici anni e indossavo un abitino di cotone leggero
con le maniche lunghe. Era una vestito confezionato da una sarta e mi
sentivo elegante. Era una domenica pomeriggio di primavera inoltrata e
chiacchieravo piacevolmente con altri coetanei sotto al sole. Cominciai
a sudare e non ebbi il coraggio di dire al gruppetto di spostarci
all’ombra. Sudavo e nell’abitino, proprio sotto le ascelle, cominciò a
formarsi una macchia umida. Mi vergognavo di quella macchia umida e per
nasconderla tenevo le braccia incrociate. Così la macchia umida si
estese ulteriormente formando un alone scuro che si allargava e
prendeva una sua forma ormai impossibile da nascondere pur tenendo le
braccia appiccicate al corpo. Non ho più indossato quell’abitino
nonostante fosse carino e mi stesse bene. La vergogna provata si
riaffacciava ogni qualvolta lo vedevo e non volevo più provare quel
disagio. Forse avrei dovuto indossarlo nuovamente e se si fosse formato
l’alone di sudore avrei potuto riderci sopra e condividerlo senza
sentirmi impacciata e fuori luogo. Forse affrontando le nostre
vergogne, ripetendo i gesti o le parole che le hanno generate, potemmo
liberarcene o conviverci senza dolore.
Vivere senza giudicarci, impresa difficilissima, ed essere fieri anche
dei nostri errori, senza cadere nella presunzione, potrebbe emanciparci
dalla vergogna.
|
|
|
DALLA FOGLIA DI FICO AL MARCHIO DI CAINO
 Lucia
Lucia
 Fra le mie prime esperienze di vergogna
mi vengono in mente: il disagio nello spogliarmi di fronte a estranei,
la voglia di ‘sprofondare’ per lo scoprimento di una bugia, i rossori
incontrollabili della prima ‘cotta’, l’imbarazzo di trovarmi
impreparata a qualche prova scolastica… Circostanze dell’infanzia e
dell’adolescenza che ricordo in modo vivissimo, proprio per le forti
emozioni provate. Queste emozioni sono una scuola di vita importante,
perché da grandi, lo sappiamo tutti, il gioco si fa duro. Per esempio
bisogna imparare a difendersi dai sensi di colpa e di inadeguatezza e
riuscire a rapportarsi in modo educato ma fiero con le persone
impietose e ‘giudicanti’ (sembra che a loro non si possa mai rispondere
per le rime, ma si impara, si impara…). Anche mettere in riga gli
spudorati è un esercizio non facile. Da genitori, poi, bisogna imparare
a educare i figli al contegno e al ritegno… E via andare.
Fra le mie prime esperienze di vergogna
mi vengono in mente: il disagio nello spogliarmi di fronte a estranei,
la voglia di ‘sprofondare’ per lo scoprimento di una bugia, i rossori
incontrollabili della prima ‘cotta’, l’imbarazzo di trovarmi
impreparata a qualche prova scolastica… Circostanze dell’infanzia e
dell’adolescenza che ricordo in modo vivissimo, proprio per le forti
emozioni provate. Queste emozioni sono una scuola di vita importante,
perché da grandi, lo sappiamo tutti, il gioco si fa duro. Per esempio
bisogna imparare a difendersi dai sensi di colpa e di inadeguatezza e
riuscire a rapportarsi in modo educato ma fiero con le persone
impietose e ‘giudicanti’ (sembra che a loro non si possa mai rispondere
per le rime, ma si impara, si impara…). Anche mettere in riga gli
spudorati è un esercizio non facile. Da genitori, poi, bisogna imparare
a educare i figli al contegno e al ritegno… E via andare.
Tra le varie emozioni la vergogna è a mio parere la più… ‘umana’.
Infatti ha stretta attinenza con la consapevolezza, e quest’ultima è
forse la caratteristica che ci differenzia dagli altri esseri viventi.
Dico ‘forse’ perché, non potendo entrare nella loro testa, non sono poi
così sicura che gli animali non siano invece dei saggi, arrivati al
dunque prima di noi. Fatto sta che - a quanto pare - loro non si
vergognano dei comportamenti a cui l’istinto li guida, si accontentano
di vivere secondo natura, senza farsi troppe domande. Noi, invece, ci
vergogniamo un sacco, per i motivi più svariati, e ci facciamo
condizionare dalla considerazione di ciò che gli altri possono pensare
o dire di noi. Questa attenzione a comportarci ‘come si deve’ viene
definita con una curiosa espressione: ‘rispetto umano’. Più che di
rispetto, però, mi pare si tratti di ipocrisia. Fra gli animali, l’uomo
si distingue anche in quanto ‘nudo’ e quindi bisognoso di ricoprirsi.
Certo, il freddo, il troppo sole, le punture degli insetti, gli urti, i
graffi, insidiano la nostra pelle delicata, ma a parte questo, perché
quando siamo senza vestiti ci sentiamo ‘nudi come vermi’? Perché
consideriamo vergognose certe parti e certe funzioni del nostro corpo?
Il ‘pudore’, lo sappiamo, è un fatto culturale: dipende da tante
variabili (luoghi, epoche, religioni, assetti sociali…) ed è
costantemente soggetto a evoluzione (e involuzione). Date le sue tante
ricadute sulla vita di relazione, ciò che ha a che fare con la
corporeità e la sessualità occupa in tutte le culture una parte
sostanziosa della morale, dell’educazione e del diritto (tanto per
dire, nel nostro ordinamento il ‘comune senso del pudore’, peraltro
attualmente piuttosto ‘affievolito’, rientra fra gli elementi di
valutazione del giudice penale). Ci sono però motivi di vergogna, che
mi sembrano più seri.
 Per
spiegarmi meglio, pur senza voler rubare il mestiere a biblisti e
teologi, partirò da Adamo ed Eva, come in ogni elucubrazione che si
rispetti. Nella Genesi
la vergogna entra subito in scena, e proprio insieme alla nudità. Appena creati, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Poi mangiarono il frutto dell’albero proibito, che dava la conoscenza del bene e del male. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ecco, la consapevolezza… Ma
il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho
udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi
sono nascosto”. Il nostro Adamo, dunque, non si nasconde per
pudicizia - del resto non c’era nessuno al mondo che non l’avesse già
visto nudo - ma per paura! Ha paura di essere ‘scoperto’, colto in
fallo. Nudo, di fronte a Dio, a cui non la si fa… Ecco, la vera
vergogna: l’intima coscienza di aver agito male. Per
spiegarmi meglio, pur senza voler rubare il mestiere a biblisti e
teologi, partirò da Adamo ed Eva, come in ogni elucubrazione che si
rispetti. Nella Genesi
la vergogna entra subito in scena, e proprio insieme alla nudità. Appena creati, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Poi mangiarono il frutto dell’albero proibito, che dava la conoscenza del bene e del male. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ecco, la consapevolezza… Ma
il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho
udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi
sono nascosto”. Il nostro Adamo, dunque, non si nasconde per
pudicizia - del resto non c’era nessuno al mondo che non l’avesse già
visto nudo - ma per paura! Ha paura di essere ‘scoperto’, colto in
fallo. Nudo, di fronte a Dio, a cui non la si fa… Ecco, la vera
vergogna: l’intima coscienza di aver agito male.
Di pudore e decenza la Genesi
si occuperà un po’ più avanti, narrando della posa sconveniente in cui
Noè si addormentò a causa dell’ubriachezza e dei diversi atteggiamenti
dei suoi figli in quella circostanza, ma questa è un’altra storia.
Nell’esperienza umana la vergogna può essere motivata da un piccolo
difetto, reale o presunto, come da una causa grave, si declina quindi
sia in emozioni immediate e passeggere che in sentimenti duraturi, che
vanno dall’imbarazzo al disagio, dal turbamento alla mortificazione,
dal pentimento alla costernazione. Le sue manifestazioni esteriori
possono essere più o meno vistose, ma ciò non dipende tanto dalla
gravità del fatto, quanto dalla ‘scorza’ di cui la persona è dotata: ai
giovanissimi e ai timidi capita facilmente di lasciar trapelare forti
emozioni anche per cause oggettivamente insignificanti, al contrario
persone ‘incallite’ dall’esperienza di vita possono riuscire a sembrare
impassibili - e forse addirittura a esserlo - pur avendo la coscienza
molto sporca. Coll’ispessirsi della ‘scorza’, il sentimento stesso
della vergogna tende ad affievolirsi, e si passa dalla ‘faccia tosta’
all’impudenza, dall’insensibilità morale all’efferatezza. Malignità e
vergogna, insomma, sono inversamente proporzionali: più si consolida la
capacità di compiere il male e meno si prova vergogna. E viceversa.
Continuando la lettura della Genesi assistiamo a una specie di escalation:
dall’ingenuità delle vane giustificazioni dei due malconsigliati
progenitori, si arriva per gradi all’empietà irriducibile dei loro
corrotti e svergognati epigoni. Cacciati dall’Eden, Adamo ed Eva
cominciano a riprodursi e fin dall’inizio hanno l’amara esperienza di
vedere nei propri figli lo scontro fra il bene e il male: Caino,
invidioso del fratello Abele, lo uccide. Di fronte a Dio che lo accusa,
si mostra già diverso dai genitori: è capace di dissimulazione,
risponde con ardire e di fronte alla maledizione divina ha anche la
sfrontatezza di contrattare sulla pena, convinto com’è che sarà
respinto dal consorzio umano e forse ucciso. Nella sua egoistica
preoccupazione si può intravedere il sorgere di un altro tipo vergogna,
quella ‘sociale’: il timore per il vituperio dei propri simili, la
‘gogna’ e il probabile linciaggio… E allora il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.
Caino sopravvivrà, potrà riprodursi e fondare città, ma nella sua
stirpe la tendenza al male e la relativa impudenza aumenteranno
progressivamente, fino a che Dio preferirà distruggere un’umanità
irrimediabilmente corrotta. E sarà diluvio universale.
Mi sono sempre interrogata sul senso del marchio di Caino, uno stigma
che espone, sì, il colpevole alla riprovazione generale, ma nel
contempo può salvarlo. Ma come? Mi vien da pensare che quel tocco
divino abbia a che fare in qualche modo proprio con la vergogna,
sentimento che facendoci soffrire intimamente può indurci a voler
rimediare, pentirci, chiedere perdono, cambiare vita. Anche se il male
compiuto non si cancella, grazie alla vergogna si può imparare a non
ripeterlo. Anche se i nostri limiti ci portano a commettere
continuamente errori, grazie alla vergogna ci possiamo sforzare di
superarli… Insomma la vergogna ci offre un’opportunità di riscatto, sta
a noi saperla cogliere. Ma guai a chi non prova vergogna!
|
|
|
VERGOGNA VICARIA
 Antonio Marco Serra
Antonio Marco Serra
Non vergognarsi mai e osare tutto,
pochissimi sanno quale messe
di vantaggi ne derivi.
Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, 1511
Ho qualche difficoltà a scrivere un
articolo sulla vergogna, perché sinceramente ho scarsa frequentazione
con questa emozione. Non so se ciò sia un bene o un male, ma tant’è.
Ogni tanto qualcuno ci prova, a farmi vergognare di qualcosa che ho
fatto, peccato che solitamente si tratti delle cose di cui più vado
orgoglioso. Misteri della vita. La sensazione di vergogna più profonda
che credo di aver provato, e che mi porto dietro ancor oggi, risale a
un episodio avvenuto quando avevo, credo, sette o otto anni: erano anni
in cui erano in auge le collezioni di figurine da attaccare su degli
album appositi. Un giorno che ero indispettito con mia sorella per
qualche motivo, che ormai non ricordo più, mi rifiutai di darle una
figurina che mi chiedeva, benché l’avessi ‘doppia’, proprio per farle
dispetto; un comportamento che subito dopo vissi come un’azione di
malvagità gratuita ed abissale. E sin da subito, provai una grande,
penosissima vergogna per quel mio comportamento, e in fondo non me ne
sono mai liberato. Non voglio dire che questo ricordo mi tormenti
tutt’oggi, sarebbe troppo, ma il solo fatto che ricordi ancora un
accadimento apparentemente così insignificante, la dice lunga. Quello
appena esposto è un caso di vergogna ‘autonoma’, una vergogna che non
coinvolge il giudizio che altri possono avere su di noi, ma nasce dalla
constatazione di un profondo divario tra ciò che noi riteniamo
eticamente accettabile, e ciò che abbiamo concretamente messo in atto.
Almeno in prima approssimazione potremmo dire che in questo caso la
vergogna è la plastica espressione della nostra difficoltà a convivere
con un nostro senso di colpa.
Ma questo è solo uno dei due volti di un’emozione bifronte: esiste
anche una vergogna ‘eteronoma’, che è anzi la più diffusa, una vergogna
che è indissolubilmente legata al giudizio che gli altri hanno di noi
(o almeno: al giudizio che noi crediamo gli altri abbiano di noi).
Un’emozione che il racconto biblico pone agli albori del genere umano:
Adamo ed Eva, dopo aver mangiato il frutto dell’albero della conoscenza
del bene e del male, si accorgono di essere nudi e provano vergogna
delle proprie nudità, l’uno di fronte all’altro, ed entrambi di fronte
a Dio. E da allora sembra che l’essere umano non abbia cessato di
vergognarsi delle cose più disparate, e, almeno in molti casi, si
direbbe con ragione.
Non possiamo poi dimenticare che la vergogna sembra rivestire anche un
ruolo di controllo e di normalizzazione sociale: chi sgarra dalle
consuetudini stabilite, viene fatto oggetto di una serie di iniziative,
perché, gli piaccia o meno, provi vergogna per il proprio operato, come
è testimoniato ancor oggi da modi di dire quali “additare alla pubblica
vergogna”, ma che in passato comportava che gli autori di comportamenti
inaccettabili in una data società, venissero fatti oggetto di concrete
azioni punitive, quali l’esser mostrati immobilizzati in una gogna,
nella pubblica piazza, esposti al ludibrio della folla.
 Sorte che toccò anche a Daniel Defoe, l’autore del Robinson Crusoe,
per aver composto un pamphlet giudicato diffamatorio per la Chiesa
Anglicana. E Defoe, da par suo, seppe subito dopo vendicarsi,
componendo un altro pamphlet, il satirico Inno alla gogna.
Sorte che toccò anche a Daniel Defoe, l’autore del Robinson Crusoe,
per aver composto un pamphlet giudicato diffamatorio per la Chiesa
Anglicana. E Defoe, da par suo, seppe subito dopo vendicarsi,
componendo un altro pamphlet, il satirico Inno alla gogna.
Le gogne, almeno quelle fisiche, non esistono più nel mondo
Occidentale, ma il suo pamphlet, a distanza di oltre tre secoli, viene
ancora letto e tradotto: le forme del controllo sociale, per quanto
gravose, sono caduche, le forme dello spirito umano che ad esse si
oppongono, paiono eteree, ma hanno la potenzialità di durare in eterno.
Chiunque può tentare di farci vergognare, ma solo se, a causa delle
nostre debolezza, ignavia e infingardaggine, accettiamo acriticamente
il giudizio altrui, costoro possono realmente legare il nostro spirito:
siamo noi, e soltanto noi, che glielo consentiamo.
Un’altra forma di controllo sociale attraverso la vergogna, che ha
lasciato una notevole traccia letteraria, era la consuetudine
seicentesca, nelle Colonie del New England, di far indossare alle
adultere, sopra ai vestiti, una pezza di stoffa su cui era ricamata una
“A” di colore rosso, o almeno questo è quello che ci racconta,
splendidamente, Nataniel Hawthorne nel suo romanzo La lettera scarlatta.
Che, a rileggerlo oggi, non può non richiamarci alla mente una ben più
recente e ben più terribile consuetudine: l’obbligo imposto dai nazisti
agli ebrei, di cucire sui propri vestiti una croce di David gialla:
l’anticamera della Shoah.
Sembra che oggi una nuova forma di gogna mediatica, abbia trovato la
sua strada d’elezione nei social network, con esiti, in alcuni casi,
tragici. Non starò a citare casi particolari, che ciascuno di noi ha
letto negli ultimi anni sui quotidiani. Io, che non sono mai stato un
fan sfegatato della privacy, confesso che faccio fatica a provare una
reale empatia con alcune (solo alcune) delle vittime di tali forme di
cyberbullismo: se non si vuole che un certo nostro comportamento
divenga di dominio pubblico, la strada maestra resta una sola: non
compiere quelle azioni. Se è vero che gli altri non dovrebbero avere il
diritto di propalare ai quattro venti fatti riservati, dovremmo essere
noi stessi, a imporci di non compiere mai azioni che non possano essere
rese pubbliche senza timore di dovercene vergognare. “Vivi in modo tale da non doverti vergognare di vendere il tuo pappagallo ai pettegoli della città”, diceva Will Rogers, famoso attore hollywoodiano dell’epoca del cinema muto.
Se, come ho detto, ho scarsa frequentazione con la vergogna, a livello
personale, ho invece parecchia dimestichezza, anche troppa, con quella
che viene chiamata vergogna ‘vicaria’, quando ci vergogniamo, cioè, del
comportamento di altre persone, anche nel caso in cui queste, non ne
provino alcuna. Anzi, il fatto che non provino vergogna, accresce la
nostra. A me ciò capita, immancabilmente, quando mi pare che chi ho
dinnanzi, abbia abdicato al proprium
della propria condizione umana. Abbia appannato lo splendore del
proprio spirito, rifugga con timore, se non addirittura con terrore,
dalle grandi parole, dalle grandi azioni, dai grandi sentimenti, e da
tutto ciò che, in fondo, dovrebbe distinguere un essere umano da un
criceto, da un bradipo tridattilo o da uno scarabeo stercorario.
 Se Domineddio ci avesse voluti criceti, bradipi tridattili o scarabei stercorari, non ci avrebbe dotati di libero arbitrio [vedi nota a fondo articolo].
Se è vero che di ciò che ci accade controlliamo davvero pochino, per me
è altrettanto vero che ciò che decidiamo (o decidiamo di non decidere)
è di nostra esclusiva pertinenza, ed è ciò che ci rende uomini, nel
vero senso della parola. Se Domineddio ci avesse voluti criceti,
bradipi tridattili o scarabei stercorari non ci avrebbe fatti capaci di
commozione di fronte a una statua di Fidia, a una sinfonia di Mozart, a
una poesia di Hölderlin, e soprattutto non ci avrebbe fatti capaci di
scolpire quella statua, di comporre quella sinfonia, di scrivere quella
poesia.
Se Domineddio ci avesse voluti criceti, bradipi tridattili o scarabei stercorari, non ci avrebbe dotati di libero arbitrio [vedi nota a fondo articolo].
Se è vero che di ciò che ci accade controlliamo davvero pochino, per me
è altrettanto vero che ciò che decidiamo (o decidiamo di non decidere)
è di nostra esclusiva pertinenza, ed è ciò che ci rende uomini, nel
vero senso della parola. Se Domineddio ci avesse voluti criceti,
bradipi tridattili o scarabei stercorari non ci avrebbe fatti capaci di
commozione di fronte a una statua di Fidia, a una sinfonia di Mozart, a
una poesia di Hölderlin, e soprattutto non ci avrebbe fatti capaci di
scolpire quella statua, di comporre quella sinfonia, di scrivere quella
poesia.
Provo una vergogna, ma anche una pena, infinite, quando mi trovo di
fronte a persone il cui unico imperativo di vita sembrerebbe essere
quello di ’volare bassi’, di non impegnarsi in alcuna azione degna di
nota, di vergognarsi persino di ‘credere’ in qualcosa. La
giustificazione che spesso costoro danno a sé stessi è che il mondo è
una giungla, e che più si resta seppelliti nella propria tana, meno
rischi si corrono. Peccato che, per mia esperienza personale, proprio
costoro sono le persone più infelici che abbia conosciuto. E come
potrebbe essere altrimenti? Se si nega la propria natura, è inevitabile
che la natura stessa si vendichi. Sforzarsi di comportarsi come un
bradipo tridattilo, va benissimo, se si è un bradipo tridattilo;
trascinare palline di merda va benissimo, se si è uno scarabeo
stercorario, ma se si è un essere umano, è una strategia devastante che
non può che portare sofferenze indicibili.
Pensiamo, ad esempio, alla cosiddetta sindrome della crocerossina (Wendy Syndrome,
in ambiente anglosassone, dal nome dell’amica di Peter Pan) - che, si
badi bene, non riguarda affatto solo persone di genere femminile, ci
sono nel mondo anche tanti crocerossini! - che secondo me rappresenta
la rappresentazione plastica del ‘volare basso’ nel campo dei
sentimenti. Persone che riescono a istituire rapporti con gli altri (in
particolare nei rapporti di coppia) solo con persone particolarmente
malmesse o immature, a cui immaginano di sacrificare sé stesse, senza
chiedere niente in cambio, per il loro bene. Apparentemente questo
potrebbe essere scambiato con un atteggiamento altruistico, sia pure
spinto agli estremi, ma gli studi psicologici su tale persone ci
rivelano che è esattamente il contrario: il/la crocerossino/a è una
persona profondamente insicura, con una scarsa autostima, un estremo
bisogno del consenso altrui e teme patologicamente l’abbandono (alcuni
vi vedono una relazione stretta con un disturbo psichiatrico
ufficialmente riconosciuto: il disturbo dipendente di personalità). In
fondo credo ci troviamo di fronte a una paura mascherata: quella di
porsi in relazione con qualcuno al proprio livello, e preferire invece
di rapportarsi con chi, a causa della sua manifesta inferiorità,
difficilmente ci metterà a disagio, e che, ci illudiamo, potremo
manipolare a nostro piacimento. Ovviamente questa è solo una pia
illusione. Nel caso in cui, poi, il partner della Wendy di turno sia il
Peter Pan di turno, l’unico effetto della relazione sarà quello di
alimentare il suo ego, inabissandolo sempre più nella propria
immaturità. E purtroppo i disturbi di entrambi si autoalimenteranno,
creando un circolo vizioso da cui risulterà sempre più difficile uscire
e che, ovviamente, porterà solo una massa di sofferenze indicibili ad
entrambi.
Se qualcuno, spero - nel 2019 - pochi, volesse obiettare che tutto
questo parlare di grandi e nobili sentimenti è in fondo una presa in
giro, perché Freud ci ha insegnato che essi non sono altro che la
‘sublimazione’ delle nostre pulsioni sessuali, non volendo sporcarmi le
mani a contestare una teoria così palesemente ridicola (e direi anche
estremamente bigotta, diciamocela tutta: Freud era un gran bigotto!)
lascio il compito al noto psichiatra e psicanalista del secolo scorso,
Elvio Fachinelli, che non aveva paura di parlare della “miseria
incurabile della teoria della sublimazione, che tenta di spiegare ciò
che, se è sublime, è sublime sin dal principio. La psicanalisi
dichiara: ecco un letterato chiaramente nevrotico; un filosofo
ossessivo; un matematico quasi psicotico, un musicista autistico... Ma
la legna da ardere non spiega di per sé il divampare del fuoco” (La mente estatica,
1989). La legna da ardere può ben essere un bradipo tridattilo, ma il
divampare del fuoco, no: quel falò è l’uomo e solo l’uomo. Se manca
quel falò, manca l’uomo. Potremmo, in quel caso, lasciandoci penzolare
dai rami di un albero, cercare di farci passare per dei bradipi
tridattili, ma dubito che inganneremmo qualcuno.
Non vorrei però che da quanto sinora scritto, si pensi che io sia
convinto che la strada dell’essere pienamente uomini, di impegnarci in
ciò che è puro, nobile e giusto, sia una strada lastricata solo di
rose. A me che, pur avendo scelto altre strade, provengo da una cultura
cristiana, a volte piace fare un bagno di sano realismo e fissare
dritto negli occhi, senza timore alcuno, una persona che, nel
contemplare il proprio ‘glorioso’ destino, sudava sangue. Gesù, al
Gethsemani, non appare felice e gioioso di bere dal calice che gli
viene propinato, né pensa si tratti del miglior cocktail che suo Padre
gli avrebbe potuto shakerare. Non prova alcun piacere al pensiero di
morire, e morire di croce, sia pure per riscattare in questo modo
l’intero genere umano. “Padre, allontana da me questo calice”, sono queste le sue inequivocabili parole. “Allontanalo!”. È così poco felice del destino che il Padre gli ha apprestato che “essendo in agonia il suo sudore divenne come gocce di sangue, che colavano sino a terra”. E solo a malincuore aggiunge: “Non ciò che io voglio, ma ciò che Tu vuoi”.
Ecco, mi piace pensare che Gesù avrebbe provato una vergogna infinita,
se non avesse aggiunto questa disponibilità al proprio destino, una
vergogna che - evidentemente -
sarebbe stata ben peggiore della morte di croce.
Non c’è nulla di cui vergognarsi, se ciò che ci appare eticamente
giusto, non è di nostro gradimento, ci angoscia o ci impaura, c’è da
vergognarsi solo se questa paura ci impedisce di fare comunque ciò che
riteniamo giusto vada fatto.
NOTA
È vero che l’esistenza stessa del libero arbitrio è stata messa in
dubbio, a partire dall’epoca illuministica, in quanto in contrasto con
la visione deterministica della natura da allora imperante. Scriveva il
grande matematico e astronomo Pierre-Simon Laplace: “Ammesso
per un istante che una mente possa tener conto di tutte le forze che
animano la natura, assieme alla rispettiva situazione degli esseri che
la compongono, se tale mente fosse sufficientemente vasta da poter
sottoporre questi dati ad analisi […] per essa niente sarebbe incerto
ed il futuro, così come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi”.
E questo lascerebbe davvero poco posto ad ogni decisione autonoma da
parte di chicchessia. Visto però che le attuali leggi che regolano il
mondo della natura, non sono affatto deterministiche (uno dei loro
punti cardini è il Principio di indeterminazione di Werner Heisenberg,
più chiaro di cosi!), non sento la necessità di dilungarmi sulla
questione, e me la cavo a buon mercato con una citazione del pandit
Nehru: “La vita è come un gioco a carte: la mano che ti viene
servita rappresenta il determinismo, il modo in cui la giochi è il
libero arbitrio”.
|
|
|
LA VERGOGNA E LE MASCHERE
 Luigi Zen
Luigi Zen
L
 e maschere veneziane in origine servivano per coprire il viso quando si
doveva andare a svuotare i vasi nelle latrine. Nelle antiche ville
venete c’erano delle grandi sale e delle scale per salire al piano di
sopra, dove i bagni erano in parete. Perciò le persone si mettevano le
maschere per non essere riconosciute…Le maschere, durante il carnevale
e non solo, servivano anche in altre occasioni di vergogna o di
trasgressione. Anche i cappucci dei cappuccini, frati questuanti,
avevano un significato anti vergogna. L’uso di incappucciarsi è tipico
di confraternite e associazioni illecite, segrete, come nel caso dei
Beati Paoli siciliani, dei Ninja giapponesi, del Ku Klux Klan
americano. Invece le maschere di un supereroe, come ad esempio l’Uomo
Ragno, servono a proteggere la sua identità e la sua vita privata.
e maschere veneziane in origine servivano per coprire il viso quando si
doveva andare a svuotare i vasi nelle latrine. Nelle antiche ville
venete c’erano delle grandi sale e delle scale per salire al piano di
sopra, dove i bagni erano in parete. Perciò le persone si mettevano le
maschere per non essere riconosciute…Le maschere, durante il carnevale
e non solo, servivano anche in altre occasioni di vergogna o di
trasgressione. Anche i cappucci dei cappuccini, frati questuanti,
avevano un significato anti vergogna. L’uso di incappucciarsi è tipico
di confraternite e associazioni illecite, segrete, come nel caso dei
Beati Paoli siciliani, dei Ninja giapponesi, del Ku Klux Klan
americano. Invece le maschere di un supereroe, come ad esempio l’Uomo
Ragno, servono a proteggere la sua identità e la sua vita privata.
|
|
|
DIVENTARE ROSSI DALLA VERGOGNA
 Maria Angela Soavi
Maria Angela Soavi
 La vergogna è una forte sensazione, che
possiamo percepire in situazioni particolari, per esempio se un amico
insiste nel voler raccontare ad altri come la pensiamo noi su un
determinato argomento nel momento meno opportuno per farlo. Oppure
quando mentiamo, ma ci vergogniamo solo se veniamo smascherati.
La vergogna è una forte sensazione, che
possiamo percepire in situazioni particolari, per esempio se un amico
insiste nel voler raccontare ad altri come la pensiamo noi su un
determinato argomento nel momento meno opportuno per farlo. Oppure
quando mentiamo, ma ci vergogniamo solo se veniamo smascherati.
Ma perché, quando proviamo vergogna, arrossiamo? Fisiologicamente
arrossiamo quando l’adrenalina fa allargare i capillari che trasportano
il sangue alla pelle. Se arrossiamo emotivamente, generalmente è perché
la vergogna provoca imbarazzo e timidezza e sviluppa una forma di
linguaggio non verbale che rivela i nostri sentimenti quando meno ce lo
aspettiamo. Spesso arrossiamo proprio quando vorremmo passare
inosservati, perché il rossore è una reazione che a volte non riusciamo
a controllare. Il rossore può comparire anche in situazioni sociali non
opportune e ciò può causare eritrofobia. Il termine ‘eritrofobia’
deriva dall’unione di due parole greche: erythròs (rosso) e fobìa
(paura) cioè ‘paura di arrossire’. Questa condizione determina una
sensazione di forte disagio e vergogna che induce chi ne soffre a
sottrarsi alla vista, al contatto o al dialogo con altre persone.
Un’esperienza comune ma dolorosa è l’essere criticati: può scatenare
sentimenti di vergogna e può farci nutrire insicurezze circa l’essere
incompetente o non all’altezza. La critica quindi può essere utilizzata
strategicamente, come modalità per ottenere potere e controllo sugli
altri, per neutralizzare un rivale all’interno di una competizione…
 Con il termine ‘bullismo’ si intende un comportamento aggressivo,
ripetitivo, nei confronti di chi non è in grado di difendersi.
Solitamente i ruoli del bullismo sono ben definiti: da una parte c’è il
bullo, colui che attua comportamenti violenti, dall’altra la vittima,
colui che subisce tali atteggiamenti. La sofferenza psicologica e
l’esclusione sociale sono sperimentate spesso da bambini che, senza
sceglierlo, si ritrovano a rivestire il ruolo della vittima, subendo
umiliazioni da coloro che ricoprono il ruolo di bullo. Le sopraffazioni
avvengono soprattutto a scuola e la maggioranza delle vittime di
bullismo non denuncia per vergogna.
Con il termine ‘bullismo’ si intende un comportamento aggressivo,
ripetitivo, nei confronti di chi non è in grado di difendersi.
Solitamente i ruoli del bullismo sono ben definiti: da una parte c’è il
bullo, colui che attua comportamenti violenti, dall’altra la vittima,
colui che subisce tali atteggiamenti. La sofferenza psicologica e
l’esclusione sociale sono sperimentate spesso da bambini che, senza
sceglierlo, si ritrovano a rivestire il ruolo della vittima, subendo
umiliazioni da coloro che ricoprono il ruolo di bullo. Le sopraffazioni
avvengono soprattutto a scuola e la maggioranza delle vittime di
bullismo non denuncia per vergogna.
I ragazzi infatti credono che i compagni di classe li considerino dei
fifoni, che nessuno vorrà essere loro amico e si vergognano anche di
rivelare quanto accaduto ai genitori per timore di deluderli. La
strategia migliore per combattere il bullismo è la prevenzione. La
scuola è il principale luogo in cui si sviluppano le relazioni sociali
tra i bambini e proprio per questo ha la responsabilità di promuovere
la conoscenza reciproca, di insegnare il rispetto verso le altre realtà
socioculturali e religiose, di favorire l’autostima dei ragazzi, di
insegnare come affrontare i conflitti e soprattutto di inculcare le
regole della convivenza civile, scoraggiando sul nascere comportamenti
prepotenti e incoraggiando la denuncia. Essenziale è anche l’intervento
della famiglia: se il ragazzo o la ragazza è restio a confidarsi per
timore di essere mal giudicato, è opportuno che il genitore spieghi che
sono i comportamenti, non le persone che vanno corretti. Un ottimo
consiglio è condividere le preoccupazioni con la scuola, chiedere di
tenere d’occhio con discrezione il proprio figlio, segnalare il bullo a
un insegnante o al dirigente scolastico, dire al ragazzo di non
reagire, perché è esattamente quello su cui il bullo conta. Importante
è anche chiedere aiuto, a volte i ragazzi potrebbero sentire il bisogno
di rivolgersi ad altre persone, oltre ai genitori e agli insegnanti, in
questi casi l’aiuto di uno psicoterapeuta esperto può essere prezioso.
Può essere importante anche incoraggiare i giovani a sviluppare
amicizie al di fuori della sfera scolastica e partecipare ad attività
come ad esempio recitazione, danza, arti marziali, sport di squadra o
frequentare associazioni di quartiere che aiutino a rinforzare
l’autostima e la consapevolezza di sé. A conclusione di questa
argomentazione permettetemi di rivolgere a tutti questo invito:
“Vergogniamoci di fare il male e non di fare il bene, anche se nel
perseguire questo obbiettivo incontriamo delle difficoltà”.
|
|
|
L’ETÀ EVOLUTIVA E LA VERGOGNA
 Concy
Concy
Prima di entrare nel merito di una
significativa esperienza personale relativa al tema della vergogna,
ritengo sia utile e doverosa una premessa che definisca dal punto di
vista psicologico in modo chiaro e sintetico quest’emozione: la
vergogna è tra le più importanti emozioni secondarie (le emozioni
secondarie sono quelle che non sono presenti nell’essere umano sin
dalla nascita, ma sono fortemente legate all’ambiente culturale in cui
cresciamo). Si dice che essa genera reazioni di imbarazzo e di grande
disagio, non soltanto nella persona osservata, ma anche in quelle che
stanno osservando. A questo proposito, ho un ricordo talmente vivido
dei fatti che mi sono accaduti nell’età evolutiva, da poter escludere
categoricamente che i soggetti osservatori provassero in qualche modo
disagio, anzi...
L’età evolutiva: quanta vergogna, ma soprattutto che stressssss!
 Al compimento degli undici anni, ho avuto il menarca. Stavo
frequentando la quinta elementare. Il mio corpo subì nel giro di
pochissimo tempo una tale trasformazione, anzi, metamorfosi, da
trovarmi totalmente impreparata. Teniamo conto, che sto parlando di
fatti accaduti cinquant’anni fa, che mia madre, nata nel 1920, aveva
una propensione al dialogo poco più che zero e soprattutto che parlare
di certi argomenti era tabù, off-limits.
Mi sentivo una ragazzina goffa, buffa e bruttina nel corpo di
un’adulta. Di punto in bianco ero diventata anche la più alta delle mie
compagne di classe; anche il seno lievitò improvvisamente, fino a
raggiungere la quinta misura.
Al compimento degli undici anni, ho avuto il menarca. Stavo
frequentando la quinta elementare. Il mio corpo subì nel giro di
pochissimo tempo una tale trasformazione, anzi, metamorfosi, da
trovarmi totalmente impreparata. Teniamo conto, che sto parlando di
fatti accaduti cinquant’anni fa, che mia madre, nata nel 1920, aveva
una propensione al dialogo poco più che zero e soprattutto che parlare
di certi argomenti era tabù, off-limits.
Mi sentivo una ragazzina goffa, buffa e bruttina nel corpo di
un’adulta. Di punto in bianco ero diventata anche la più alta delle mie
compagne di classe; anche il seno lievitò improvvisamente, fino a
raggiungere la quinta misura.
Nonostante i miei tentativi di negazione, rimozione e rifiuto, dovevo
purtroppo fare i conti con la ‘dolorosa’ realtà. Rifiutavo di indossare
il reggiseno, facevo di tutto per coprire quelle forme ingombranti e
troppo vistose attraverso l’uso di indumenti larghi dai colori scuri,
per poter mimetizzare e celare il cambiamento. Quando ero costretta a
uscire, incrociavo le braccia sul petto a mo’ di paravento, di scudo:
questi escamotages
tuttavia, non sempre sortivano gli effetti sperati. Tutti i miei
compagni di scuola, ma anche ragazzi più grandi e giovani adulti, al
mio passaggio si lasciavano andare a fischi e ad apprezzamenti che mi
creavano disagio e grave imbarazzo; il tutto si traduceva in
sudorazione abbondante e acceso rossore del viso.
Pur di evitare tali situazioni, arrivai a studiare percorsi alternativi
a quelli soliti, pur di non trovarmi sulla strada nel mirino dei
capannelli fatti di soli uomini. Coprivo tragitti lunghissimi,
impiegando solitamente il doppio o il triplo del tempo necessario.
Questo tormento mi ha accompagnato per qualche anno, praticamente fino
a quando l’aspetto fisico non si è armonizzato con la mia generale
maturazione psicologica e mentale. Per la sottoscritta la fase
evolutiva, lo sviluppo, ha rappresentato un vero e proprio ‘calvario’.
Quando adesso, mi capita di tornare indietro nel tempo, nel ripensare a
quelle situazioni e ai vissuti di allora riaffiorano e rivivo, sì, le
sensazioni negative, ma sento di provare nei confronti della me stessa
di allora una grande tenerezza.
|
|
|
La vergogna
 Paola Scatola
Paola Scatola
Ti osannavo e ti dicevo
Sei mia!
Rossa, verde, blu o gialla.
Ora che ti ho…
Ma ti ho,
Cosa ho?
Ho te e me stessa.
Ora so che sono tua
Ma perché ti racconto
Ma perché sei così
Inumana mente mia.
|
|
|
Il vento
 Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Le mani agitate del vento
frusciando sottili spiragli
creano scompigli
nelle decisioni.
Manca il coraggio
controcorrente.
Cadono voli inquieti sussurri e grida
idee nude
di mente liberatoria.
|
|
|
Il consiglio
 Matteo Bosinelli
Matteo Bosinelli
Ricevere, in gennaio,
un consiglio per febbraio,
e ricevere, in novembre,
ugual consiglio per dicembre.
E così, protetto per tutto l’anno,
fronteggio con amici
violente ondate biancastre,
senza alcun danno però
per le nostre barche brunastre.
|
|
|
Verba volant
 Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Non proietto sonetti
su schermi giganti.
Non regalo dipinti
a illustri parenti.
Non creo sinfonie
per orchestre del mondo.
Non sono una star
ma un verso
in attesa di esordio
bozza di emozioni
fioritura pop
da frantumi di ipotesi
in cerca d’identità.
Vivo la scrittura
accanto al focolare.
Accetto inviti dalle fiamme
al camouflage.
Sprofondo nella cenere
lasciando libera
la mano inarrestabile
anarchica scribacchina.
Anagrammo immagini
senza soluzione.
Tutto è un gioco
con rischi di azzardo.
Verba volant
num scripta manent?
|
|
|
Liaisons amoureuses
 Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Cercando liaisons
che altri non vedono
elementi onirici
spasmi profondi
ricchi di passione
sorprendo lettori.
Il banale rivela
mille sfumature
di arcobaleni segreti.
Come nastro d'acqua
parole senza voce
trascinando chi legge.
Intimi ardori
suonano rintocchi
e il cuore fermo
al passato non finito
ritrova echi
e turbolenze vitali.
|
|
|
Rose rosse
 Maurizio Leggeri
Maurizio Leggeri
Rose e lusinghe
offerte da uomo
a qual donna,
crean sensazioni
color fuoco
che contagiano
per un attimo
petali sporgenti
di un volto vellutato,
facendo apparir
altre rose,
ancor più calde,
facendo apparir
guance rosse,
ancor più umane:
dando senso
al sangue
dell’universo.
|
|
|
I tuoi occhi
 Anna R. G.
Anna R. G.
I tuoi occhi
dentro ai
suoi.
Le tue mani
nelle sue.
I nostri
sguardi pieni
d’amore.
|
|
|
Tornata a casa lessi
 Enomis
Enomis
Ricordo quella vergogna
di chi era condannato alla gogna
che pure se era innocente
veniva deriso dalle persone
guardato nella sua faccia piangente
che nella vita era l’ultima visione.
Se penso alla vergogna
dico che poi anche insegna
a fortificare dai malumori
come far d’abitudine di contorno i rumori.
Con in mano la penna con cui scrivo
della città nella quale vivo
è banale la rima con vergogna
ma non mi interessano i tetti colorati
guardo la gente in faccia e una cosa si sogna
che tutti ci si scopra della vita innamorati.
|
|
|
Solitudine di Faro
 Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Giorgia Teresa Di Lullo (da Vox clamantis, 2016)
Le mani sporcate di farina altrui
scaricano immagini
da cuore diamantato
a animo di granito.
Filosofia a bocconcini
e prosopopea a peso
alzano temperatura emotiva
di molti lettori.
Felice chi legge
tra estasi e claustrofobia
prosa d'arte
estraendo radici quadrate
da ore domestiche
di faro solitario.
|
|
|
Via dalla gente
 Marcella Colaci
Marcella Colaci
Via dalla gente
che non sente, non vede, non parla
sulla collina mi fermerò
color smeraldo
a tratti vedrò l'oro del grano
e poi mi adagerò
stanca e senza più forze.
Il fianco poggerò
per poter vedere
dal basso in alto
le verità del cielo
senza coprire gli occhi
per udire e parlare
anche se affranta e logorata
mi sazierò dell'ossigeno
e si avvererà il sogno
di noi che nel ricordo
accende la stanza del piacere.
Dispiace dirlo
ma non posso essere fiera di me
che assecondo ma non provo amore
più per te che hai fatto di me
sposa ma senza velo
incapace di prenderti e portarti via
lontano da falsità che stupidamente
credevo non appartenerti.
Vedi la curva di smeraldo ed il grano
sono piaceri della natura
che osa straziarmi
e per pudore nasconde
quello di più caro:
l'amore.
|
|
|
2 Agosto
 Francesco Valgimigli
Francesco Valgimigli
Ho visto me stesso seduto
in una sala d’attesa,
senza orologio,
senza attesa.
Ho visto
i miei giorni
disgregarsi
in ali di vento.
|
|
|
Il sorriso di una donna
 La Poetessa della Riva Sinistra
La Poetessa della Riva Sinistra
Ti ho conosciuto dolce e innamorato,
poi nel tempo sei cambiato,
come un diavolo ti sei rivelato:
la vita insieme a te era quella di un carcerato.
Quando parlavo sembravi sempre annoiato e,
se qualcosa sbagliavo, come un folle violento
eri trasformato.
Nulla serviva per guarire questo Amore Malato,
la passione e ugualmente l’odio,
sì, l’odio, ci avevano ingoiato
in un tunnel disperato.
Il mio cuore talvolta sentiva che era tutto
peccato, ma il mio volto emaciato
era rassegnato.
In un giorno di luce, finalmente,
ti dissi che ti avrei lasciato.
E, nel tuo stile, non l'hai mai accettato,
diventando geloso e opprimente
più di quello che eri stato.
Le minacce e i tormenti
sono le ultime cose che mi hai donato.
Le persone a me care mi avevano avvisato:
non stare mai sola, neanche un minuto...
Non è servito averti denunciato,
urlavi come un pazzo il tuo Amore Dannato,
quella sera fatale quando mi hai aspettato.
Non ricordo quante coltellate mi hai dato,
ma so che nulla e nessuno ti avrebbe fermato.
Non so ancora se ti ho perdonato, come Dio
mi ha insegnato...
Dove vivo ora, in un Giardino Incantato,
con ragazze e donne che hanno vissuto
un Amore Disperato,
c'è Armonia, c'è Speranza,
l'Amicizia e la Pace
che non hanno conosciuto.
Nel vostro mondo, ora, le donne muoiono
ed è tristemente scontato: io so di me
che non l'ho meritato.
Come nessuna donna merita di conoscere
la Bestia umana nascosta nell’uomo che ama.
Gentilissimi Signori, Mariti, Fidanzati, soprattutto EX,
ricordate che un tempo i nostri nonni dicevano
“Le donne non si toccano nemmeno con un fiore”.
Cercate di amarle e rispettarle ogni minuto, ogni giorno
della vita.
Perché una cosa bellissima di questa epoca sarebbe
non portare più fiori sulla loro tomba,
ma donarli ogni volta che
una Donna sorride.
|
|
|
Carapace di tartaruga
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti
Con questo spicchio arancio
che squisitamente
il mio tramonto illumina
voglio assaporare
il tuo dolce profumo
e farti indossare
una candida serica veste.
Io porterò un abito grigiastro
e scarpe con gomma
(ché il mio passo è forse malcerto)
e ti accompagnerò
con animo pronto
a godere avidamente
ogni momento che verrà.
I tuoi giorni ancora lunghi
i miei tempi tristemente lenti,
sarò quasi il tuo guscio di tartaruga.
(Sicuramente tra noi
ci sarà calore!)
|
|
|
La vergogna del nostro tempo
 Maurizio Leggeri
Maurizio Leggeri
Nelle vesti di un falso “buon senso”
e sulle ali di una vile propaganda
i paesi ricchi di qua e di là dell’atlantico
rifiutano le speranze bambine
che attraversano mari e deserti
per giocare con aquiloni più colorati.
Sono speranze strappate
alle sofferenze indicibili dei padri
seminate in guerre omicide
dagli stessi voraci ricchi paesi
per succhiare l’ultimo sangue
ai poveri diseredati della terra.
Ma i bambini cresceranno e tutti:
giovani, vecchi e tanti altri bimbi,
nel nord e nel sud del mondo
all’insegna della vera fratellanza
che non ama contese e confini
sconfiggeranno i nuovi barbari
per un domani di pace fra le genti.
|
|
|
A battaglia finita
 Matteo Bosinelli
Matteo Bosinelli
“Sono preoccupata per te mi
disse allora Rhona,
che io so, non sbaglia,
ma spesso perdona Il
tempo non attende,
e sempre passa:
non devi sbagliare,
dunque, ora, la mossa”.
È passato tanto tempo, ormai,
da quando ti dissi:
“Amami e vivrai”,
sei fuggita subito molto lontano,
pur prendendomi timidamente per mano.
“Vada avanti con il suo dolore,
la seguo io –
mi disse allora il Dottore –
vada avanti e non disperi:
l’accompagno io,
in questi viottoli stantii e neri”.
È un passo nuovo,
su un altro selciato,
in cui devo muovermi,
e sono turbato.
Non ci son Leggi,
a cui sia preparato,
non ci son schemi,
in cui muovermi agiato.
|
|
|
Uno scherzo!
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti
Quagliarella, Quagliarella,
sei una stella!
sei una stella del calcio moderno
sei più vecchio del padreterno.
Forse non è un caso
sei convocato in Nazionale
per le feste di carnevale.
Quasi ogni tiro una rete:
quali sono le tue mete?
Con te il pallone gira tondo
tra un po’ giocherai nel “Resto del Mondo”.
|
|
|
Nuda
 Marcella Colaci
Marcella Colaci
Eccomi nuda,
di una nudità disarmante
senza arte né parte
vuota apparente
impervia storia
di me sola
ma il giorno è generoso
arrivi tu
e la mia nudità
si veste di gioia
la mia nudità ha il calore
il fuoco, nell'abbraccio
Nascondo il seno che ami
che mordi, che scaldi
e sono tua
come non mai
come sempre
come un passerotto al nido
come un pesce nello scoglio
come una donna
che fa di se stessa
il dono all'amore
creando pace e passione
nuda.
|
|
|
Crescente
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti
La tua pura voce
è come una calma foce
che mi irrora tutto.
È un fluido strutto
che assieme alla farina
con cui ti incipriavi da bambina
mi fa pensare alla crescentina, al pane
al pane e salame,
un qualcosa di assai fragrante
da mangiare golosamente.
Ma che amante!
Amo troppo la pasta fumante!
Ma perché così di frequente
mi pensi un serpente?
|
|
|
La cacciata dell’ambulante
 Marcella Colaci
Marcella Colaci
Vattene
vai fuori dai coglioni
non c'è terra per te, per voi
che mendicate.
Andate via
vai via ambulante straniero
vai a fare il viaggio di ritorno
e non farti vedere in giro
non farti pizzicare incredulo
sappi che siamo duri
siamo forti, siamo noi
quelli che governano il mondo.
La vita non ti appartiene
la tua vita è nostra
la strada che ti aspetta è breve
senza futuro
con pochi stracci
da finire in mare
da finire in terra straniera
da finire in ogni caso.
Io non sono nessuno
non posso nemmeno
implorarvi a lasciarmi andare
i miei occhi sono pietosi
e voi che adorate Michelangelo
sappiate guardarmi
come i suoi occhi guardavano Cristo in croce.
Io sono colui che sapete beffeggiare
sapete pugnalare con vigliaccheria
io non sono nessuno
sono solo un uomo.
|
|
|
Schizofrenia
 Matteo Bosinelli
Matteo Bosinelli
Quel ragazzo aveva l’animo ferito,
da grave malattia colpito.
Nuotava nella vita non sereno,
mentre il mare era pieno
e lo costringeva alla deriva...
Forse forse, così, da solo, moriva.
|
|
|
La vergogna e l’amore
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti
Anche la vergogna
A volte la si sogna
A volte è qualcosa di reale
Che fa veramente male
Però certamente puoi amarti
Non devi vergognarti
E lei col pensiero si ama
Non farti turbare, è la tua brama!
Non dispiacerti mai d’osare
Per la tua amata devi lottare
Lotta magari con un cuscino
Come facevi da ragazzino
Questa casa è come un bosco
È proprio qui che la conosco
È una ventenne Cappuccetto Rosso
E io la voglio a più non posso
Questo uomo travagliato
Da lei è sinceramente turbato
Ma si deve preservare l’amata
Che sia proprio illibata
È un.. sessuale travolgente
Che vive tutto nella tua mente
Oh stelle, fate che nel suo cuore
Viva per sempre un grande amore!
|
|
|
Vergogna e vita
 Piergiorgio Fanti
Piergiorgio Fanti
La vergogna tocca tutti:
Si nasce nella vergogna
Peggio, si muore!
Ma non vergognarti di lottare
Se la ragione te ne danno
Sbatti in galera il truffaldino
Picchia duro con la legge
Che il colpevole sia preso!
(Cedere vuol dire perdere
Non cedere vuol dire esistere)
Ma di piegarti
Per una vita cambiare
Non te ne pentire mai!
|
|
|
Cara mamma…
 La Poetessa della Riva Sinistra
La Poetessa della Riva Sinistra
Cara mamma, non so se ti ho mai scritto
una lettera, forse non ne ho avuto il tempo,
o forse ero giovane, troppo giovane
quando ti ho persa.
Ricordo i tuoi ultimi giorni... eri triste
in cucina, mentre stiravi... pensosa
come se nulla dovesse accadere...
Dentro di te portavi un destino che,
per troppo amore, ci nascondevi.
Il tuo segreto era la forza che ci proteggeva.
Cara mamma, ho sempre sperato di essere una ragazzina
migliore di quella che hai conosciuto.
Ti ho dato dei dispiaceri.
Ti ho fatto anche piangere, purtroppo:
mi hai amata lo stesso.
Volevo diventare una donna
forte come te.
Ma non è andata così. Non sono né moglie, né madre.
Non mi sono neanche laureata.
Cara mamma, ogni sera, prima di dormire
penso a te e a papà, che, felice, ti è accanto:
vi ringrazio perché mi avete sempre protetto e donato
quella luce che nei giorni di buio,
da sola, non avrei mai trovato.
Sarebbe stato bello abbracciarti
quando avevo paura, stringerti a me
quando ti sentivi triste.
Anche ora,
cosa darei per telefonarti
chiederti un consiglio...
Sapere che ci sei, lì ad aspettarmi.
Cara mamma, perdonami perché il tempo
pian piano ha cancellato nella mia mente
la tua voce e il tuo volto, cerco di ricordarli,
ma non è possibile...
Facciamo in modo di incontrarci
nei miei sogni...
Saremo in un mondo
solo NOSTRO...
|
|
|
IL FILO ROSSO
 Stefania Galassi
Stefania Galassi
F
 requentavo
la terza elementare ed ero alta un metro e sessanta centimetri. La mia
statura era fonte di grande imbarazzo. A scuola mi sentivo come
Gulliver approdato nell’isola dei Lillipuziani. Piccoli esseri crudeli
che mi riservavano torture e umiliazioni. In particolare il ‘boss’
della classe, Matteo, mi aveva preso di mira. Mi chiamava ‘scimpanzé’
per via della camminata goffa e impacciata. Mi lanciava palline di
carta nei capelli, durante le ore di lezione e aeroplanini con
parolacce e insulti. Nella sua mente di ottenne, come per tutti i
maschi, io con la mia terza di seno e le mie curve pericolose
assomigliavo a una Jessica Rabbit, lasciva e vogliosa. requentavo
la terza elementare ed ero alta un metro e sessanta centimetri. La mia
statura era fonte di grande imbarazzo. A scuola mi sentivo come
Gulliver approdato nell’isola dei Lillipuziani. Piccoli esseri crudeli
che mi riservavano torture e umiliazioni. In particolare il ‘boss’
della classe, Matteo, mi aveva preso di mira. Mi chiamava ‘scimpanzé’
per via della camminata goffa e impacciata. Mi lanciava palline di
carta nei capelli, durante le ore di lezione e aeroplanini con
parolacce e insulti. Nella sua mente di ottenne, come per tutti i
maschi, io con la mia terza di seno e le mie curve pericolose
assomigliavo a una Jessica Rabbit, lasciva e vogliosa.
Per limitare l’esposizione del mio corpo a occhi indiscreti, mi vestivo
con abiti larghi, trascorrevo anche tutta la ricreazione in classe,
evitavo le ore di educazione fisica perché la divisa da palestra,
pantaloncini aderenti e maglietta attillata, mettevano in risalto le
forme che volevo nascondere. Se fuori avevo il corpo di una tredicenne,
dentro ero una bambina spaventata. Avrei voluto avere una mamma che mi
rassicurasse. Avrei voluto una madre comprensiva e amorevole. Mia
madre, al contrario, era una donna autoritaria che mio padre chiamava
‘generale’.
Per lei, donna emancipata e moderna, non c’era problema che non avesse
una soluzione semplice e razionale. Credeva nella scienza anche se, da
buona sessantottina femminista, era legata al concetto di madre natura.
“Lascia fare alla natura”, diceva sempre. “Tesoro non preoccuparti. Sei
solo un po’ più alta delle tue compagne. Che c’è di male? L’importante
è la salute. E tu sei sana e forte”.
Ma la natura aveva un piano tutto speciale per me che avevo da poco
compiuto gli otto anni. Erano giorni che soffrivo di strani mal di
testa. Ero nervosa e irritabile. In uno slancio di ottimismo decisi di
fare ginnastica con i miei compagni, indossando però una tuta lunga e
larga. Tutto filò liscio fino al termine della lezione. Nello
spogliatoio scelsi la doccia singola mentre le mie compagne si lavavano
nelle docce comuni. Erano ninfe piccole e aggraziate. Io avevo
l’aspetto di una tredicenne ipersviluppata e come tale dovevo
rintanarmi. Fare la doccia mi piaceva. Il mio corpo ingombrante pareva
sciogliersi sotto il getto dell’acqua calda, nascondersi tra le bolle
del bagnoschiuma al profumo di mandorle dolci. Le tensioni cedevano
alle nuvole di vapore. Mentre mi insaponavo una gamba, notai l’acqua
limpida tingersi di rosso. Controllai di non avere una ferita nella
coscia ma niente. Riaprii il rubinetto e ancora l’acqua si tinse di
rosso. Un rivolo di sangue usciva dalla ‘farfallina’, così chiamavo il
mio organo sessuale. Mi spaventai. Forse era un’emorragia. Mi stavo
dissanguando! Sentivo le forze venir meno. Le gambe deboli. Il fiato
corto. La cabina della doccia fu attraversata da un lampo bianco. Un
pulviscolo bianco candido scese dal soffitto come quando fuori la neve,
cadendo, copre le cose e attutisce i suoni. Le parole lievi come un
brusio lontano: “Maestra…”, “Maestra…”.
“S. mi senti? Coraggio, apri gli occhi... Ah, eccoti qua... Come
stai?”. “Cos’è successo?”, domandai con un filo di voce alla maestra.
“Sei svenuta nella doccia. Niente di grave”. Ero sdraiata sul
pavimento, vicino alla guardiola della bidella, su un materassino.
Avevo addosso il mio accappatoio bianco con una macchia rossa
all’altezza della coscia. Un capannello di bambini. Mi circondavano
fissandomi curiosi. “Maestra cos’è quel sangue?”, chiese una delle
bambine. “Non è niente - disse Maria Rosa - una piccola ferita alla
gamba. Guarirà presto”.
La porta d’ingresso s’aprì e, insieme a una folata di aria fredda, fece
irruzione mia madre, evidentemente avvisata del mio malore. Ci
raggiunse con passo deciso. “Fate largo, bambini! - disse - Fatela
respirare”… “Va tutto bene, tesoro”, sussurrò.
Ora che avevo ripreso i sensi, avvertivo un fastidio in mezzo alle
gambe. Qualcosa di duro oscillava avanti e indietro. Era come stare su
una barca con le onde che si infrangono sullo scafo. “Gliel’ha messo
l’assorbente?”, chiese mia madre rivolta alla maestra. “ Ne avevamo uno
nell’armadietto dei medicinali, in guardiola”… “Assorbente?”, chiese la
bambina di prima. “Sì piccola, per tamponare il sangue mestruale”,
rispose mia madre. La maestra la guardò di traverso ma non disse
niente.
“Cos’è ‘mestruale’?”, chiese ancora la lillipuziana. La domanda cadde
nel vuoto. Ma i bambini sono curiosi e quando sentono una parola nuova
la ripetono all’infinito come se, nominandola, ne carpissero il
significato recondito. La mamma mi condusse in guardiola,
momentaneamente vuota, dove mi vestii. La maestra si offrì di
accompagnarci alla macchina. “Ce la fa da sola -disse mia madre in tono
sgarbato- non è mica malata”.
Nel breve tragitto tra la guardiola e l’uscita, passai davanti ai miei
compagni che mi osservavano confabulando. Ripetevano sempre la stessa
parola: “Mestruazioni”. Camminai col capo chino. Rossa di sangue e di
vergogna. Avevo le mestruazioni, così aveva detto la mamma, ma non
avevo la minima idea di cosa fossero. Mia madre mi aveva tenuta
all’oscuro di tutto. Per quanto fossi alta e prosperosa, per lei ero
ancora la sua bambina che giocava con le barbie e, la sera, andava a
letto coi peluche.
 Ora, però, non poteva più far finta di nulla. Quel giorno decise che
era giunto il momento di mettermi al corrente dei segreti della natura,
dei misteri del sesso e della procreazione. Ci sedemmo sul divano in
camera mia. “Sei diventata signorina - mi comunicò sollecita - non c’è
nulla di cui vergognarsi, è naturale. Anche le tue compagne si
svilupperanno: è solo una questione di tempo. Appena compaiono le
mestruazioni, la donna è in grado di dare la vita. Le donne sanguinano
una volta al mese, se non sono incinte. Se invece la donna aspetta un
figlio, il ciclo si blocca finché non partorisce”.
Ora, però, non poteva più far finta di nulla. Quel giorno decise che
era giunto il momento di mettermi al corrente dei segreti della natura,
dei misteri del sesso e della procreazione. Ci sedemmo sul divano in
camera mia. “Sei diventata signorina - mi comunicò sollecita - non c’è
nulla di cui vergognarsi, è naturale. Anche le tue compagne si
svilupperanno: è solo una questione di tempo. Appena compaiono le
mestruazioni, la donna è in grado di dare la vita. Le donne sanguinano
una volta al mese, se non sono incinte. Se invece la donna aspetta un
figlio, il ciclo si blocca finché non partorisce”.
Mi spiegò senza tanti preamboli come nascono i bambini. Poco mancò che
le vomitassi addosso. Non era naturale, era sporco. Avevo perso
l’innocenza, anche se non avevo fatto nulla di male. “Io non le voglio!
-
dissi con gli occhi strabuzzati - io non le voglio le mestruazioni!”…
Ripetevo in maniera ossessivo compulsiva: “Voglio morire! Voglio
morire! Ho anche mal di pancia”…
“La soluzione - sentenziò mia madre senza farsi per nulla turbare da
quella scenata - è una bella puntura di antiinfiammatorio sulla
pancia”. Mi bastò sentire la parola siringa per smettere di urlare e
piangere. La mamma mi diede una compressa di tachipirina e mi spedì a
letto con la borsa dell’acqua calda. “Vedrai che ti sentirai subito
meglio”, mi assicurò. Sentivo il sangue fluire tra le gambe. Umido e
appiccicaticcio. Piangevo con la testa affondata sul cuscino. Che
peccato avevo commesso per meritarmi un castigo simile? Il sangue con
quell’odore nauseabondo di violetta appassita e di formaggio rancido.
Mamma aveva detto che il sangue serviva a fare i bambini. Ma io non li
volevo, i bambini. Mi aveva detto che anche le mie compagne si
sarebbero sviluppate. Ma loro erano piccole e carine. Indossavano
vestitini con nastrini e paillettes, sandali colorati e portavano le
treccine. Io ero alta e sgraziata. Per colpa di mia madre, ora i miei
compagni sapevano delle mie mestruazioni. Avrebbero interrogato i
genitori per sapere cosa fossero. Io sarei diventata lo zimbello di
Matteo e dei suoi compari. Odiavo la scuola e me stessa.
Volevo solo dormire e non svegliarmi più. L’indomani mattina , quando
mia madre venne a svegliarmi, le dissi di abbassare le tapparelle e di
lasciarmi in pace. Non sarei andata a scuola per nessuna ragione al
mondo. “Poche storie! - gridò lei - Ora ti alzi, ti prepari e ci
vai!”…“No che non ci vado! - piagnucolai io - Non mi puoi costringere”.
“Eccome se posso - mi rispose alterata - Non voglio finire in galera
per colpa di una figlia sciagurata. Andare a scuola è obbligatorio fino
a una certa età, cara la mia signorina, e tu ci vai. Eccome se ci
vai!”.
La maestra mi diede il benvenuto. Mi chiese come stavo. Risposi:
"Bene”, anche se ero profondamente scossa. “Ci hai fatto preoccupare,
vero ragazzi?”. Le bambine annuirono. Da brave crocerossine dissero che
appena mi avevano sentito chiamare: “Maestra”, avevano capito che
qualcosa non andava e si erano precipitate a informare Maria Rosa.
“L’importante è che tu sia qui con noi”, disse l’insegnante.
Aveva modificato l’ordine dei banchi. Li aveva disposti su due file,
l’una di fronte all’altra a formare un unico tavolo. Il mio sesto senso
mi suggeriva che lo avesse fatto per tenere d’occhio gli alunni più
scalmanati. Forse si era accorta delle ‘angherie’ nei miei confronti e
voleva proteggermi. Ero seduta accanto a lei. Matteo lo aveva sistemato
nell’ultimo banco della fila di destra, lungo la sua traiettoria
visiva, per poterlo facilmente controllare. Tirammo fuori i quadernoni
di italiano per il dettato di ortografia. Mettemmo sotto il banco ogni
cosa escluso l’astuccio. C’era silenzio, a parte lo scricchiolio dei
temperini e il clin clan dei righelli appoggiati sul banco. Faticavo a
concentrarmi. Il pensiero era impegnato a capire cosa stava succedendo
là sotto. Avrei voluto andare in bagno a controllare l’assorbente, ma
il dettato non ammetteva interruzioni. Matteo era stranamente calmo.
Con la testa china e il braccio a 90 gradi nascondeva il quadernone.
Senza mai alzare gli occhi, la sua mano scorreva veloce. Molto più
veloce delle parole pronunciate dalla maestra.
La campanella suonò ad annunciare l’inizio della ricreazione. Maria
Rosa ritirò i quadernoni e li chiuse a chiave nel cassetto della
scrivania. Avremmo ripreso il dettato nell’ora successiva. I compagni
si sparpagliarono nel corridoio. Alcuni andarono al bar a consumare
merendine e panini, altri andarono nelle altre classi a cercare amici
con cui scambiare le figurine. Le bambine si riunirono in gruppetti a
parlare male di questo e quello. Io mi trovavo ancora in aula quando
entrò Matteo accompagnato da tre compari. Mi circondarono e presero a
sbeffeggiarmi. “Dove credi di andare?”… “Era meglio se te ne stavi a
casa”… “A te ci pensiamo noi”… “Guarda un po’ qua”. Mi lanciarono il
diario di Matteo. Nella pagina segnata da un’orecchia era raffigurata
una ragazza nuda che mi somigliava. Aveva due seni enormi e una pozza
di sangue, a terra, tra le gambe. “La spilungona piscia sangue - disse
Matteo - Che schifo!”… “Oh povera piccola!”, disse uno. “Perché non lo
vai a raccontare alla maestra che ti prendiamo in giro?! - disse
l’altro -
Gne, gne, gne!”.
Sconvolta, riuscii a rifilare un calcio nello stinco a uno dei tre, che
sbandò, creandomi un varco nel cerchio spezzato. Corsi a chiudermi a
chiave nel bagno. Non mi avrebbero mai lasciata in pace. Aprii la
finestra: un piccolo vano senza sbarre. Calcolai la distanza tra me e
il cortile: tre piani esatti. Se mi fossi buttata, probabilmente sarei
morta e avrei smesso di soffrire. E se non fosse andata così? Se mi
fossi ridotta su una sedia a rotelle? O intubata in un letto di
ospedale? La mia vigliaccheria non poteva accettare simili eventualità.
Richiusi la finestra. Dovevo trovare il coraggio di tornare in classe.
Controllai l’assorbente, che non mi creasse ulteriori disagi. Le
mutande elastiche di mamma lo avevano mantenuto nella posizione
corretta. Il flusso era scarso perciò decisi di non cambiarlo.
La ricreazione era finita da alcuni minuti. Maria Rosa stava
distribuendo i quadernoni per il dettato. I compagni erano seduti
composti, persino Matteo, dopo essersi sfogato su di me, sembrava aver
ritrovato il contegno. “Bene ci siamo tutti - disse la maestra, appena
raggiunsi il mio posto a sedere – Allora, bambini, ascoltatemi! Mettete
nell’astuccio matite, gomme, temperini: tutto quello che non serve.
Prestate attenzione alla pronuncia delle parole. Vi concederò qualche
minuto per pensare. Guardate sempre e solo il vostro quadernone. Non
copiate altrimenti sarò costretta a dividere i banchi. Il voto del
dettato sarà scritto sul registro. Siete pronti?”. La classe annuì.
“Cominciamo!”.
|
|
|
LA VERGOGNA DI ESSERE SCOPERTI
 Francesco Valgimigli
Francesco Valgimigli

 uando
devo leggere una mia poesia davanti a delle persone provo una gran
vergogna, mi sento esposto a tutte le critiche che si possono fare, ho
paura, insomma, di essere scoperto nei segreti più intimi. È come se in
quel momento qualcuno mi facesse una radiografia. Come se non riuscissi
più a trovare posti dove potermi nascondere e mi trovassi senza
protezione. La poesia infatti, secondo me, rivela i segreti dell’anima
di chi l’ha scritta e tra il poeta e il suo pubblico c’è solo un
alberello striminzito dietro il quale potersi rifugiare. Nel racconto
invece hai un intero bosco nel quale sparire, e quando leggo un mio
racconto so che mentre lo sto leggendo posso truccare un po’ le carte,
intuisco un margine di sicurezza, una zona buia che rimane oscura in
cui potersi mimetizzare. Quando leggo una mia poesia, oltre questo
senso di vergogna, c’è comunque il piacere di leggere qualcosa che si è
pensato e si è scritto e di avere, a lettura finita, la soddisfazione
di ricevere complimenti da chi ti ha ascoltato. È quindi una sofferenza
e una gioia insieme quello che provo mentre leggo una poesia e le due
emozioni si combattono dentro di me come due pupi siciliani e nessuno
dei due vince, nessun colpo di spada ferisce a morte l’altro, e la
rappresentazione nel mio cervello non sembra finire mai. Sento ancora
il cozzare delle spade mentre leggo gli ultimi versi; poi per fortuna
cala il silenzio, il sipario si chiude e io posso tornare a nascondermi
dentro di me. uando
devo leggere una mia poesia davanti a delle persone provo una gran
vergogna, mi sento esposto a tutte le critiche che si possono fare, ho
paura, insomma, di essere scoperto nei segreti più intimi. È come se in
quel momento qualcuno mi facesse una radiografia. Come se non riuscissi
più a trovare posti dove potermi nascondere e mi trovassi senza
protezione. La poesia infatti, secondo me, rivela i segreti dell’anima
di chi l’ha scritta e tra il poeta e il suo pubblico c’è solo un
alberello striminzito dietro il quale potersi rifugiare. Nel racconto
invece hai un intero bosco nel quale sparire, e quando leggo un mio
racconto so che mentre lo sto leggendo posso truccare un po’ le carte,
intuisco un margine di sicurezza, una zona buia che rimane oscura in
cui potersi mimetizzare. Quando leggo una mia poesia, oltre questo
senso di vergogna, c’è comunque il piacere di leggere qualcosa che si è
pensato e si è scritto e di avere, a lettura finita, la soddisfazione
di ricevere complimenti da chi ti ha ascoltato. È quindi una sofferenza
e una gioia insieme quello che provo mentre leggo una poesia e le due
emozioni si combattono dentro di me come due pupi siciliani e nessuno
dei due vince, nessun colpo di spada ferisce a morte l’altro, e la
rappresentazione nel mio cervello non sembra finire mai. Sento ancora
il cozzare delle spade mentre leggo gli ultimi versi; poi per fortuna
cala il silenzio, il sipario si chiude e io posso tornare a nascondermi
dentro di me.
|
|
|
QUANDO MI VERGOGNO E QUANDO NO
 Luca G.
Luca G.
La vergogna è quel sentimento che provi
quando dici o fai una cosa di cui poi ti penti amaramente e desideri
non averla mai fatta o detta, oppure quando gli altri ti fanno pentire:
insulti, critiche, punizioni, reazioni violente, tutto questo ti fa
provare la vergogna. Personalmente, posso dire che ci sono cose di cui
mi vergogno, e altre di cui non mi vergogno.
Io sono l’equivoco formato persona, nel senso che molte delle cose che
faccio o dico non sono quello che sembrano. Per esempio, al lavoro mi
hanno sorpreso a chiudere la porta del mio ufficio con una strana
espressione sul volto: strizzavo gli occhi e tenevo la bocca serrata,
mostrando i denti, come se mi fossi strappato un muscolo. Invece, come
ho spiegato alle colleghe che mi hanno visto, stavo pensando in quel
momento a qualcuno che si procurava una ferita e quindi strizzava gli
occhi e stringeva i denti: era solo una coincidenza, niente di più.
Inoltre quando sbadiglio lo faccio spesso a denti stretti, apposta per
non spalancare la bocca per non fare la figura del maleducato e per
evitare di mettermi la mano davanti al volto, per pigrizia. So che è
una cosa molto strana, quasi assurda, ma quando sbadiglio così non me
ne vergogno. Semmai mi sono vergognato quando una signora mi ha visto
sbadigliare aprendo la bocca senza la mano davanti. Non tanto per il
gesto, ma perché quella donna mi ha sgridato. Infatti mi chiedevo: “Ma
non poteva farsi i fatti propri, quella donna?”. Non per maleducazione,
beninteso, ma perché sono convinto che se fossi stato io a vedere
un’altra persona sbadigliare così e a correggerla, quell’altra persona
mi avrebbe rinfacciato di non farmi i fatti miei.
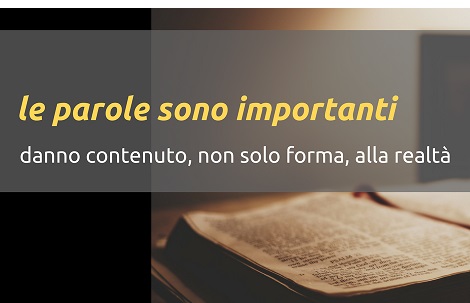 Devo sempre spiegare agli altri che con me le cose non sono mai come
sembrano. E spiegarlo pure con le parole giuste, perché “le parole sono
importanti”, come diceva Nanni Moretti. Bisogna scegliere bene gli
argomenti e le parole da usare a seconda del momento e
dell’interlocutore. Perché se usi parole troppo sofisticate per chi non
capisce certe cose, o ne usi di volgari con persone che sono molto
educate, rischi di fare una brutta figura e di provare vergogna per
questo. Fortunatamente io ho quasi sempre a che fare con delle persone
che tollerano un linguaggio semplice e con le quali, oltre ad avere una
certa confidenza, non devo usare parole troppo complicate, anzi in
moltissime occasioni devo fare il contrario. Non mi hanno mai detto:
“Parla come mangi!”, però me l’hanno fatto capire, sia a casa che a
scuola.
Devo sempre spiegare agli altri che con me le cose non sono mai come
sembrano. E spiegarlo pure con le parole giuste, perché “le parole sono
importanti”, come diceva Nanni Moretti. Bisogna scegliere bene gli
argomenti e le parole da usare a seconda del momento e
dell’interlocutore. Perché se usi parole troppo sofisticate per chi non
capisce certe cose, o ne usi di volgari con persone che sono molto
educate, rischi di fare una brutta figura e di provare vergogna per
questo. Fortunatamente io ho quasi sempre a che fare con delle persone
che tollerano un linguaggio semplice e con le quali, oltre ad avere una
certa confidenza, non devo usare parole troppo complicate, anzi in
moltissime occasioni devo fare il contrario. Non mi hanno mai detto:
“Parla come mangi!”, però me l’hanno fatto capire, sia a casa che a
scuola.
Mi è successo di dire ai genitori o agli insegnanti parole o concetti
difficili da capire o diversi da quelli che mi hanno insegnato, e
qualche volta mi è successo di sentirmi rispondere che devo parlare
come gli altri, o non prendere iniziative. E in quelle occasioni ho
provato vergogna. Per esempio quando ho citato in un compito in classe
d’inglese l’anticiclone delle Azzorre, che la prof non aveva mai
menzionato. Oppure quando i compagni di classe facevano i buffoni
scrivendo o disegnando cose schifose sulla lavagna senza ritegno. Ho
visto uno di loro fare una caricatura di una professoressa disegnandola
come l’omino dei marshmallows del film Ghostbusters: mi sono vergognato per lui, anche se la prof non ha visto niente.
Mi è capitato che i genitori mi facessero provare vergogna quando
parlavo troppo forte o con tono troppo arrabbiato. E tutto perché avevo
trasformato in motto della mia vita il proverbio latino Rem tene, verba sequentur,
che in sintesi vuol dire: “Tieni a mente il concetto, le parole
verranno da sé”. Perciò ho badato sempre a ‘cosa’ dire, e non troppo a
‘come’ lo dico. Per fortuna riesco quasi sempre a badare alle parole
che uso e al volume della voce, solo che non gli do tutta questa
priorità. Quelle poche volte che non ci riesco mi vergogno: in casa
bastava anche solo superare il limite di un centimetro, magari con un
urlo di disappunto o una parolaccia da parte mia, anche solo una volta
all’anno, che il babbo si arrabbiava e mi sgridava e mi faceva pentire
di quest’infrazione. Quando c’era lui non potevo ‘sbroccare’ o
irritarmi, ma lui sì. Non so perché si arrogasse il diritto di farlo,
di sicuro non me l’ha mai spiegato né mi ci ha fatto ragionare sopra, e
di questo mi vergogno. Era il capofamiglia, era più vecchio della mamma
e ovviamente anche di me, ma non sempre questo gli dava il diritto di
sbagliare, o di dimostrare che lui la sapeva più lunga di me. E questo
mi ha portato a desiderare che fossero tutti uguali, e trovare un
metodo per parlare con gli altri che potesse andare bene per chiunque.
E qua mi ritrovo sul concetto “Parla come mangi!”, che sembra cozzare
con “le parole sono importanti”, ma non è così. Anzi, è importante
usare un linguaggio semplice con chi parla come mangia, come lo è usare
un modo di parlare educato o complesso con chi è abituato
all’educazione e a livelli di linguaggio più alti. È tutta una
questione di comunicazione.
Una cosa di cui non mi vergogno affatto e che qualche volta dico, è che
quando si ha a che fare con una persona poco gradita l’ideale non
sarebbe farla morire, ma farla sparire! Detto così, è facile che chi me
lo sente dire pensi che io quella persona voglia farla a pezzi,
disintegrarla, farne sparire il corpo dopo averla fatta fuori. No,
niente affatto. Per far sparire una persona ci sono metodi molto più
civili, anche se più complicati. Un tempo, per punire qualcuno di un
crimine che aveva commesso, o per toglierlo di mezzo perché scomodo, lo
si mandava in esilio, lontano da tutto e da tutti. Oppure, come al
giorno d’oggi, lo si rinchiudeva in prigione, escludendolo dal resto
della comunità, ai cui occhi il personaggio in questione ‘spariva’.
Questo discorso vale anche dal punto di vista personale: se un ragazzo
che conosci smette di frequentare la tua stessa scuola o cambia
quartiere o città, è come se sparisse dalla tua vita. Oppure, visto che
non si può esiliare o mettere in galera qualcuno solo perché dà
fastidio, puoi smettere di andare nelle vie e di frequentare gli stessi
posti dove va lui. Almeno questo è quello che ho imparato a fare io.
Non occorre arrivare a uccidere, perché altrimenti si finisce dalla
parte del torto. E peggio ancora, si potrebbe avere il tormento del
ricordo della persona uccisa per il resto della vita. Roba da Delitto e castigo di Dostoevskij.
Come dicevo, ci sono cose della vita di tutti i giorni che mi vergogno
di fare, o di non riuscire a fare, e altre che non mi vergogno di fare.
Per esempio non mi vergogno di riflettere ad alta voce (ossia parlando,
anche avendo cura di non farmi sentire dagli altri, oppure senza fare
attenzione a questo), e non mi vergogno nemmeno di borbottare
esclamazioni colorite. Non perché siano volgari, anche se qualche volta
sussurro a me stesso insulti e parolacce che mi entrano in testa (a
causa della mia bassa autostima), ma perché sono originali. Non capita
spesso di sentire qualcuno esclamare: “Per mille afgani!” o “Per
Gabbiadini!”… Le mie esclamazioni sono ispirate dalla prima persona,
cosa o parola che mi viene in mente o che secondo me ha un bel suono, e
quindi mi ritrovo a dirle sottovoce.  Non me ne vergogno, anzi sotto questo aspetto mi sento un po’ come Deadpool, il mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel.
Non me ne vergogno, anzi sotto questo aspetto mi sento un po’ come Deadpool, il mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel.
Semmai mi vergogno di non avere mai imparato a spiegare la strada ai
passanti. Ogni volta che qualcuno mi chiede un’informazione, o arriva
qualcun altro che risponde prima di me, o non so cosa rispondere,
perché certe vie e zone della città non le conosco, oppure impiego un
sacco di tempo a formulare e dire la mia spiegazione. Allora per far
prima preferisco di gran lunga dire “non lo so” o “non sono di queste
parti”, a meno che io non conosca veramente bene quello che mi viene
chiesto. Se conosco il posto o la via, allora mi offro di accompagnare
chi mi ha chiesto l’informazione, oppure se è di poche o immediate
parole, gliela espongo senza problemi.
Mi vergogno anche di aver fatto insieme ad altri cose che mi piacevano,
ma che lasciavano sconvolti loro. A undici anni io e i miei genitori
eravamo a L’Italia in miniatura
ed entrammo in un gigantesco simulatore che ci mostrò il filmato di una
gara di rally, facendoci sballottare e sobbalzare sui sedili come se
fossimo stati dentro l’auto. Io mi divertii, i miei genitori rimasero
invece scombussolati e sconvolti. E allora mi sono vergognato di averli
fatti stare così. Ancora prima di allora, quand’ero molto piccolo, mi
incollavo davanti alla tv quando c’era la pubblicità, ignorando tutto
il resto. E a due anni ho preso una sbarra e ho graffiato l’auto nuova
di zecca di un parente. Non provavo vergogna allora, l’ho provata molto
fortemente quando il babbo mi ha raccontato questi due aneddoti con
tono allegro, quasi si volesse prendere gioco di me. Mi vergogno anche
quando vengo sgridato dai conducenti d’autobus. Qualche esempio: per
una volta che non alzavo il braccio per segnalare all’autobus che
doveva fermarsi, successe che l’autista fermò il mezzo, ma poi mi
sgridò. “Alzare la mano no, eh?”… “Di solito lo faccio…”, iniziai a
dirgli con tono cortese. “Di solito lo fa!”, mi rimbeccò lui, come a
dirmi che devo farlo sempre e lasciandomi senza più parole per
giustificarmi. Un’altra volta, per salire sull’autobus, mi ritrovai a
tagliare senza volerlo la strada a una ciclista. Se l’avessi lasciata
passare, avrei perso il bus. E l’autista mi sgridò. “Hai osato tagliare
la strada a quella bicicletta!”… “No...”… “Sì, non no!”… “Mi scusi, non
l’ho fatto apposta!”. Lui non mi rispose più, forse non mi ascoltava
neanche più, però come disse mia madre quando glielo raccontai avrebbe
dovuto pensare solo a fare il suo lavoro. “E chi è, un vigile urbano?”,
fu il suo commento. Un altro episodio che posso raccontare è questo:
una mattina mi stava passando davanti un autobus che dovevo prendere.
L’autista si era fermato, ma aveva aperto solo la porta anteriore, per
permettere a un uomo alla fermata di salire, ma tenendo chiusa quella
posteriore. Prima mi ero messo davanti a quest’ultima, ma subito dopo,
avendo intuito che lui non me l’avrebbe aperta, mi ero messo a correre
verso l’altra. Proprio quando l’avevo raggiunta il conducente la stava
chiudendo, e allora avevo dovuto mettere le mani dentro la porta e fare
il gesto di aprirla a mano. Ammetto che avrei rischiato di rimanere
incastrato, ma non mi importava e non me ne vergognavo. Ero solo
sbalordito perché l’autista non aveva fatto il suo dovere di aprire
tutte le porte del mezzo pubblico. L’autista alla fine mi aprì, ma una
volta salito a bordo ignorando il mio “grazie” cominciò a farmi una
serie di urla che non finivano più: “Che fai? Fermi l’autobus?”. Non
era la prima volta che un autista mi criticava, ma tentai di spiegarmi:
“Stavo correndo... Stavo raggiungendo...”. L’implacabile autista, forse
senza ascoltarmi, mi interruppe e continuò a urlare dicendo cosa
sarebbe potuto succedere: “Io parto, tu cadi con la testa sotto la
ruota e ti ammazzi!”… “Stavo correndo… Stavo raggiungendo…”, tentavo di
dirgli, ma oltre queste parole non
riuscivo ad andare, visto che l’autista continuava a interrompermi
tutto arrabbiato. Lì per lì ci rimasi male, con i passeggeri che mi
guardavano indifferenti o sconvolti, però cercai di ragionare e
giustificare anche l’autista. Quelle frasi le aveva dette male, ma
aveva buone intenzioni, si era preoccupato per me, anche spaventato.
Però trovo assurdo che mi stesse chiudendo la porta in faccia, proprio
mentre stavo per salire. L’autista aveva fermato il bus, aveva fatto
salire un passeggero aprendo una porta sola, non aveva neanche pensato
di aprire quella posteriore, e poi quasi mi chiudeva in faccia l’unica
che aveva aperto. Alla fine ho ottenuto quel che volevo, salire a
bordo, per di più con delle maniere non buone, e non me ne vergogno
nemmeno adesso, però ho provato vergogna nell’osservare le facce
indifferenti o sbalordite degli altri passeggeri. E penso che se fossi
stato nei panni di quel conducente di autobus, avrei dovuto provare
vergogna anche nel suo caso.
Non provo invece vergogna nel dire e pensare che alle volte sono
invisibile.
Poche ore dopo l’episodio dell’autista che non aveva aperto tutte le
porte, una collega di lavoro non mi notò se non dopo essersi girata e
mi chiese scusa per non avermi salutato. “Non importa, tanto sono
invisibile”, le dissi. “No, non sei invisibile”, rispose lei. “Sì,
invece”, ribattei. “Sono invisibile nel senso che faccio cose
invisibili!”. La collega di nuovo negò, ma io sono sicuro che è come
dico io: non sono trasparente né posso diventarlo, ma se io faccio
qualcosa e nessuno mi nota, è come se non mi vedesse quindi, non
essendo visto, sono invisibile. Se faccio un gesto o mangio una
merendina e nessuno mi vede, sono invisibile. Diventerei visibile solo
se qualcuno mi buttasse l’occhio addosso e smettesse di ignorarmi.
Allora sì che sarei visibile, perché sarei visto. E certe volte non mi
vergogno proprio di essere invisibile. Semmai fa male essere ignorati,
ma non è proprio la stessa cosa.
 Non mi vergogno nemmeno di pensare qualche volta: “Homer è un cane”.
Non l’ho mai detto a nessuno, perché non ho mai avuto ragioni per
farlo, però mi rendo conto che una frase detta così lascia un po’
spiazzati, e per i fan dei Simpson può sembrare un insulto bello e
buono. Ma pensateci bene: Homer, come i cani, ha una grandissima
passione per il cibo, anzi sbava e prova libidine davanti alla carne di
maiale, alle ciambelle e a tutto ciò che può far male al fegato e
ingrassare. Inoltre Homer è fedele e affezionato alla sua famiglia come
lo è un cane verso il suo padrone, e farebbe qualunque cosa per essa:
per amore verso Marge non esita a ributtare nel lago un enorme pesce da
lui pescato di nascosto mentre la moglie tenta di riparare il loro
matrimonio presso un consulente in montagna. Oppure non esita ad
aiutare Lisa sacrificando dei soldi risparmiati per comprarsi cose che
desidera per sé, tipo regalandole un sassofono nuovo invece che
procurarsi un condizionatore. E anche a Bart, col quale spesso perde la
pazienza, tanto da arrivare a strangolarlo, cerca di dimostrare che è
il miglior padre che si possa desiderare facendo e condividendo molte
cose con lui. Ed è anche molto affettuoso verso la piccola Maggie, pur
dimenticandosi spesso della sua esistenza. Quindi Homer sembra un tipo
egoista, pigro, ignorante, maleducato, non sempre onesto, che a volte
fa arrabbiare la sua famiglia, però quando serve sa anche essere molto
sensibile, gentile, comprensivo, sa redimersi, è quindi ovvio che agli
occhi di Marge egli sia l’unico uomo della sua vita. Homer è quindi un
cane, ma in senso figurato e tutt’altro che offensivo, anzi è anche
considerato un uomo ‘intelligente nella sua stupidità’, come dice David
Silverman, il regista dei Simpson. Certe volte anche Homer si vergogna,
tanto per restare in tema: ne sono la prova i suoi innumerevoli
“D’oh!”, esclamazione che dice quando capisce di aver detto o fatto una
cosa stupida.
Non mi vergogno nemmeno di pensare qualche volta: “Homer è un cane”.
Non l’ho mai detto a nessuno, perché non ho mai avuto ragioni per
farlo, però mi rendo conto che una frase detta così lascia un po’
spiazzati, e per i fan dei Simpson può sembrare un insulto bello e
buono. Ma pensateci bene: Homer, come i cani, ha una grandissima
passione per il cibo, anzi sbava e prova libidine davanti alla carne di
maiale, alle ciambelle e a tutto ciò che può far male al fegato e
ingrassare. Inoltre Homer è fedele e affezionato alla sua famiglia come
lo è un cane verso il suo padrone, e farebbe qualunque cosa per essa:
per amore verso Marge non esita a ributtare nel lago un enorme pesce da
lui pescato di nascosto mentre la moglie tenta di riparare il loro
matrimonio presso un consulente in montagna. Oppure non esita ad
aiutare Lisa sacrificando dei soldi risparmiati per comprarsi cose che
desidera per sé, tipo regalandole un sassofono nuovo invece che
procurarsi un condizionatore. E anche a Bart, col quale spesso perde la
pazienza, tanto da arrivare a strangolarlo, cerca di dimostrare che è
il miglior padre che si possa desiderare facendo e condividendo molte
cose con lui. Ed è anche molto affettuoso verso la piccola Maggie, pur
dimenticandosi spesso della sua esistenza. Quindi Homer sembra un tipo
egoista, pigro, ignorante, maleducato, non sempre onesto, che a volte
fa arrabbiare la sua famiglia, però quando serve sa anche essere molto
sensibile, gentile, comprensivo, sa redimersi, è quindi ovvio che agli
occhi di Marge egli sia l’unico uomo della sua vita. Homer è quindi un
cane, ma in senso figurato e tutt’altro che offensivo, anzi è anche
considerato un uomo ‘intelligente nella sua stupidità’, come dice David
Silverman, il regista dei Simpson. Certe volte anche Homer si vergogna,
tanto per restare in tema: ne sono la prova i suoi innumerevoli
“D’oh!”, esclamazione che dice quando capisce di aver detto o fatto una
cosa stupida.
Tornando a me, mi vergogno semmai quando non riesco a parlare con gli
altri per giustificare certe cose, di cui non mi vergogno. Per esempio
non mi vergogno di aver chiamato “fessi” due amici con cui giocavo a
briscola perché avevano fatto una mossa sbagliata: io avevo messo sul
tavolo un tre di briscola, dieci punti. Davanti a una carta simile gli
altri giocatori dovrebbero mettere giù delle carte del minor valore
possibile. Invece in quell’occasione i miei due compagni di gioco hanno
mostrato due assi, regalandomi undici punti a testa! In quel frangente
diedi per scontato che l’avessero fatto apposta, non pensai ad altre
eventualità, pensai solo che se fossi stato io a regalare una carta
così a un giocatore che aveva messo giù una briscola pesante, sarei
stato corretto, o sgridato. Perciò senza vergognarmene, dissi loro che
erano due fessi, che non è una parola carina ma neanche un insulto
gravissimo, che ci stava tutto nella circostanza. Non me ne vergognai
allora, non me ne vergogno adesso. Semmai mi vergogno di non essere
riuscito a spiegare all’educatore che ci osservava il motivo per cui
l’avevo fatto. Per tre volte tentai di parlare, per tre volte
l’educatore me lo impedì, senza che avessi detto mezza parola,
sentenziando freddamente: “Se avessero detto fesso a te, ti sentiresti
bene?”… E i miei due compagni di gioco che ridacchiavano! Non so se
l’abbiano fatto apposta o se non avessero altre carte da giocare a
parte quei due assi, di sicuro non erano due deficienti o novellini, e
nemmeno esordienti totali a briscola. E di sicuro non mi piace che
altri facciano impunemente cose che se le faccio io vengo ripreso o mi
vergogno.
Altre cause di vergogna (o non vergogna) sono state delle circostanze
per me spiacevoli che mi hanno fatto arrabbiare. Se poi mi sono
vergognato o no, di queste mie arrabbiature, dipende dalla situazione.
Ricordo di certi insegnanti che mi hanno urlato in faccia, ma non
sempre quando questo accadeva provavo vergogna. Qualche volta me ne
facevano provare, ma alle elementari avevo un’insegnante di sostegno
che alcune volte con me era piuttosto cordiale, ma altre volte quando
facevo qualcosa che non andava bene mi sgridava con delle urla tali che
mentre la fissavo mi sentivo scuotere la testa, prossimo al pianto.
Anzi, a volte mi picchiava pure, facendomi piangere per forza. Ammetto
che quando facevo cose cattive per cui meritavo di essere messo in
punizione non mi vergognavo sempre, ma c’erano ben altri casi in cui
era quest’insegnante che doveva vergognarsi, perché ricordo che lei
stracciava i fogli su cui scrivevo o disegnavo delle cose che non le
piacevano o che non pensava c’entrassero con la lezione. Anzi, ancora
oggi temo che se dovesse vedere le cose da me scritte dopo le
elementari straccerebbe pure quelle, libri compresi.
Anche il mio prof di educazione tecnica delle medie dovrebbe
vergognarsi di alcune cose che mi ha fatto. Un giorno mi stava
riprendendo per qualche cosa che non mi ricordo. Io dissi: “Sì, va
bene, professore, ma…”… “NON ESISTE UN MA!” strillò lui. L’urlo fu così
spaventoso e crudele che mi misi poco dopo a piangere. E lui,
aggressivo: “Che fai, piangi?”. E poco dopo ancora, mentre disegnava
una cosa sulla lavagna, quando avevo smesso di piangere mi rivolse una
domanda con lo stesso tono: “A chi parlo? Al muro?!”.
Da allora l’ho sempre odiato, come odio moltissime persone che mi hanno
fatto piangere. E poco m’importava che era il padre di un’educatrice
che io e i compagni di classe conoscevamo e frequentavamo. Una volta,
in seconda, mi ha spiegato perché si rifiutava di sentirsi dire che
aveva ragione: “La ragione viene data ai fessi!”. Da allora un po’
tutti i compagni di classe hanno adottato questo proverbio come loro
motto di battaglia o motivo di vita, facendomi sentire uno stupido. Se
uno ti fa un discorso serio, sensato, non puoi non dargli ragione. Ma
quel professore era fatto così, era bislacco e sarcastico, tanto che
faticavo a sopportarlo. Ogni volta che mi cavava di bocca un: “Scusi,
ha ragione lei”, subito dopo gridava che non aveva ragione né voleva
averne, perché aveva sempre paura che gli dessimo ragione solo per
fargli un piacere. Non prendeva nemmeno le mie difese quando i compagni
mi spaventavano con le loro maschere da Halloween, specie quella di
Scream, e non li metteva in punizione. Solo dopo ho capito che il prof
non voleva rischiare di sentirsi dire “Ha ragione lei” solo per fargli
un piacere e non perché lo pensassimo davvero. E voleva rendermi più
forte davanti agli spaventi che mi prendevo. All’epoca però mi pareva
un despota, alla maniera di 1984: quando glielo consigliai per renderlo più buono e gentile, fu lui a consigliarlo a me!
Una volta mi chiese di essere onesto nel valutare un brutto disegno che
avevo fatto. Non avevo vergogna del mio operato, però rimasi dubbioso.
Mi misi a pensare a alla fine mi diedi un sufficiente. “Sei stato
onesto”, disse lui con tono calmo.
Durante la prima settimana dell’anno di terza media non ci fu nessuna
lezione da lui tenuta, e credetti di essermi tolto dai piedi professore
e materia. Ma non era così. La seconda settimana tornò e appresi che
era pure diventato vicepreside. Mi diceva: “Comoda la vita!”, per
criticare il mio presunto scarso impegno. Una volta mi aveva messo una
nota sul diario perché era convinto che durante tutto il primo
quadrimestre non avessi fatto nemmeno un disegno. Avevo cercato di
dimostrargli che non era vero, semplicemente li facevo ma non glieli
facevo vedere, non pensavo di doverglieli consegnare. Dovevo solo
tenerli dopo averli fatti. Così sapevo.
Tra me e questo prof c’è stato un rapporto conflittuale, altalenante,
che mi ha visto in terza media prendere quattro note da lui sul diario.
Addirittura aveva cominciato a bollarmi come ‘perugino’ solo perché
aveva saputo che col babbo avevo visto allo stadio una partita tra
Bologna e Perugia. Però non mi ha mai messo le mani addosso, almeno
questo devo riconoscerlo. E fuori di scuola era una persona assai più
calma.
Un’altra insegnante con cui non sono stato a mio agio era la prof di
fisica che avevo alle superiori. Anche lei mi ha fatto vergognare
qualche volta della mia ignoranza. Per esempio urlandomi in faccia come
si dovesse fare per prendere le misure di un quaderno. Ma io penso che
a vergognarsi dovrebbe essere lei: per aver detto parolacce durante
alcune interrogazioni, per aver inveito contro me e gli altri miei
compagni di classe quando non sapevamo le cose che ci spiegava o non
mostravamo attenzione, o quella volta che non mi mostrò nessuna
sensibilità quando mi chiamò alla lavagna per interrogarmi dopo che
avevo saltato un compito in classe per la morte di mio nonno. E visto
che non gliel’avevano detto, convinti di non portarmi rispetto, aveva
creduto che avessi fatto un’assenza strategica. Addirittura penso che
dovrebbe vergognarsi per aver fatto accendere una sigaretta e tirare
una boccata a un mio compagno di classe per vedere se un proiettore
funzionava. Far fumare uno studente in un luogo pubblico! Assurdo! Ma
quando gliel’ho detto, lei ha risposto che non le sembrava tanto
assurdo, pur non avendo mai fumato. Ha detto che ormai fumano tutti! Ma
vi pare normale? Io trovo ci sia da vergognarsi. Almeno si è scusata
quando mia madre le ha detto che ero stato al funerale del nonno.
|
|
|
CI SONO BAMBINI CHE MUOIONO DI FAME
 Luca G.
Luca G.
M
 olte
volte, fino ai quattordici anni, ho avuto a che fare con educatrici che
mi mettevano in punizione e mi facevano soffrire perché mi rifiutavo di
mangiare la minestra. È un classico, tanti bambini si sono rifiutati di
farlo. olte
volte, fino ai quattordici anni, ho avuto a che fare con educatrici che
mi mettevano in punizione e mi facevano soffrire perché mi rifiutavo di
mangiare la minestra. È un classico, tanti bambini si sono rifiutati di
farlo.
Io lo facevo perché non mi piaceva l’aspetto del cibo nel piatto, o
perché avevo paura che ci cadesse dentro una foglia, o un petalo di un
fiore, persino un pezzo di carta ritagliato da una rivista. Non mi
hanno mai minacciato di chiamare il lupo se non avessi mangiato la
minestra, però mi hanno mostrato e indicato con rabbia immagini di
bambini piccoli che soffrivano la fame.
Non mi vergogno a dirlo, ma quelle immagini, l’idea di questi bambini
meno fortunati non mi ha mai fatto effetto. Impressione sì, un bambino
denutrito scheletrico, rugoso, che respira con la bocca (altra
conseguenza della denutrizione) mi ha impressionato. Ma l’idea che ci
fossero bambini piccoli che non mangiavano spesso quanto un bambino
medio dell’emisfero nord non la trovavo un’esortazione efficace a
mangiare quel che avevo nel piatto. Forse perché non ho mai sentito
sulla pelle la loro sofferenza.
In un’occasione, avevo già tredici anni e frequentavo un campo solare,
all’ora di mangiare fui trattato molto duramente da un’educatrice che
mi sembrava gentile, ma che cambiava atteggiamento quando contrariata.
Quando le dissi: “Ehi, ma questa è violenza!”, mi rispose sfacciata:
“Sì, è violenza, e allora?” , lasciandomi stupito.
Per tutta la durata del pranzo continuò a rivolgersi a me con tono
ostile, e fui messo pure in punizione. Rimasi seduto con la pietanza
davanti a piangere, senza nemmeno toccarla. Poi ebbi uno scoppio d’ira
e col braccio scagliai per terra il piatto. E l’educatrice mi costrinse
ad alzarmi in piedi, a guardarla in faccia (ed era molto più bassa di
me!) e ad ascoltarla mentre mi sgridava parlando a stento per mantenere
la calma: “Ci sono bambini che muoiono di fame - disse rabbiosa - e tu
ti rifiuti di mangiare!”.
Io rimasi lì a guardarla dall’alto in basso, piangendo e vociando.
Eppure non solo non mi pento o vergogno di aver scansato il piatto,
semmai provo dispiacere e stupore nel pensare come potesse essere così
brusca quell’educatrice se contrariata. Ricordo che qualche giorno dopo
mi aveva cacciato dalla stanza e costretto a stare sotto un portico per
punizione. Quel giorno pioveva: peggio di così poteva essere solo farmi
stare sotto l’acqua scrosciante. E in tal caso quell’educatrice secondo
me si sarebbe dovuta vergognare.
|
|
|
PICCOLA SILLOGE DI VERGOGNE
 Lu Zen pass
Lu Zen pass
La vergogna degli innamorati timidi
Per non vergognarsi l’uno dell’altro, si incontrano al buio.
La vergogna della prostituta
La prima volta lo fa di notte perché non si veda che diventa rossa. Poi, quando si è abituata, può lavorare anche di giorno.
La vergogna del frequentatore di prostitute
Passeresti col
rosso sapendo che ti fanno cento euro di multa? No. Se per andare da
una prostituta ti vergogni e diventi rosso, meglio evitare di spendere
cento euro.
La vergogna della pelle
Uno particolarmente sensibile punto da più zanzare diventa rosso: è la parte punta che si vergogna.
La vergogna frazionata
Il mutuo della vergogna è quando si diventa rossi solo in una piccola
parte del corpo, come quando una zanzara ti ha punto in un punto.
Vergogne collettive
Ci sono anche le vergogne collettive, e quelle degli stati. I politici
che hanno ordinato di fare guerre dovrebbero vergognarsi.
|
|
|
NON SI SCHERZA PIÙ
 Cesare Riitano
Cesare Riitano
T
 ra il Redentore e il Battezzatore ho sempre preferito Giovanni. Mi
piaceva la potenza delle sue parole, ma anche il suo enorme coraggio
nell’abbandonare le comodità e le ricchezze che competevano al suo
rango per gridare seminudo nel deserto la venuta del Salvatore. Ho
sempre scherzato su tutto, ma sul Battista mai; è un personaggio troppo
bello e nobile per infangarlo con qualsivoglia sarcasmo. Mi sembra di
vederlo tra le dune di un deserto palestinese. Ecco, là, quello strano
figuro che sbraita l’avvento del Messia spalancando le ganasce. È un
ometto ossuto, si copre le pudenda con una pelle di cammello, la sua
mano è ‘armata’ di bastone, è inebriato da un invincibile sacro fuoco e
consapevole della giustezza della sua missione, operata in nome e per
conto di Dio; la sua voce è potente, terrificante, destabilizzante, la
folla che lo segue è ammaliata, completamente sedotta, è scossa. Le
vibrazioni provocate dal sisma sedizioso che Giovanni sta innescando
arrivano alle corrotte stanze del Tempio di Gerusalemme, e poi più su,
fino a rimbombare nella testa coronata del dissoluto Re Erode. Se la
sua predicazione messianica esalta il coraggio, l’eroismo e la forza
della sua fede, la sua decapitazione, ma ancor più la detenzione in
quell’oscura cella di rigore, lo rende commovente per la sua umana
vulnerabilità. Soffro e mi identifico, immaginando quei drammatici
momenti che precedono la sua morte. Denudato, sporco, affamato e
fiaccato dalla sferza, Giovanni sente l’approssimarsi della fine e
crollando psicologicamente chiama in soccorso il suo amico Gesù: “Sei
tu colui che deve venire?”, manda a dire il Battista al Cristo,
sottintendendo una seconda invocazione: “Io sono qua... Salvami”. Il
Nazareno risponderà con parole volutamente ambigue, tese a incoraggiare
l’amico evidenziando tuttavia l’impossibilità di cambiarne il destino.
A Giovanni solo, disperato, abbandonato, non rimarrà altro che
rivolgersi a Dio, ma da lassù nessuna risposta; “È finita, Giovanni -
sembra pensare il profeta - nessuno verrà mai a salvarti... Ti aspetta
solo la mannaia del boia!”.
ra il Redentore e il Battezzatore ho sempre preferito Giovanni. Mi
piaceva la potenza delle sue parole, ma anche il suo enorme coraggio
nell’abbandonare le comodità e le ricchezze che competevano al suo
rango per gridare seminudo nel deserto la venuta del Salvatore. Ho
sempre scherzato su tutto, ma sul Battista mai; è un personaggio troppo
bello e nobile per infangarlo con qualsivoglia sarcasmo. Mi sembra di
vederlo tra le dune di un deserto palestinese. Ecco, là, quello strano
figuro che sbraita l’avvento del Messia spalancando le ganasce. È un
ometto ossuto, si copre le pudenda con una pelle di cammello, la sua
mano è ‘armata’ di bastone, è inebriato da un invincibile sacro fuoco e
consapevole della giustezza della sua missione, operata in nome e per
conto di Dio; la sua voce è potente, terrificante, destabilizzante, la
folla che lo segue è ammaliata, completamente sedotta, è scossa. Le
vibrazioni provocate dal sisma sedizioso che Giovanni sta innescando
arrivano alle corrotte stanze del Tempio di Gerusalemme, e poi più su,
fino a rimbombare nella testa coronata del dissoluto Re Erode. Se la
sua predicazione messianica esalta il coraggio, l’eroismo e la forza
della sua fede, la sua decapitazione, ma ancor più la detenzione in
quell’oscura cella di rigore, lo rende commovente per la sua umana
vulnerabilità. Soffro e mi identifico, immaginando quei drammatici
momenti che precedono la sua morte. Denudato, sporco, affamato e
fiaccato dalla sferza, Giovanni sente l’approssimarsi della fine e
crollando psicologicamente chiama in soccorso il suo amico Gesù: “Sei
tu colui che deve venire?”, manda a dire il Battista al Cristo,
sottintendendo una seconda invocazione: “Io sono qua... Salvami”. Il
Nazareno risponderà con parole volutamente ambigue, tese a incoraggiare
l’amico evidenziando tuttavia l’impossibilità di cambiarne il destino.
A Giovanni solo, disperato, abbandonato, non rimarrà altro che
rivolgersi a Dio, ma da lassù nessuna risposta; “È finita, Giovanni -
sembra pensare il profeta - nessuno verrà mai a salvarti... Ti aspetta
solo la mannaia del boia!”.
|
|
|

Non
potevo attendere oltre ad inviarvi questa mail, non fosse altro per
farvi i miei migliori auguri per un 2019 ricco di idee e di stimoli e,
tanta tantissima fortuna. Due parole sulla vostra rivista che conservo
e ogni tanto, nei momenti di ‘calma’, riprendo in mano e sfoglio,
trovando sempre qualcosa che o mi era sfuggito o avevo rimosso. Ho
trovato molto interessanti i pochi numeri che sono riuscita a reperire
(purtroppo non sono una lettrice da video, il cartaceo mi è più
congeniale), brevemente: temi sempre interessanti; rubriche originali e
mai scontate; fantasia e coraggio nell’aff rontare gli argomenti
trattati che, pur non essendo di facile approccio, vengono sviluppati
con molta semplicità e partecipazione sentita, sincera, autentica e, a
volte, una vena ironica, nella soff erenza e nel disagio, che dovrebbe
insegnare a tutti qualcosa. Non ultimo la grande professionalità degli
‘addetti ai lavori’. Vi auguro di cuore di continuare a regalare
emozioni a chi vi legge. Un grazie per quello che ci avete dato e
quello che ci darete.
Luciana Bernardini
Qui di seguito uno scritto di una cara amica che ha avuto, pure lei,
l’occasione di leggervi: “Sono anziana e leggo da tanto e mi sorprendo
ancora, leggendo, quando incontro parole vere: sono quelle che scrivete
voi nella Rivista Il FARO. Ho trovato verità nei racconti; nelle
storie, nelle vostre rifl essioni ironiche, battute e vignette. Tutto è
percorso da un pensiero libero e disperato e coraggioso. Ho avuto
l’impressione di trovarmi tra persone curiose della vita e golose,
perfi no, di questo vivere diffi cile ma autentico. Grazie grazie
davvero.”
Laura Perini
|
|
|

SULLA VERGOGNA
 Irene Sabelli, psicologa, psicoterapeuta
Irene Sabelli, psicologa, psicoterapeuta
(www.irenesabelli.it - email: irene@irenesabelli.it)
C
 he cos’è la vergogna? È un’emozione etichettata come ‘secondaria’, dato
che implica un certo grado di auto-coscienza, cioè di una capacità di
guardarsi da fuori e considerarsi oggetto di attenzione altrui.
he cos’è la vergogna? È un’emozione etichettata come ‘secondaria’, dato
che implica un certo grado di auto-coscienza, cioè di una capacità di
guardarsi da fuori e considerarsi oggetto di attenzione altrui.
Vergognarci, quando supera una certa intensità, fa provare una
combinazione di angoscia, rabbia, tristezza, ma si tratta di qualcosa
di diverso ancora, spesso è difficile anche riconoscerla. Anche perché,
diciamocelo, spesso non è un’esperienza piacevole. A volte è talmente
sgradita che fatichiamo a darle un nome; in quanto può risultarci
un’esperienza di disagio che rimane nebulosa. Così però non la
ascoltiamo e non riesce ad aiutarci. Sappiamo che ci stiamo vergognando
quando sentiamo che vorremmo nasconderci, sotterrarci, o addirittura
scomparire per intero, è la sensazione di essere esposti senza
possibilità di difesa allo sguardo altrui. Quando ci vergogniamo ci
viene da chiuderci in noi stessi anche fisicamente: ci raccogliamo,
abbassiamo lo sguardo, arrossiamo (o in alternativa proviamo a
mascherarla facendo l’opposto, magari gli spavaldi) e proviamo
sensazioni intense, che amplificano i nostri difetti o particolarità
facendoci sentire più insicuri, inadeguati.
Le conseguenze di quest’emozione sono molteplici e personali e…
sorpresa! Contrariamente al vissuto più immediato al riguardo, non sono
solo negative, anzi, hanno una funzione adattiva importantissima. La
vergogna, per sua stessa costituzione, coinvolge sempre qualcun altro:
quando ci vergogniamo è come se fossimo contemporaneamente al nostro
posto e anche al posto dell’altro, altro che è certamente qualcuno che
‘ci sta a cuore’ (un genitore, un amico importante, qualcuno che ci
piace...). Per capirla proviamo a pensare che coinvolge tre personaggi,
di cui dobbiamo prenderci cura...
1) Io che la sto vivendo: di che cosa ci vergogniamo in particolare?
Qual è quella nostra caratteristica che se fosse scoperta dagli altri
ci farebbe venir voglia di scappare a gambe levate? Una caratteristica
fisica tipo il naso grosso, la pancia, oppure quel mio difetto di
pronuncia? Può anche essere un comportamento, tipo “quando non riesco a
rispondere subito ad una domanda mi sento così impacciato che vorrei
sotterrarmi”. Questo ci dà informazioni su quali caratteristiche sono
importanti per la nostra autostima.
2) L’immagine che ho di me: meno mi sento sicuro di me, più bassa è la
mia autostima, più è facile che sia soggetto a provare vergogna e tenda
ad evitare situazioni di esposizione. Il rischio però è di innescare
così un circolo vizioso, che ci porta a non esporci né a rischiare mai,
non facendoci però collezionare possibili successi. La vergogna può
essere un’emozione molto penosa, perché il suo meccanismo diventa una
pena che ci auto-
infliggiamo e che autoalimentiamo senza accorgercene. Magari credendo
di prevenire ulteriori situazioni in cui verremmo visti in tutta la
nostra negatività. Finiamo così per vergognarci della nostra stessa
vergogna, sentendoci inferiori e diversi da tutti e ci isoliamo, o ci
blocchiamo.
3) L’altro da cui mi sento osservato: più mi sento diverso da un
gruppo, o più tengo all’opinione di quella persona, magari perché mi
sto innamorando di lei, o perché è un insegnante che mi piace. Più ci
tengo a fare una bella impressione, più è probabile che provi vergogna
se questo non succede. In queste situazioni il confronto può risultare
difficile per il timore di essere rifiutati o giudicati male: significa
che ci teniamo a dare una bella impressione di noi. Proprio per questo
però potrebbe essere importante per noi andare in quella direzione:
confrontarci, pur sentendoci diversi o inferiori. Per farlo è
importante soffermarci e metterci il nostro impegno per migliorarci,
per dare il meglio delle nostre potenzialità.
La vergogna ci sensibilizza alle opinioni e ai sentimenti degli altri,
è una specie di collante sociale perché ci porta a ricercare con il
nostro comportamento l’approvazione e la stima altrui. Quest’emozione,
quando non è troppo intensa, può fungere anche come regolatore di buona
distanza nella relazione, anche in senso fisico, aiutandoci a
ridimensionare il nostro spazio privato dove avvertiamo un’intrusione,
oppure a non esporci in situazioni che potrebbero a posteriori
rivelarsi controproducenti. Pensiamo ad esempio ai social network e a
cosa ci piace e non ci piace condividere, e se siamo nel dubbio un
certo grado di vergogna, può aiutarci a decidere di non condividere
qualcosa, e potremmo poi scoprire di avere fatto la cosa più giusta per
noi.  Come sapere decidere fra un confronto che ci aiuta e il rischio di
esporci troppo a qualcuno che non ci può/vuole comprendere? Si impara
affrontando un percorso fatto di prove ed errori… E se poi? E se poi?
Se poi va male? Se quella/quel ragazza/o nonostante io ci abbia messo
tutto me stesso nel dichiararmi mi rifiuta? Se mi espongo a dire la mia
opinione a quell’insegnante che mi piace così tanto e lui la giudica
una scemenza? Se mi espongo a raccontare quella cosa di me che mi fa
sentire uno sfigato al mio amico e poi lui pensa male di me? Sono
scenari possibili, la delusione, il rischio di un rifiuto sono dietro
l’angolo. Se ci esponiamo, però, corriamo anche il rischio… Che le cose
vadano bene. Mentre se non lo facciamo non lo sapremo mai, rischiando
di continuare a darla vinta alla bassa autostima. E se alla fine ci ho
messo tutto me stesso e va male, come faccio? Potremmo provare a…
Riderci sopra? Ci è possibile pensare di ridere di noi stessi se quella
situazione andasse male? Vi è mai capitato di inciampare per strada, o
di rovesciarvi qualcosa addosso, provare imbarazzo o vergogna e dopo
qualche minuto riderci sopra? Il ridere di sé stessi, serve a prendere
le distanze da un’esperienza emotiva faticosa. Inoltre, ridendo,
cogliamo l’occasione di unirci agli altri nel ruolo di osservatori
esterni, passando dall’altra parte, dalla posizione della vergogna
solitaria alla posizione dell’osservazione condivisa con gli altri.
Qualche giorno fa passeggiando per Bologna ho visto una scritta su un
muro che mi ha fatto pensare a un brutto effetto collaterale della
vergogna: “Nessuno ti consola se hai solamente segreti”.
Un’alternativa, quando non ci sia possibile riderci su, è quella di
raccontare a un altro, magari selezionato con cura, o se non lo
troviamo, a un professionista, la nostra esperienza di vergogna. Questo
è un altro modo di alleviarla, ci dà anche sollievo dal punto di vista
dell’autostima, che così possiamo recuperare: “non sarò un granché, ma
almeno so ammettere i miei difetti”. È un’idea che attenua la
svalorizzazione di sé, rimediandola con un’azione proattiva.
Come sapere decidere fra un confronto che ci aiuta e il rischio di
esporci troppo a qualcuno che non ci può/vuole comprendere? Si impara
affrontando un percorso fatto di prove ed errori… E se poi? E se poi?
Se poi va male? Se quella/quel ragazza/o nonostante io ci abbia messo
tutto me stesso nel dichiararmi mi rifiuta? Se mi espongo a dire la mia
opinione a quell’insegnante che mi piace così tanto e lui la giudica
una scemenza? Se mi espongo a raccontare quella cosa di me che mi fa
sentire uno sfigato al mio amico e poi lui pensa male di me? Sono
scenari possibili, la delusione, il rischio di un rifiuto sono dietro
l’angolo. Se ci esponiamo, però, corriamo anche il rischio… Che le cose
vadano bene. Mentre se non lo facciamo non lo sapremo mai, rischiando
di continuare a darla vinta alla bassa autostima. E se alla fine ci ho
messo tutto me stesso e va male, come faccio? Potremmo provare a…
Riderci sopra? Ci è possibile pensare di ridere di noi stessi se quella
situazione andasse male? Vi è mai capitato di inciampare per strada, o
di rovesciarvi qualcosa addosso, provare imbarazzo o vergogna e dopo
qualche minuto riderci sopra? Il ridere di sé stessi, serve a prendere
le distanze da un’esperienza emotiva faticosa. Inoltre, ridendo,
cogliamo l’occasione di unirci agli altri nel ruolo di osservatori
esterni, passando dall’altra parte, dalla posizione della vergogna
solitaria alla posizione dell’osservazione condivisa con gli altri.
Qualche giorno fa passeggiando per Bologna ho visto una scritta su un
muro che mi ha fatto pensare a un brutto effetto collaterale della
vergogna: “Nessuno ti consola se hai solamente segreti”.
Un’alternativa, quando non ci sia possibile riderci su, è quella di
raccontare a un altro, magari selezionato con cura, o se non lo
troviamo, a un professionista, la nostra esperienza di vergogna. Questo
è un altro modo di alleviarla, ci dà anche sollievo dal punto di vista
dell’autostima, che così possiamo recuperare: “non sarò un granché, ma
almeno so ammettere i miei difetti”. È un’idea che attenua la
svalorizzazione di sé, rimediandola con un’azione proattiva.

CURIOSITÀ STORICHE
 ricerca su siti internet di L. L.
ricerca su siti internet di L. L.
LA BERLINA E LA GOGNA
 Mettere ‘alla berlina’ significa, in
senso figurato, esporre qualcuno alla pubblica derisione, rendere
qualcuno ridicolo davanti a tutti. L’origine del detto è piuttosto
antica. La berlina (dal tedesco antico bretling,
asse, tavola) era una pena infamante di origine barbarica, che veniva
utilizzata soprattutto in epoca medievale, ma che era ancora vigente
nel XIX secolo; consisteva nel condurre il condannato in un luogo
esposto al pubblico (detto appunto ‘berlina’), con l’indicazione del
crimine commesso; talvolta il condannato veniva portato in giro per la
città su una carretta preceduta da un banditore che rendeva note le sue
colpe. Il condannato alla berlina poteva essere immobilizzato per mezzo
della gogna, originariamente un collare in ferro fissato a una colonna
per mezzo di una catena, successivamente sostituito da un apparecchio
in legno con fori in cui venivano bloccati la testa e gli arti. Vicino
al prigioniero un cartello indicava il suo reato e il suo nome. In caso
di morte o contumacia se ne esponeva l’effigie. La cittadinanza ave-
va una certa libertà d’infierire sul reo, e normalmente lo copriva
d’insulti, sputi e percosse… Oggi si parla di ‘gogna mediatica’, un
sistema per umiliare il prossimo meno pittoresco e apparentemente
incruento, ma sicuramente molto efficace.
Mettere ‘alla berlina’ significa, in
senso figurato, esporre qualcuno alla pubblica derisione, rendere
qualcuno ridicolo davanti a tutti. L’origine del detto è piuttosto
antica. La berlina (dal tedesco antico bretling,
asse, tavola) era una pena infamante di origine barbarica, che veniva
utilizzata soprattutto in epoca medievale, ma che era ancora vigente
nel XIX secolo; consisteva nel condurre il condannato in un luogo
esposto al pubblico (detto appunto ‘berlina’), con l’indicazione del
crimine commesso; talvolta il condannato veniva portato in giro per la
città su una carretta preceduta da un banditore che rendeva note le sue
colpe. Il condannato alla berlina poteva essere immobilizzato per mezzo
della gogna, originariamente un collare in ferro fissato a una colonna
per mezzo di una catena, successivamente sostituito da un apparecchio
in legno con fori in cui venivano bloccati la testa e gli arti. Vicino
al prigioniero un cartello indicava il suo reato e il suo nome. In caso
di morte o contumacia se ne esponeva l’effigie. La cittadinanza ave-
va una certa libertà d’infierire sul reo, e normalmente lo copriva
d’insulti, sputi e percosse… Oggi si parla di ‘gogna mediatica’, un
sistema per umiliare il prossimo meno pittoresco e apparentemente
incruento, ma sicuramente molto efficace.
IN BRAGHE DI TELA
 Ancora oggi, per indicare che una
persona è andata in rovina, si dice che “è rimasta in braghe di tela”.
Queste espressioni fanno riferimento a una condanna che veniva inflitta
nel Medioevo a chi non era in grado di pagare i suoi debiti. Si
trattava di un’espiazione pubblica che in alcune parti d’Italia
sostituiva punizioni ben più gravi, come frustate e torture, o il
carcere. Il debitore, veniva spogliato di tutto, compresa la dignità,
così si liberava dei debiti, però da quel giorno difficilmente avrebbe
trovato nella sua città qualcuno disposto a fargli credito.
Ancora oggi, per indicare che una
persona è andata in rovina, si dice che “è rimasta in braghe di tela”.
Queste espressioni fanno riferimento a una condanna che veniva inflitta
nel Medioevo a chi non era in grado di pagare i suoi debiti. Si
trattava di un’espiazione pubblica che in alcune parti d’Italia
sostituiva punizioni ben più gravi, come frustate e torture, o il
carcere. Il debitore, veniva spogliato di tutto, compresa la dignità,
così si liberava dei debiti, però da quel giorno difficilmente avrebbe
trovato nella sua città qualcuno disposto a fargli credito.
A Modena nell’angolo nord-est di piazza Grande c’è una grande lastra di marmo rosso chiamata preda ringadora
(pietra dell’arringa), perché faceva da palco per gli oratori. Serviva
anche per esporre cadaveri da identificare, nonché per mettere alla
berlina i debitori insolventi. Nel giorno del mercato, dopo aver fatto
il giro della piazza preceduto dal suono di una tromba, con la testa
rasata e uno speciale copricapo, il malcapitato doveva dichiararsi
fallito e «dare a culo nudo suso la preda rengadora, la quale sia ben
unta de trementina, tre volte, dicendo: “Cedo bonis, cedo bonis, cedo bonis”»,
e questo doveva accadere per tre sabati, su richiesta dei creditori. A
Padova, invece, all’ingresso del Palazzo della Ragione, c’è un blocco
di porfido nero poggiato su una base quadrata chiamato ‘pietra del
vituperio’. Coloro che non potevano pagare i loro debiti, anche per
cause di forza maggiore o disgrazie personali, fino al 1231 venivano
condannati senza appello al carcere perpetuo oppure al tratto di corda.
Quell’anno però S. Antonio, già vicino alla morte, si presentò al
Consiglio Maggiore chiedendo che quelle pene troppo dure fossero
sostituite dalla berlina. Il podestà non poteva certo dir di no al
Santo, ordinò quindi che “per ricerca del venerando frate Antonio
nessuno per alcun debito sia carcerato”. Nel 1260 venne ufficializzato
il luogo in cui porre la pietra e la prassi da seguire: il debitore
insolvente doveva spogliarsi (probabilmente anche i vestiti venivano
confiscati), rimanendo con la sola camicia e in mutande, quindi alla
presenza di almeno cento persone doveva battere le natiche per tre
volte sulla pietra, ripetendo cedo bonis e poi lasciare la città per
rifarsi una vita. In caso fosse rientrato senza il consenso dei
creditori, sarebbe stato costretto a ripetere l’umiliazione della
pietra e in più gli sarebbero stati gettati addosso tre secchi d’acqua.
I POVERI VERGOGNOSI
 Il 25 marzo 1495, all’interno del
Convento di San Do- menico, dieci nobili fondarono una delle più
antiche istituzioni caritatevoli bolognesi, la Compagnia de’ Poveri
Vergognosi, con lo scopo di “provvedere ai poveri, ai quali era
vergogna il mendicare per essere caduti in povertà per disgrazie ed
infortuni dei loro stati e condizioni”. Si trattava di una specie di
mutuo soccorso fra persone altolocate, esistente anche in altre città
italiane ed europee, che aveva un’indubbia finalità benefica, ma aveva
anche lo scopo di attenuare o occultare questi casi di mobilità sociale
discendente, che rappresentavano un’infrazione alle norme della società
per ceti. L’Opera Pia crebbe e prosperò, facendo sorgere e
amministrando anche altre istituzioni e riuscendo per quattro secoli a
mantenere la propria autonomia, finché, col Regio Decreto 6972 del 17
luglio 1890, meglio noto come Legge Crispi, tutti gli enti benefici
italiani con natura privatistica diventarono Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (IPAB). Successive modifi che statutarie
porteranno al passaggio all’attuale Azienda di Servizi alla Persona
(ASP). Il patrimonio, accumulato nel corso dei secoli grazie ai lasciti
delle famiglie nobili, comprende una grande quantità di beni immobili
in città e in campagna, preziosi oggetti d’arte e d’arredo, documenti,
paramenti sacri. Nel 1716, non avendo eredi, Giovanni Francesco Rossi
Poggi Marsili lasciò all’opera Pia dei Poveri Vergognosi la propria
dimora cittadina di via Marsala 7, con la clausola che ne diventasse la
sede. Lo vediamo qui ritratto da Giovanni Battista Canziani nel 1707,
mentre firma l’atto di donazione. Oggi il palazzo ospita la preziosa
Quadreria dei poveri Vergognosi, costituita da una cinquantina di
dipinti prevalentemente di scuola bolognese del Cinquecento, Seicento e
Settecento.
Il 25 marzo 1495, all’interno del
Convento di San Do- menico, dieci nobili fondarono una delle più
antiche istituzioni caritatevoli bolognesi, la Compagnia de’ Poveri
Vergognosi, con lo scopo di “provvedere ai poveri, ai quali era
vergogna il mendicare per essere caduti in povertà per disgrazie ed
infortuni dei loro stati e condizioni”. Si trattava di una specie di
mutuo soccorso fra persone altolocate, esistente anche in altre città
italiane ed europee, che aveva un’indubbia finalità benefica, ma aveva
anche lo scopo di attenuare o occultare questi casi di mobilità sociale
discendente, che rappresentavano un’infrazione alle norme della società
per ceti. L’Opera Pia crebbe e prosperò, facendo sorgere e
amministrando anche altre istituzioni e riuscendo per quattro secoli a
mantenere la propria autonomia, finché, col Regio Decreto 6972 del 17
luglio 1890, meglio noto come Legge Crispi, tutti gli enti benefici
italiani con natura privatistica diventarono Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (IPAB). Successive modifi che statutarie
porteranno al passaggio all’attuale Azienda di Servizi alla Persona
(ASP). Il patrimonio, accumulato nel corso dei secoli grazie ai lasciti
delle famiglie nobili, comprende una grande quantità di beni immobili
in città e in campagna, preziosi oggetti d’arte e d’arredo, documenti,
paramenti sacri. Nel 1716, non avendo eredi, Giovanni Francesco Rossi
Poggi Marsili lasciò all’opera Pia dei Poveri Vergognosi la propria
dimora cittadina di via Marsala 7, con la clausola che ne diventasse la
sede. Lo vediamo qui ritratto da Giovanni Battista Canziani nel 1707,
mentre firma l’atto di donazione. Oggi il palazzo ospita la preziosa
Quadreria dei poveri Vergognosi, costituita da una cinquantina di
dipinti prevalentemente di scuola bolognese del Cinquecento, Seicento e
Settecento.
|
|
|
ALLA ‘TROTTOLA’ I SEMI DI UMANITÀ DELLA POESIA
 L. V.
L. V.
“Cosa possiamo fare noi?”, chiese don Camillo.
Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando
il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna
salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo
alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà”.
(da Don Camillo e i giovani d’oggi di Giovannino Guareschi)
I
 l 2 febbraio scorso, alla Trottola di Croce di Casalecchio, alcuni collaboratori del Faro
hanno letto loro poesie. Chissà perché, ascoltandoli, mi è tornato alla
mente il racconto di Giovannino Guareschi e la risposta di Gesù alla
domanda di don Camillo: “Che cosa possiamo fare di fronte al dilagare
di un’ipocrisia senza vergogna che si sta diffondendo anche fra i
giovani?”. Don Camillo si riferiva a comportamenti sociali della fine
degli anni Sessanta.
l 2 febbraio scorso, alla Trottola di Croce di Casalecchio, alcuni collaboratori del Faro
hanno letto loro poesie. Chissà perché, ascoltandoli, mi è tornato alla
mente il racconto di Giovannino Guareschi e la risposta di Gesù alla
domanda di don Camillo: “Che cosa possiamo fare di fronte al dilagare
di un’ipocrisia senza vergogna che si sta diffondendo anche fra i
giovani?”. Don Camillo si riferiva a comportamenti sociali della fine
degli anni Sessanta.
Da allora molte cose sono cambiate, il mondo è diventato più piccolo
grazie alla diffusione degli aerei e, soprattutto grazie a Internet che
consente di comunicare in tempo reale con tutti i cinque continenti.
Sembra incredibile, ma, nonostante gli enormi progressi, la domanda
“Cosa possiamo fare?” è ancora di grande attualità. I giovani di cui si
lamentava don Camillo sfidavano il sentimento della vergogna, ma oggi
siamo andati oltre: ‘vergogna’ sembra una parola scomparsa. Basta
navigare sui vari siti e blog Internet per trovare infiniti esempi
(purtroppo anche da parte di politici) di una deriva senza vergogna che
attacca i valori fondanti della nostra civiltà. Come il vantarsi e
diffondere sui social web cose di cui una volta ci si vergognava:
portar via le coperte a un barbone che dorme al freddo, fischiare un
giocatore di calcio perché è ‘negro’, cliccare ‘mi piace’ su un post
che invoca l’uso dei forni crematori per i migranti in attesa di un
alloggio popolare… Questi post ignoranti e volgari si diffondono
rapidamente e fanno molto rumore, ma non ci devono ingannare: sono
soltanto una minima parte dei messaggi che ogni giorno circolano in
Internet, molti dei quali comunicano invece fatti e opinioni ricchi di
valori umani.
Nelle poesie lette alla Trottola,
ho ritrovato la saggezza contadina del Gesù di Guareschi, che
suggerisce di cercare, salvare e valorizzare quei semi di umanità
dall’alluvione di una volgarità ignorante. C’è un fondamento di grande
umanità nelle poesie pubblicate sul Faro e in quelle recitate alla Trottola.
Tutte comunicano bisogni e valori universali profondi. Primo fra tutti
il bisogno insopprimibile di amare e di essere amati. Da molti versi
traspaiono il mistero e la speranza di un Amore universale che va oltre
la dimensione individuale.
Ai poeti del Faro un grazie e
un invito a mantenere il coraggio anticonformista di un’arte capace di
svelare quei semi di umanità che, in questa crisi etica e morale che
stiamo vivendo, fanno meno notizia di uno slogan volgare, ma sono
fertili e conservano la potenzialità di far crescere un vasto campo di
valori umani.
|
|
|
|
|
|
29 LUGLIO 2008
 Luca G.
Luca G.
S
 e
mi alzo la mattina e sembro nervoso, non è sempre per colpa mia, ma è
colpa degli altri. Quindi sono più innervosito che nervoso. Io mi alzo
tranquillo, se poi per una scemenza qualsiasi mi provocano, è normale
che io sembri essermi alzato con la luna storta: mi hanno fatto
agitare. Ma non è giusto darmi addosso per questo! Esempio: 29 luglio
2008. Siamo in vacanza a Foggia, io mi alzo dal letto che sono
tranquillissimo, e dopo essermi cambiato ed aver fatto colazione, cosa
vedo? Vedo che nella mia stanza hanno sostituito il tavolo con un altro
più piccolo. Irritato, chiedo ai miei genitori di rimettere tutto come
prima, ma loro non lo fanno. E figuratevi se lo facevano! Ma
soprattutto figuratevi se mi avvertivano! Perché non lo hanno fatto?!
Perché non mi hanno detto, spiegato o neanche provato a dirmi di questa
loro idea e di metterla in atto?! Rimarreste sorpresi anche voi se
vedeste il vostro amministratore far svuotare la casa dagli operai
senza preavviso! e
mi alzo la mattina e sembro nervoso, non è sempre per colpa mia, ma è
colpa degli altri. Quindi sono più innervosito che nervoso. Io mi alzo
tranquillo, se poi per una scemenza qualsiasi mi provocano, è normale
che io sembri essermi alzato con la luna storta: mi hanno fatto
agitare. Ma non è giusto darmi addosso per questo! Esempio: 29 luglio
2008. Siamo in vacanza a Foggia, io mi alzo dal letto che sono
tranquillissimo, e dopo essermi cambiato ed aver fatto colazione, cosa
vedo? Vedo che nella mia stanza hanno sostituito il tavolo con un altro
più piccolo. Irritato, chiedo ai miei genitori di rimettere tutto come
prima, ma loro non lo fanno. E figuratevi se lo facevano! Ma
soprattutto figuratevi se mi avvertivano! Perché non lo hanno fatto?!
Perché non mi hanno detto, spiegato o neanche provato a dirmi di questa
loro idea e di metterla in atto?! Rimarreste sorpresi anche voi se
vedeste il vostro amministratore far svuotare la casa dagli operai
senza preavviso!
Infatti ho detto a mio padre: “Non avete il diritto di piombare così in
una casa qualsiasi e cambiare i mobili senza preavviso! Voi state
sempre a fare innovazioni, a cambiare le cose! Sostituite sempre
qualcosa, un mobile, un elettrodomestico, quello che è! Arredare la
casa, fare le innovazioni dev’essere un divertimento, non un lavoro!
Dev’essere un piacere, non un dovere, e voi lo fate come un obbligo!
Che bisogno c’è di cambiare tutto? Perché fate certe cose senza dirmi
niente?”.
Ho detto che dovevano dirmi le cose, spiegarmele, dirmi la verità, che
non era giusto che loro dicessero le bugie e io non potessi farlo. Fra
una frase e l’altra il babbo mi chiede cosa voglio, perché non capisce.
La discussione diventa una litigata molto violenta, nella quale non ci
picchiamo
ma ci lanciamo urla a vicenda.
Comincio a chiedergli perché non mi dicono mai la verità, perché non sono di parola.
Vista la reticenza del babbo, che continua a non capire quel che dico,
io grido: “Quand’ero piccolo, mi sgridavate perché dicevo le bugie. Ora
che sono grande, mi sgridate perché dico la verità. Vuoi spiegarmi cosa
volete da me?”. Do un calcio a un bidone, mio padre piagnucola: “Non ce
la faccio più! Basta!”. Allora, capendo che ormai i miei faranno le
loro operazioni indipendentemente dalla mia opinione, e non volendo
essere presente, prendo il biglietto dell’autobus e vado al cancello:
“ME NE VADO!”. urlo, sottintendendo che tornerò quando loro avranno
finito, ma col tono di uno che vuole andarsene da casa per sempre.
Ho preso le mie cose e sono andato alla fermata dell’autobus. Ero
deciso ad allontanarmi per un po’ finché le acque non si fossero
calmate e finché tutto non fosse stato rimesso a posto. Ma la
circostanza e il tono da me usato hanno fatto intendere che io volessi
andarmene per sempre. E allora ho gridato di nuovo: “Quand’ero piccolo
vi arrabbiavate perché dicevo le bugie. Ora vi arrabbiate perché dico
la verità. Volete spiegarmi cosa pretendete da me? LASCIATEMI IN
PACE!!!”.
Solo dopo un po’, quando sono più calmo, mia madre mi spiega che già da
tempo lei e il babbo volevano buttare via della roba vecchia. Quanto al
mio tavolo, che era malridotto, vecchio e impolverato. volevano
cambiarlo con uno nuovo, magari anche buttarlo, ma solo perché pieno di
tarli. Vista la mia reazione hanno stabilito che non bisognava
necessariamente buttarlo via: se proprio dovevamo tenerlo, almeno si
poteva pulirlo dai tarli. Da parte loro volevano anche buttarlo, ma
alla fine l’abbiamo solo ripulito e rimesso dov’era, buttando via solo
un paio di vecchie scarpe e conservando in una scatola dei nastri
stereo 8 che buttarli via era un delitto assoluto. Chissà quanto
valgono adesso.
Tutto finito, ma io ricordo questa cosa perché non è giusto che non mi
dicano niente solo perché sono il figlio (e quindi quello che conta di
meno) o perché io dico sempre no alle loro proposte. Chi sono io per
non essere avvertito? Cavolo, non avevo mica cinque anni e un cervello
incapace di intendere e volere! Anzi, ne avevo già ventuno! Perché non
me ne hanno parlato? Perché non mi hanno preparato in anticipo all’idea
di cambiare il tavolo? Forse avevano paura dei miei no? Avevo voglia di
fargli capire l’assurdità della situazione prendendo le loro sedie e i
loro sgabelli per buttarli fuori e urlare: “Ora siamo pari! Così
imparate a togliere i mobili agli altri senza dire nulla a nessuno!”.
Vi piacerebbe se un pazzo vi sgomberasse la casa così di colpo? Non
credo. Questo mi hanno fatto percepire i miei genitori quel giorno! Mi
hanno rovinato la mattina, LORO! E anche la gola!
Non mi vergogno di essermi arrabbiato così tanto, né delle reazioni che
ho avuto. Non sono il tipo di persona che scappa di casa per non
tornare più, con me le cose non sono mai come sembrano. Sono stato
male, certo, ma non mi vergogno. Se poi gli ho chiesto scusa è un altro
paio di maniche, succede che le persone chiedano scusa senza pentirsi o
vergognarsi delle loro azioni. Chiedono scusa per rincuorare chi si è
angustiato, si fa un discorso per spiegare e giustificare il
comportamento negativo, ma non sempre si prova vergogna.
|
|
|
IO E A.
 Luca G.
Luca G.
Dieci anni fa conobbi A., un’educatrice
che gestiva un’attività di cucina nella quale si preparavano dolci e
dolcetti da offrire ad altri utenti del Tasso. Avevo deciso di entrarne
a far parte per un solo scopo: preparare una torta farcita di crema al
cioccolato che avevo assaggiato qualche mese prima. Nient’altro.
Devo dire che tra me e A. era nato un rapporto favoloso, infatti mi era
molto simpatica, tanto che una notte (e non mi vergogno a dirlo) sognai
che io e lei eravamo distesi su un letto matrimoniale a chiacchierare.
Magari penserete che eravamo nudi, sotto le coperte, prima o dopo di
consumare un amplesso. Ma non è così, anzi: con me le cose non sono mai
come sembrano. Io e A. eravamo vestiti, rilassati sopra le coperte ben
fatte e intenti a parlare. Non sapete quante volte io e mio padre siamo
stati distesi sul letto a fare questa cosa. Niente di erotico o di
incestuoso.
Quanto all’attività con A. non avevo ancora avuto la possibilità di far
fare quella torta che desideravo, pure perché non eravamo solo noi due,
c’era anche un amico di nome R. Dopo le vacanze natalizie, le casse di
via Tasso rimasero chiuse a tempo indeterminato, e finché non si erano
completati i calcoli delle spese dell’anno prima non si poté comprare
niente. Mancando le uova in cucina, fummo costretti per un tempo
lunghissimo a preparare ricette senz’uova: fiadoncini (plum cake a base
di formaggio), caramelle al cioccolato, perfino piadine.
Una mattina, quando ormai le casse erano state riaperte (e le uova
potevano essere riacquistate), tutto cambiò: arrivato in via Tasso,
discussi con A. di questa storia delle casse chiuse. Come mai due anni
prima, quando avevo fatto un’altra attività di cucina, questa cosa non
si era fatta?! Pur parlando educatamente, A. aveva iniziato a mostrare
una certa impazienza e ostilità. Poi arrivò R., lo presi in disparte,
sapendo che avrebbe dovuto essere lui a scegliere il dolce da fare per
la volta dopo, e tentai di convincerlo a chiedere di fare la torta
farcita al cioccolato. Gli dissi con calma e gentilezza: “Senti, ti
devo dire una cosa…”… “No”, mi interruppe A.
Io, con gentilezza e fretta, iniziai a mentire su quel che stavo per
dire a R.: “È completamente esule da…”… “No!” , mi interruppe A. di
nuovo, per dirmi che non dovevo dirgli niente. “Non voglio
condizionarlo - dissi, tentando di nascondere le mie intenzioni -
volevo solo…”. A. mi interruppe ancora una volta senza che potessi
completare la frase. “Non vedo perché devo per forza lasciar stare R.”,
provai una quarta volta, ma A. mi interruppe anche questa volta. Allora
esasperato lanciai un grido: “OH!”. Un urlo di rabbia e disappunto che
mi diranno in seguito essere stato colto anche dalle case vicine al
Tasso. Alla fine decidemmo di fare la zuppa inglese (la proposta, come
d’accordo, doveva essere approvata all’unanimità). I miei due compagni
di attività si calmarono, io no.
 Tirai fuori la ricetta e A. mi costrinse a essere educato. Lessi la
ricetta con voce malferma e tenendo il foglio tra le mani tremanti
dalla rabbia che la stessa A. mi aveva fatto scaturire. Notai che mi
stava guardando con disappunto. Come se non bastasse, quando le dissi
che il latte era leggermente scaduto lei mi sgridò mostrando di non
curarsene. Dopo quella giornata, ho ridimensionato il mio sentimento
verso A. e ho smesso di idolatrarla. Non mi vergogno di questo, e
nemmeno di aver alzato la voce. Non sopporto di essere interrotto di
continuo ogni tre secondi, senza avere la possibilità di spiegarmi o di
spiccicare anche solo mezza parola. In questo modo non c’è
comunicazione. E possono esserci risvolti negativi, equivoci,
complicazioni, rancori. Con A. non sono passato da un estremo
all’altro, non ho preso a odiarla, ma durante il resto di quella
giornata ero talmente infuriato con lei che mentre tornavo a casa mi
ritrovai a inveirle contro, e persino a desiderare un manichino o un
sacco da pugile contro cui sfogarmi. E quella notte ebbi un terribile
mal di pancia, avendo somatizzato tutto quanto. Un tutto che si poteva
evitare se A. mi avesse lasciato dire qualche parola in più e non mi
avesse fatto arrabbiare. Solo col tempo, parecchi giorni dopo, la
rabbia svanì.
Tirai fuori la ricetta e A. mi costrinse a essere educato. Lessi la
ricetta con voce malferma e tenendo il foglio tra le mani tremanti
dalla rabbia che la stessa A. mi aveva fatto scaturire. Notai che mi
stava guardando con disappunto. Come se non bastasse, quando le dissi
che il latte era leggermente scaduto lei mi sgridò mostrando di non
curarsene. Dopo quella giornata, ho ridimensionato il mio sentimento
verso A. e ho smesso di idolatrarla. Non mi vergogno di questo, e
nemmeno di aver alzato la voce. Non sopporto di essere interrotto di
continuo ogni tre secondi, senza avere la possibilità di spiegarmi o di
spiccicare anche solo mezza parola. In questo modo non c’è
comunicazione. E possono esserci risvolti negativi, equivoci,
complicazioni, rancori. Con A. non sono passato da un estremo
all’altro, non ho preso a odiarla, ma durante il resto di quella
giornata ero talmente infuriato con lei che mentre tornavo a casa mi
ritrovai a inveirle contro, e persino a desiderare un manichino o un
sacco da pugile contro cui sfogarmi. E quella notte ebbi un terribile
mal di pancia, avendo somatizzato tutto quanto. Un tutto che si poteva
evitare se A. mi avesse lasciato dire qualche parola in più e non mi
avesse fatto arrabbiare. Solo col tempo, parecchi giorni dopo, la
rabbia svanì.
|
|
|
LASCIANDO CORRERE I PENSIERI
 Maria Chiara Reitani
Maria Chiara Reitani
Trentasei anni fa mi laureavo al DAMS
(Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo), con una tesi sul regista
Luca Ronconi e il laboratorio di Prato, un’esperienza che si era tenuta
per l’appunto a Prato dal 1976 al 1980 e che aveva visto la nascita di
tre spettacoli: Calderon, La torre
di Hofmansthal, e uno spettacolo ispirato a un testo di Pasolini, di
cui mi sfugge il nome, ma che posso rintracciare senza molta
difficoltà. Avevo allora ventisei anni e ora ne ho quasi sessantadue,
li compirò, per la precisione il 10 agosto del 2019. Ora frequento al
mattino dalle 9 alle 13 (pressappoco) un centro diurno di cui è
responsabile Carmela e a cui partecipano Cecilia, Rosalia, Mirella,
Cinzia e Monica, signore che son tutte nella terza età, cioè mie
coetanee con delle disabilità, e mi sento meno sola. Finalmente riesco
a realizzare che ho un grosso dono, quello di saper scrivere, ma nello
stesso tempo riesco a focalizzare i miei limiti, per esempio l’essere
molto disordinata, smemorata, tendente al perfezionismo ma con scarsi
risultati. Mi piace essere elegante, passione che ho ereditato da mia
madre, che ho perso nel 2010, quando aveva ottantotto anni. Posso dire
senza alcun dubbio che l’ho assistita fino agli ultimi attimi della sua
vita e l’ho vista morire. Per la precisione ricordo che aveva
balbettato delle frasi e poi si era accasciata sul cuscino ed era
spirata. Cosa dire? Sentirsi orfani non è piacevole. Avevo perso mio
padre, a cui ero molto legata, a soli quindici anni, un dolore che
tuttora non sono riuscita ad elaborare del tutto. Ora che ho
sessantadue anni posso dire che ho avuto coraggio e ho fatto delle
scelte precise, quali lasciare il mio paese natale, un paesone della
Puglia in cui erano nati il sindacalista Giuseppe Di Vittorio e Nicola
Zingarelli,
 l’autore del vocabolario della lingua italiana, che era il mio bisnonno da parte materna. Condivido con Calvino la passione per Il Corriere dei Piccoli,
che mio nonno Gaetano aveva fatto rilegare e ne sono risultati due
libroni, ora impolverati, che mi divertivo a sfogliare soprattutto
quando ero ammalata. Da piccola soffrivo di crisi di acetone ed ero
spesso a letto. Devo dire che personaggi quali Bonaventura e il suo
Milione, Bibì e Bibò, la Tordella e, in tempi più recenti, Valentina
Mela Verde, una ragazzina adolescente con cui mi ero identificata, mi
hanno fatto tanta compagnia.
l’autore del vocabolario della lingua italiana, che era il mio bisnonno da parte materna. Condivido con Calvino la passione per Il Corriere dei Piccoli,
che mio nonno Gaetano aveva fatto rilegare e ne sono risultati due
libroni, ora impolverati, che mi divertivo a sfogliare soprattutto
quando ero ammalata. Da piccola soffrivo di crisi di acetone ed ero
spesso a letto. Devo dire che personaggi quali Bonaventura e il suo
Milione, Bibì e Bibò, la Tordella e, in tempi più recenti, Valentina
Mela Verde, una ragazzina adolescente con cui mi ero identificata, mi
hanno fatto tanta compagnia.
|
|
|
|
|
|
PICCOLO CAPOLAVORO DI UN ITALO-AMERICANO
 Matteo Bosinelli
Matteo Bosinelli

Come bisogna ricordare le origini italiane di Fabiano Caruana, non meno
interessante è che il giapponese Nakamura - mi risulta - ha sposato una
italiana!
In astratto, questi due fortissimi giocatori si equivalgono, ma Fabiano
ha sfoggiato una partita veramente straordinaria, con un sacrificio di
Regina, 19) Dxf6 , incredibile e imprevedibile. Il seguito è pura
tecnica: il nero viene lentamente soffocato dai pezzi bianchi, fino
alla resa.
Caruana – Nakamur (Londra 2016)
1) e4 c5
2) Cf3 d6
3) d4 c x d4
4) C x d4 Cf6
5) Cc3 a6
6) Ag5 e6
7) f4 h6
8) Ah4 Db6
9) a3 Ae7
(se Dxb2 il bianco guadagna la Regina con Ca4)
10) Af2 Dc7
11) Df3 Cbd7
12) 0-0-0 b5
13) g4 g5
14) h4 g x f4
15) Ae2
(fino a qui tutto già teoricamente studiato)
15) ... b4
(Novità teorica che sarà confutata dalla mossa 19 ... Dxf6)
16) a x b4 Ce5
17) D x f4 Ce x g4
18) A x g4 e5
19) D x f6
(Splendida! Il nostro connazionale si fa valere e il nero è bloccato)

19) A x f6
20) Cd5 Dd8
21) Cf5
(ed ora, per la Regina, il bianco ha due soli cavalli: ma che cavalli !)
21) … Tb8
22) Cxf6+ D x f6
23) Txd6
(forse
era meglio giocare la più incisiva Cxd6+ - Rf8 , Af5 e il bianco vince
grazie alla ottima collocazione dei suoi pezzi minori)
23) ... Ae6
24) Thd1 0-0
(Pur essendo riuscito ad arroccare, il nero si ritrova però ancora con tutti i suoi pezzi bloccati)
25) h5 Dg5+
26) Ae3 Df6
(se ...Dxg4, Cxh6+)
27) Cxh6+ Rh8
28) Af5 De7
(in posizione persa, il nero cerca di liberarsi tatticamente)
29) b5 De8
30) Cxf7+ Txf7
31) Txe6 Dxb5
32) Th6+

e il nero abbandona
|
|
|

 Soliti socialisti
Soliti socialisti
Da avanguardisti a passatisti, il passo è breve. Devi metterti la
maglia aziendale e crederci. Questa è l’aria che tira in certe
cooperative dove se ti permetti di chiedere l’aumento di stipendio ti
rispondono che lo fai perché ‘stressato’ dalla situazione.
Problemi di ansia???
L’esercizio della scrittura, potrebbe essere paragonato a una sorta di specchio...
La
matassa da dipanare altro non è che il conflitto interno tra ciò che
siamo e ciò che per gli altri rappresentiamo. Credo, in fondo, che non
si possa piacere a tutti.
La città
È pur sempre vero che si parla degli assenti.
Déjà vu
I
ricordi si accavallano in quello che maldestramente chiamiamo déjà vu.
Tra il Vero e il Falso la memoria ripercorre momenti che spesso sono
avvolti da una nebbia che scontornando visi, fatti ed eventi rendono il
contesto quasi plastico.
Monoliti
Come
monoliti di un colore nero (dove il nero tutto assorbe e nulla
riflette) si confrontano senza esclusione di colpi... Probabilmente due
facce di una stessa medaglia.
Esclusi dal Gotha
La
lotta è sempre più dura... La percezione di non poter entrare e di
essere esclusi dal gotha è insostenibile. Gli esterofili governano il
mondo. Non si è profeti in patria.
 Siamo i primi
Siamo i primi
Siamo i primi a bistrattare le cose che dovremmo preservare.
Sottigliezze
Capita sovente che sia una questione di lana caprina.
Zelig
Il modello è quello del biadesivo, appiccicare il profilo di una
persona ad un’altra. Non si riesce mai a capire di che diavolo stiano
parlando, se non tramite un sillabario.
Militante
Caso
curioso è quello della fotografia di stampo militante. Non è possibile
distinguere se è il soggetto ripreso a essere militante oppure il
fotografo.
Città perduta
Cerco una Città oramai perduta, semplicemente uguale alle altre. La kappa che circonda tutti noi è quasi soffocante.
Piccole considerazioni
Capita
al capo popolo di essere osannato, idolatrato e perfino clonato, in
quelle che dovrebbero essere per lui normali atteggiamenti nei
confronti dell’esistenza/resistenza alla vita. Credo che il problema
sia poi alla mattina, quando, come si suol dire, guardandosi allo
specchio, il nostro capo popolo non ne trova riscontro… Che la
‘coerenza’ sbiadisca, con il passare del tempo?
Forma e sostanza
Ma è proprio vero che l’abito fa il monaco.
Fotoreportage
Molto
più ‘attiva’, è la registrazione tramite una forma di scrittura
personalizzata che riesca a rilevare fatti e circostanze accaduti. Nel
fotoreportage o fotogiornalismo, la questione, non è, a mio avviso,
quella di cambiare o testimoniare il mondo, ma quella di non essere
‘passivi’ nella rilevazione degli accadimenti. costruire un’immagine è
questione molto complicata: non basta scattare a raffica per ottenere
una ‘buona immagine’.
Appartenenza
Curioso caso, è il senso di ‘appartenenza’ che ci contraddistingue
tutti quanti… Vogliamo appartenere a qualche cosa o a qualcheduno, un
sistema ‘corporativo’ che ci induce, specchiandoci a riconoscerci
nell’‘altro’. Giusto o sbagliato, si perdona per essere perdonati.
 Piccola considerazione
Piccola considerazione
Strani
scherzi produce il cosiddetto mondo capitalista… Nella moltitudine
degli oggetti ti puoi comprare anche simboli del mondo comunista.
Radical chic
Si
possono barattare presunti diritti civili a discapito dei diritti dei
lavoratori? Questo è a mio avviso, l’andazzo che da anni in Italia si è
insinuato in maniera silente. La spina che collega un mondo di tipo
radical chic, di stampo americano a un mondo cattolico terzomondista è
proprio questo…
Autoreferenzialità
L’aria
è stantia, verrebbe voglia di spalancare la finestra e di scaraventare
fuori tutto… Ma come ogni sistema che si rispetti, il livello di
autoreferenzialità tende a saturare ogni cosa (discorsi, parole,
immagini)…
Il paradiso perduto
Ti ho
parlato in maniera schietta, confidando nella tua capacità critica ed
emotiva, ma quando si toccano determinati argomenti lontani o recenti
del passato, scatta improvvisamente una sorta di barriera, uno scudo
impenetrabile, le relazioni saltano... Il sistema consolidato in
decenni di politica aveva reso la città impermeabile ad accadimenti di
natura sociale.
Charles Bukowski
“Ci sono dei momenti in cui la follia diventa così vera che non è più follia”.
Il prezzo da pagare
Difficile
rimanere amici, quando il tuo interlocutore ti identifica come suo
antagonista. È una miscela che mescola patologia, parte caratteriale ed
esperienza probabilmente negativa della vita. Quando il problema è
riconoscere i propri limiti, altro non rimane che aspettare un’altra
ricaduta... Il prezzo più alto lo paga sempre il paziente.
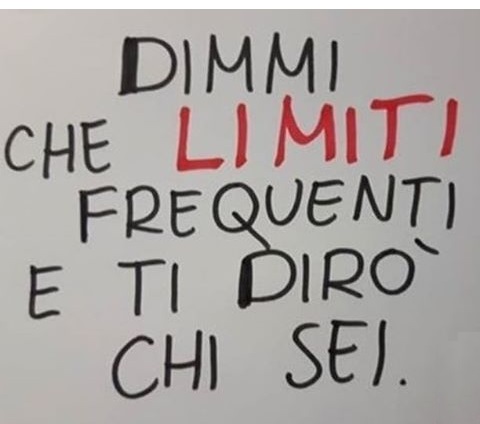 All'origine
All'origine
Solo il tempo ci restituirà le cose come sono all’origine.
Questioni di punti di vista
Qui Houston, siamo lavoratori / utenti, non utenti / lavoratori… Sembra la stessa cosa, ma non lo è.
La pillola amara
È amara la pillola da ingoiare, quando scopri che si è circondati da
arrampicatori sociali. Il problema non è quello di avere delle
ambizioni nella vita, ma dimenticarsi da dove si proviene.
Fermo immagine
Il
fermo immagine è rimasto tra la fine degli anni Settanta e metà anni
Ottanta. Evidentemente cristallizzare il tempo in quel periodo è utile
per mantenere quella tensione mai sopita... Spirale di fatti e
avvenimenti che ingloba chiunque vi venga a contatto.
 Trompe l'oeil
Trompe l'oeil
Non si
smette mai di meravigliarsi di fronte alla propria famiglia d’origine…
Il trompe l’oeil che si presenta davanti a noi è qualcosa di
terrificante, ti aspetti un appoggio se non materiale, almeno ‘morale’,
e ti trovi invece una ‘voragine’.
I confronti, spesso sono spietati e quando, a concorrere all’interno
della famiglia ci si mette pure il padre, ti accorgi di avere un
‘fratello’ acquisito che tigna e strilla, si piange addosso, riversa
continuamente le sue aspettative sul figlio preferito, dimenticandosi
totalmente dell’altro (che sarei IO).
Libertà di stampa
La
pretesa di voler svolgere la professione di ‘giornalista’, informando e
nello stesso tempo esprimendo il proprio punto di vista, con la
conseguenza di ricevere delle non troppe velate ‘minacce’ per ciò che
si scrive, rende il tutto più credibile.
La nausea
Si
arriva a un punto della vita dove la nausea per ciò che si fa è
veramente insopportabile... L’odore di morte e di morti che ti circonda
si taglia nell’aria. Ti viene chiesto di comprendere il contesto in cui
ti trovi e la tua mente corre a fatti che sono accaduti nel tempo anche
recente. È un tritacarne, il sistema, non lascia scampo. Andare o
rimanere??? Un segno che ti rimane impresso comunque.
Disfatta
Ogni uomo è artefice del proprio destino... E della propria disfatta.
Dipende dal contesto
Alza le mani, sei circondato... La miglior difesa è l’attacco... Sei solo paranoide.
Cerchiobottismo
Ripeto, non simpatizzare per questo governo, non significa non rispettare la volontà di chi l’ha votato.
 Il fondo
Il fondo
Se è pur vero che le persone non si conoscono mai abbastanza, fino in
fondo, e al fondo non c’è mai fine, è altrettanto vero che non ci
conosciamo noi stessi fino in fondo, e al fondo non c’è mai fine.
La radio
Le inflessioni dialettali comunque parlano di te.
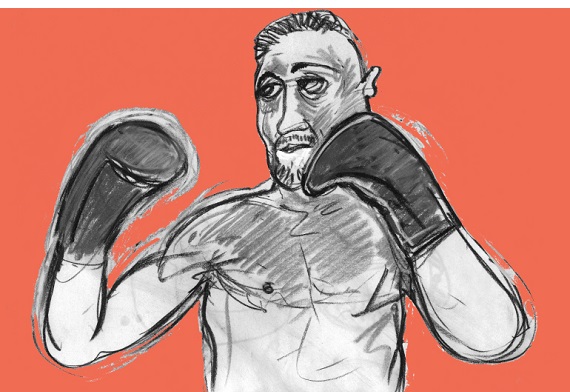 Tensione di vita
Tensione di vita
Tenere
la guardia alta. Come un incontro di box, non c’è tregua, il gancio è
in agguato. Può arrivare da chiunque. Posizionarsi in modo da poter
schivare l’attacco avversario...
Padre
Se non può essere autorevole, almeno che sia onesto...
Droghe di classe
Il
mondo del proibito, droghe incluse, fa scaturire curiosi ragionamenti
di tipo morale/classista. All’appartenenza politica corrisponde un
certo tipo di stupefacente che vorremmo in qualche modo legalizzare.
Ma che sapore ha...
Sempre
più conformi a un canone prestabilito, come prodotti esposti in un
supermercato, dove la differenza tra uno e l’altro è nell’etichetta, ma
il sapore è standardizzato... Confidiamo in un’esistenza di vita quanto
mai sorprendente, speciale e unica.
 Con / testi
Con / testi
Nell’intenzione
di ricontestualizzare oggetti decontestualizzati dalla loro funzione,
come molti artisti propongono dopo M.D. [Marcel Duchamp n.d.r.], mi
domando se un’opera di arte sacra (il soggetto ritratto) lo sia perché
in un contesto sacro (chiese, templi eccetera) oppure lo sia per un
significato intrinseco.
L'incubo
Vorrei dormire e non svegliarmi più. Vorrei svegliarmi e non dormire più.
Tutti dentro
La pena
all’ergastolo, in fondo, cela una condanna a morte nei fatti. È
pensabile che un paese che si ritiene civile, possa utilizzare questo
sistema di condanna “occhio per occhio”? Quando funzionari dello stato
pensano di far marcire nelle patrie galere persone che si sono
macchiate di reati gravi??? La realtà è che la reclusione perdurante
nel tempo non porta a nessun ravvedimento, le galere a poco servono, se
utilizzate in questa maniera, e le persone si incattiviscono…
Tutti dentro 2
Non è
certo perdono cristiano quello che ho in mente, solamente credo che le
battaglie civili siano improntate a una certa direzione quando le
necessità lo impongano… Rifuggire dai facili calcoli politici,
mantenere la lucidità...
Scrivere una fotografia
Mi
arrovello da tempo, nel tentativo di “scrivere una fotografia”... Di
gettito, a posa lunga eccetera. Cogliere l’attimo, ma non essere nello
stesso tempo passivo, come una foto di reportage, dove a raffica spari
quasi senza pensare. Il troppo pensare, invece, non fa altro che
assomigliare alla scrittura classica, dove tutto funziona e rimane
l’esercizio stilistico un po’ fine a sé stesso. Non rimane che
l’anti/scrittura, come l’anti-fotografia di W. K. (William Klein
n.d.r.) riportava alla luce soggetti un tantino scomodi ripresi con
l’obiettivo giusto. E alla giusta distanza.
 Scrivere una fotografia 2
Scrivere una fotografia 2
Dettagli
sfocati, oggetti volutamente tenuti in secondo piano, particolari che
riaffiorano dal fondo indistinto eccetera. Cogliere e nello stesso
tempo togliere i fronzoli di una scrittura di tipo autoreferenziale (ci
sono io e poi io), la complessità di tutto ciò vale la scrittura.
Scene di vita
Ho
fatto scelte sbagliate, sono agitato per le conseguenze. Non esco più
dal tunnel. Datemi qualcosa da ingerire. Sto impazzendo… E giù
tranquillanti.
Lento cambiamento
Credo
sia la frustrazione, che segue all’impotenza di incidere in qualche
maniera nei cambiamenti, che ci porta spesso e volentieri a domandarci
della nostra incapacità di relazione e di confronto con il mondo…
Confini allargati
Curioso
caso è quello dei confini allargati. Dove abbiamo ad esempio un
infermiere che si crede medico, un medico che si crede primario e così
via, all’infinito.
|
|
|

Franz Kafka: La metamorfosi
 I
l primo romanzo di Kafka, La Metamorfosi,
scritto nel 1912 e pubblicato nel 1915 a Lipsia, è una delle opere che
hanno influenzato maggiormente la narrativa del XX secolo.
I
l primo romanzo di Kafka, La Metamorfosi,
scritto nel 1912 e pubblicato nel 1915 a Lipsia, è una delle opere che
hanno influenzato maggiormente la narrativa del XX secolo.
La storia inizia così: un venditore ambulante, Gregor Samsa, una
mattina si svegliò trasformato in un parassita mostruoso. Pensò, come
se niente fosse, che comunque doveva andare a lavorare, ma la sveglia
non aveva suonato e quindi aveva perso il treno. Ebbe paura di
prendersi una lavata di capo dal suo principale. Tutti i membri della
famiglia intanto si preoccupavano, perché non si era ancora alzato.
Gregor faceva molta fatica, perché non aveva braccia e gambe ma solo
delle zampette. A un certo punto della mattinata il procuratore andò a
casa sua per sapere perché non era andato al lavoro. Gregor ne fu
infastidito, perché secondo lui non c’era nessun bisogno di essere così
allarmisti, ma i genitori gli urlarono che il procuratore era venuto a
lamentarsi anche perché ultimamente il suo lavoro era insoddisfacente.
Gregor dalla sua stanza cercò di rassicurare il procuratore. La sorella
Grete, sentendo la sua voce si preoccupò: pensò che Gregor stesse male
e avesse bisogno di un medico. Il padre, poi, visto che Gregor non
apriva la porta, pensò che ci fosse bisogno di un fabbro. Gregor capiva
che volevano aiutarlo, allora cercò di girare la chiave con i denti, ma
con fatica perché non aveva dei veri propri denti. Alla fine riuscì ad
aprire, uscì dalla stanza e si fece vedere. Il procuratore fu
meravigliato nel vederlo. Il padre fu preso da un grande vergogna e
serrò il pugno, ostile, quasi a volerlo ricacciare verso la camera. Mi
ha colpito il fatto che il protagonista nonostante tutto volesse andare
a lavorare. Cercò di spiegare al procuratore che senza lavorare non
avrebbe saputo vivere e lo pregò di mettere una buona parola con il
principale, dicendo che ci si poteva sentire incapaci, ma proprio
allora bisognava riprendere con più impegno e concentrazione. Aggiunse
anche che doveva pensare ai suoi genitori e a sua sorella. Ma fin dalle
prime parole il procuratore fece cenno di andarsene e il padre, invece
di trattenerlo, ricacciò Gregor nella sua stanza col bastone. Il fianco
sinistro, colpito, sembrava ridotto a un’unica cicatrice.
Poco dopo Gregor, avendo antenne molto sviluppate, venne attirato da un
gran profumo di cibo: c’era infatti una tazza di latte zuccherato con
dentro pezzi di pane. Ma Gregor non la gradì, e il fianco sinistro gli
faceva troppo male. Il suo corpo era grande, perciò si sistemò sul
divano e vi passò tutta la notte. La mattina seguente di buon’ora la
sorella entrò nella stanza e vide che il latte non era stato toccato.
Gregor forse per orgoglio voleva che Grete gli portasse qualcosa da
mangiare, ma di sua spontanea volontà, senza che lui glielo chiedesse.
Lei cominciò a portargli verdura appassita, ossa avanzate, qualche
chicco d’uva e del formaggio. Per far capire a Gregor che poteva
mangiare indisturbato, se ne andava e girava la chiave nella toppa.
Quando rientrava per rassettare la stanza, Gregor correva subito via,
per non farsi vedere. Riceveva il suo cibo ogni giorno in quella
maniera, la prima volta al mattino, quando i genitori e la domestica
dormivano ancora, la seconda dopo mezzogiorno, quando i genitori
facevano un pisolino. La sorella non diceva ai genitori di questi
servizi, perché non voleva preoccuparli.
Gregor, origliando alla porta, sentiva che parlavano sempre di lui e
facevano discussioni su come comportarsi. Fra i vari discorsi sentì
anche parlare della situazione finanziaria della famiglia. La fabbrica
del padre cinque anni prima aveva avuto un crollo e Gregor aveva avuto
il compito di mantenerli tutti, compito svolto egregiamente, tanto che
si era persino pensato di mandare Grete al conservatorio. La notizia
bella fu che erano rimasti alcuni risparmi. Questa somma però non
bastava, bisognava lavorare… Ma chi lavorava ora che lui era in quelle
condizioni? Il
padre non poteva fare affidamento sulle proprie forze, la madre
soffriva d’asma, la sorella era troppo giovane. Questi pensieri gli
procuravano sensi di colpa, ma soprattutto tristezza. Avrebbe voluto
ringraziare Grete per quello che faceva, ma si vergognava davanti a
lei. La sorella si accorse che Gregor padroneggiava bene il proprio
corpo e che gli piaceva fare un salto dal soffitto fino al pavimento,
quindi pensò di togliere molti mobili dalla camera per agevolarlo in
questo; la madre non voleva, perché sperava in un miglioramento e
pensava che poi Gregor avrebbe voluto la stanza in ordine (con la
mobilia). Alla fine ebbe la meglio la sorella. Da parte sua Gregor era
dispiaciuto che gli togliessero i suoi mobili, soprattutto la
scrivania, perché su di essa aveva fatto tutti i compiti delle scuole
elementari medie e commerciali. Inoltre voleva che non fosse tolto un
quadro, perciò si adagiò su di esso con tutto il corpo. Fu allora che
la madre lo vide e svenne. Trascorso un po’ di tempo rientrò il padre e
Grete gli riferì che la madre era svenuta e il fratello era uscito
dalla stanza. Il padre travisò, pensò che Gregor avesse combinato
chissà che cosa e si mise a inseguirlo. Gregor non lo riconosceva più,
tanto era cambiato di carattere. Prima era tanto buono e adesso lo
rifiutava. Si avvicinò alla porta della sua stanza per fargli capire
che aveva intenzione di entrarvi, ma il padre non capì e si mise a
inseguirlo fino a quando Gregor inciampò in un mucchio di mele
facendosi male.
Da quel giorno la porta della cucina fu lasciata semiaperta, così
Gregor poteva vedere come se la passava la famiglia: il padre si
addormentava sulla seggiola, la madre cuciva e la sorella studiava
francese e stenografia. Le spese per il governo della casa venivano
sempre più limitate, tanto che furono venduti i gioielli. La domestica
venne licenziata, quindi toccava Grete aiutare la madre. In Gregor si
alternavano momenti di affetto per la famiglia (a volte pensava di
riprendere in mano la situazione economica della casa) a momenti di
rabbia, per la cattiva assistenza che gli riservavano. La pulizia era
sbrigata frettolosamente. Per invitare Grete a pulire meglio Gregor si
metteva nei punti più sporchi, ma la sorella non puliva lo stesso. Però
non voleva che nessuno pulisse la stanza di Gregor, voleva pulirla solo
lei. Una volta la pulì la madre e lei la sgridò. Ma Grete era stanca,
quindi il compito fu affidato a una donna ossuta, che era molto forte e
non aveva nessuna ripugnanza per Gregor, ma lo offendeva chiamandolo
‘vecchio scarafaggio’, ‘blatta’… Egli pensava che la donna invece di
scocciarlo con questi epiteti, avrebbe dovuto fare meglio la stanza
tutti i giorni.
Ormai Gregor non mangiava quasi nulla, anche perché la sua stanza era
in disordine. La famiglia si era abituata a mettere lì quello che non
serviva e di queste cose ce n’erano molte. La famiglia aveva affittato
un vano a tre tizi serissimi, maniaci dell’ordine e meticolosi non solo
a proposito della loro stanza, ma anche dell’andamento del resto della
casa, in particolare della cucina. Non sopportavano roba inutile o
sporca. Inoltre avevano arredato la stanza con mobili di loro
proprietà. Per questo erano diventati inutili molti oggetti che non si
potevano né vendere né buttar via (la cassetta delle ceneri e quella
dell’immondizia). I tre mangiavano in sala, la famiglia invece mangiava
in cucina. Erano molto schizzinosi anche nel giudicare il cibo.
Una sera avendo sentito Grete suonare il violino, gli affittuari
chiesero al padre se la ragazza poteva suonare per loro, ma furono
delusi da quell’esibizione e si misero a parlare tra loro vicino alla
finestra. Gregor, che osservava la scena da lontano, ci rimase male. Si
immaginò di portare Grete col suo violino nella sua stanza, per
confidarle che voleva pagarle il conservatorio. Decise quindi di uscire
e di presentarsi a quei tre. Il padre cercò di rassicurarli, ma quelli
si incollerirono, non si sapeva se più per il comportamento del padre o
per il fatto di aver avuto uno scarafaggio nella casa. Così vollero
andare via e non pagare niente, anzi volevano chiedere un indennizzo.
Per questo avvenimento, proprio la sorella che fino a quel momento era
stata così buona, volle sbarazzarsi di Gregor. Diceva che bisognava
pensare che quello scarafaggio non fosse lui: se fosse stato lui,
avrebbe capito che la convivenza con gli esseri umani era impossibile e
se ne sarebbe andato via spontaneamente. Allora lei non avrebbe più
avuto un fratello in senso fisico, ma avrebbe onorato la sua memoria.
Così invece aveva cacciato gli affittuari e sembrava volersi
impadronire dell’intera casa…
Gregor aveva molto dispiacere della situazione nella quale dovevano
vivere i suoi genitori per colpa sua e pensava di dover scomparire,
proprio come diceva la sorella. Finché una notte esalò l’ultimo
respiro. Fu trovato il mattino seguente dalla donna delle pulizie. La
famiglia, dopo i primi dispiaceri, si riunì e si mise a scrivere delle
lettere: al direttore della banca, al committente e al principale.
Decisero di traslocare in un appartamento più piccolo e più economico,
ma situato in una posizione migliore.
Questo libro mi ha molto commosso. Ho visto crudeltà, ma nello stesso
tempo umanità, sia nel comportamento della sorella nei confronti del
protagonista (gli portava da mangiare) sia i quello del protagonista
nei confronti della famiglia (avrebbe voluto nonostante tutto andare a
lavorare per mantenere la famiglia).
Consiglio la lettura perché è una storia che offre tanti spunti di
riflessione. Quello che ho scritto non è il riassunto del libro, ma
l’insieme di avvenimenti che mi hanno più toccato.
|
|
|
‘IL TAGLIAERBE’ E ‘LUCY’. Due film a confronto
 Luca G.
Luca G.
 P
rotagonisti
P
rotagonisti
Nel film Il tagliaerbe, il protagonista è Giobbe Smith (Jeff Fahey), un
giovane giardiniere ritardato che vive in una piccola città americana,
nella quale abita anche uno scienziato, il dottor Lawrence Angelo
(Pierce Brosnan) che vuole aiutarlo a raggiungere un livello di
quoziente intellettivo normale e per questo conduce su di lui un
esperimento, sottoponendolo ad iniezioni di droghe neurotrope e
immersioni nella realtà virtuale. In Lucy, la protagonista è una
studentessa americana di nome Lucy Miller (Scarlett Johansson), che
vive a Taipei e che ama andare in discoteca. Un giorno viene convinta
dal suo fidanzato a fargli un favore, che consiste nel fare una
consegna molto particolare. Rapita, stravolta e quasi violentata, Lucy
si ritrova costretta a fare da corriere della droga e le viene inserito
nell’addome un sacchetto contenente il CPH4 sintetico, un enzima
prodotto dalle madri in gravidanza per sviluppare il feto. Dopo un
tentativo di stupro, Lucy riceve un calcio nello stomaco, il sacchetto
si rompe e l’enzima si sparge nel resto del corpo. Nel frattempo, un
docente universitario che vive a Parigi, il professor Samuel Norman
(Morgan Freeman) teorizza che gli esseri umani usano solo il 10% del
loro cervello. Se lo usassero al 100%, farebbero delle cose eccezionali
come il controllo della materia.
Aumento intelligenza
Sia Giobbe che Lucy vedono aumentare di molto la propria intelligenza.
Ma mentre quella di Giobbe aumenta in un mese, l’intelligenza di Lucy
aumenta nel giro di pochissime ore. In entrambi i casi comunque, i
personaggi imparano prestissimo a fare cose che prima non sapevano fare
(come guidare un’auto e maneggiare armi con una mira precisissima) e
acquisiscono una memoria fotografica, tanto che Giobbe impara il latino
in meno di due ore e Lucy impara a memoria le 6734 pagine di ricerche
del professor Norman. Giobbe e Lucy acquisiscono anche capacità mentali
al di fuori dell’ordinario, come la telepatia e la telecinesi.
Conseguenze dell’esperimento e capacità acquisite
Nel film Il tagliaerbe, l’esperimento avviato da Angelo va fuori
controllo, perché l’intelligenza di Giobbe continua a crescere e le sue
facoltà continuano a cambiare, nonostante l’interruzione
dell’esperimento stesso. Inizialmente Giobbe è sconvolto
dall’acquisizione di poteri di natura psicocinetica, ma poi impara a
controllarli e si convince che bisogna continuare il trattamento a cui
è sottoposto per desiderio di usarli a suo vantaggio. Inoltre il
supervisore di Angelo viene spinto dal direttore del suo centro di
ricerche a indirizzare l’esperimento verso scopi militari, così
sostituisce di nascosto le droghe neurotrope con stimolanti
dell’aggressività, che Giobbe assume senza accorgersene. Mentre i suoi
poteri mentali si fanno sempre più forti, egli rende il proprio
carattere sempre più freddo, diventa onnipotente e crudele e comincia a
usare i poteri che ha acquistato per fare del male a chi l’ha sempre
maltrattato e a chi tenterà di ostacolarlo. Infine preso da deliri di
onnipotenza ed allucinazioni smette di ragionare e decide di usare le
sue capacità per dominare il mondo. Anche nel film Lucy la protagonista
acquisisce poteri telepatici e telecinetici, ma la sua metamorfosi è
molto più rapida e una volta che il CPH4 sintetico ha iniziato a fare
effetto, la ragazza diventa fin da subito fredda, consapevole di sé,
mantiene lucida la sua capacità di ragionare e i poteri che manifesta
all’inizio sono subito tanti, molto sviluppati e destinati a evolversi
velocemente. Dopo essersi liberata dei suoi carcerieri, Lucy li uccide
con le loro armi mostrando di aver acquisito una mira infallibile.
Quindi dopo aver finito di consumare la loro cena, essersi cambiata
d’abito e armata, lei realizza che ha solo dodici ore di tempo per fare
qualcosa della sua vita, di cui percepisce la fine imminente, dato che
molte sue azioni le fanno consumare energia. In compenso i poteri che
ottiene sono già molto ben allenati: oltre alla telepatia e alla
telecinesi acquisisce due capacità che Giobbe non ottiene: quella di
cambiare il proprio aspetto fisico con la sola forza di volontà (utile
per mimetizzarsi all’aeroporto) e addirittura quella di viaggiare nel
tempo e nello spazio, cosa che fa quando arriva a usare il 99% del
cervello verso la fine del film. Sia Giobbe che Lucy col tempo
diventano sempre più freddi, ma mentre Giobbe arriverà a elaborare un
piano per entrare nella rete informatica e governare il mondo, Lucy non
avrà nessuna idea di cosa fare dei suoi poteri e della vita che le
rimane. In ogni caso l’aumento delle sue capacità si manifesta quando
si fa asportare il sacchetto dell’enzima sintetico dal corpo (senza
bisogno dell’anestesia, poiché l’enzima l’ha resa anche insensibile al
dolore) e racconta per telefono alla madre che riesce a ricordare cose
come le prime poppate da neonata o addirittura altre che si sono
verificate prima della sua nascita. Lucy è anche in grado di sentire le
funzioni vitali e i fluidi corporali delle persone che tocca, cosa che
le succede quando abbraccia una sua amica. Leggendo nella mente di un
boss coreano toccandogli le tempie, Lucy apprende che tre suoi corrieri
della droga sono diretti a Berlino, Parigi e Roma. Lucy riesce poi a
contattare molto in fretta il professor Norman mostrandogli le sue
capacità ancora limitate, ma già molto sviluppate. Lucy comunica a
Norman la propria situazione e le proprie opinioni riguardo alle teorie
del professore, definendole elementari, anche se “è sulla strada
giusta”. In questa scena, Lucy dimostra che può controllare
l’elettricità entrando in televisori, telefoni e computer: una facoltà
che in Il tagliaerbe Giobbe inizialmente non possiede e che arriva a
sviluppare solo alla fine del film. Sia Giobbe che Lucy, quando
iniziano a manifestare i loro poteri non sono in grado di entrare nelle
onde magnetiche ed elettriche, ed entrambi hanno comunque bisogno di
macchine per farlo. Giobbe usa i macchinari del laboratorio dove
lavorava Angelo per accedere alla realtà virtuale e poi per tentare di
entrare nella rete informatica e governare il mondo, e Lucy usa un
telefono per chiamare prima il professor Norman e poi gli agenti
dell’antidroga della polizia francese dopo aver preso il posto del
corriere diretto a Parigi e aver cambiato aspetto. Sull’aereo diretto
in Francia a Lucy succede una cosa che a Giobbe non avviene mai:
rischia di vedere disintegrato il suo corpo per espandersi sotto forma
di energia. Come Giobbe, però, anche lei diventa dipendente dalla droga
usata per aumentare le capacità cerebrali, ne è la prova che per
evitare che il suo corpo si disintegri la ragazza è costretta ad
assumere un’altra dose del CPH4 sintetico.
 Il destino dei protagonisti
Il destino dei protagonisti
In entrambi i film, sia Giobbe che Lucy abbandonano la propria forma
umana, ma non nello stesso modo e non dopo gli stessi eventi. In Il
tagliaerbe, Giobbe usa la telepatia per raggiungere il centro di
ricerche e togliere di mezzo le guardie. Quindi si immerge
definitivamente nella realtà virtuale, lasciandosi dietro solo il suo
corpo. Per raggiungere la rete informatica planetaria prova numerose
combinazioni, e proprio quando esplodono delle bombe che Angelo aveva
disposto per fermarlo, trova quella giusta. Prima di abbandonare la sua
città, Angelo sente squillare il proprio telefono e poi tutti quelli
del mondo, pertanto si presume che Giobbe riuscirà a governare il mondo
sotto forma di pura energia. Per Lucy il discorso è diverso. Dopo aver
recuperato le ultime sacche di CPH4 sintetico dal boss coreano che
l’aveva fatta rapire, si incontra con il professor Norman e alcuni suoi
colleghi e dimostra di nuovo di non sapere cosa fare delle sue facoltà.
Il professore le suggerisce di riversare le tante ed elevate conoscenze
acquisite dopo l’assunzione dell’enzima all’interno di una chiavetta
USB, in modo che l’umanità possa sfruttarle a fin di bene. Lucy si
trasforma allora in una specie di computer nel quale inserisce le sue
conoscenze. Mentre si verifica all’esterno della stanza una sparatoria
tra gli agenti dell’antidroga e gli uomini del coreano, la ragazza
riesce nell’intento, ma poi raggiunge il 100% dell’uso del cervello e
nel tentativo di scappare dalla sparatoria si proietta attraverso il
tempo e lo spazio tornando indietro fino al Big Bang e poi scompare,
lasciando solo i vestiti. E poi? Che cosa farà? Il film termina con i
protagonisti maschili che si fanno domande su dove si trovi, e come
risposta compare su un cellulare un messaggio nel quale lei dice: “Io
sono ovunque”. Questo vuol dire che è diventata onnipresente e
onnisciente, che è in ogni luogo e c’è sempre stata pur non essendo
visibile, un po’ come Dio, ma non dà nessuna idea di cosa farà dal
punto di vista pratico.
 Considerazioni personali e teorie scientifiche
Considerazioni personali e teorie scientifiche
Il tagliaerbe è un film particolare, nel quale viene ipotizzato che in
futuro si userà moltissimo la realtà virtuale. Ci sono molte scene che
sono state ricreate con la computer grafica, come nella pellicola Tron
del 1982. Ma in verità la realtà virtuale, tridimensionale, ricreata al
computer, non si è rivelata di così grande uso. Al massimo viene usata
per scopi didattici (vengono per esempio simulate immersioni in città
del passato ricostruite alla perfezione) o per scopi ludici, con
videogiochi visionari. Dal 2000 in poi ha prevalso la realtà aumentata,
cioè l’arricchimento delle percezioni sensoriali per mezzo di
informazioni ottenute con dispostivi artificiali. Esempi di realtà
aumentata sono il cruscotto dell’automobile, o lo smartphone, o la
chirurgia robotica. È vero che ne Il tagliaerbe si usano guanti e
visori che sono poi stati utili per la realtà aumentata, ma gli scopi
pratici offerti da quest’ultima sono di gran lunga superiori di quelli
offerti dalla realtà virtuale. La gente ha convenuto che è più utile
rimanere nella realtà fisica e sfruttare informazioni utili riguardo a
essa piuttosto che immergersi in un mondo del tutto diverso, virtuale,
lontano da quello reale al punto da dimenticarsi in che realtà si vive
ed è presente il proprio corpo. Se con la mente si è nel mondo
virtuale, nel corpo si resta in quello reale. L’uso che si fa oggi di
Internet, dei computer, degli smartphone e degli oggetti con cui ci si
tiene connessi è la dimostrazione del trionfo della realtà aumentata,
con cui è possibile orientarsi (usando la bussola o il GPS), informarsi
sui luoghi che si stanno visitando o fare operazioni chirurgiche
complesse e delicate. L’unico vantaggio della realtà virtuale rispetto
a quella aumentata è che non c’è il rischio che venga violata la
propria privacy. Il film con Jeff Fahey e Pierce Brosnan è tratto
liberamente da un racconto di Stephen King, nel quale si narra di un
signore, ridotto nel film a personaggio secondario, che chiama qualcuno
che gli tagli il prato venendo però falciato lui stesso. Racconto nel
quale la realtà virtuale non c’entra affatto, pur lasciando un po’
inquieto chi ha visto Il tagliaerbe. Lucy è stato a mio parere più
divertente e meno riflessivo di quest’ultimo, e Scarlett Johansson è
una garanzia in quanto avvenenza e protagonismo, nella sua filmografia
non mancano infatti film d’autore come Lost in translation o La ragazza
con l’orecchino di perla. E vengono anche discusse interessanti teorie
sul tempo, oltre che sulla materia, nonostante l’idea che noi usiamo
solo il 10% del cervello sia solo una leggenda metropolitana e non una
teoria scientifica. Lucy è un film che Luc Besson ha non solo diretto,
ma anche scritto rendendolo pieno di azione ed effetti speciali che
balzano all’occhio e stupiscono, ma basandosi su teorie scientifiche
spesso senza fondamento. Prima di riversare il suo sapere in una
chiavetta USB, Lucy mostra di poter controllare la materia per mezzo di
comunicazioni tra una cellula e l’altra semplicemente modificando in
forme molteplici la sua mano destra e spiega che gli esseri umani hanno
codificato la natura e la loro esistenza per mezzo di unità di misura
per renderla comprensibile. Ma non sono le discipline come la
matematica o la fisica a governare l’universo, esse permettono solo di
comprenderlo. L’unica vera cosa che regola l’esistenza è il tempo, in
quanto prova dell’esistenza della materia. Senza tempo, noi non
esistiamo. Una teoria che potrebbe anche starci, che si può considerare
credibile, ma che cozza contro quella su cui si basa il film con la
Johansson: che noi usiamo solo il 10% del nostro cervello. È vero che
alcuni aspetti del cervello sono ancora sconosciuti, ma ad ogni zona di
esso si conosce tutto e a ciascuna è stata attribuita una funzione.  La radice della teoria ha origine fra l’Ottocento e il Novecento,
quando si fecero alcuni studi neurologici che portarono gli esperti a
interrogarsi sulle funzioni e potenzialità delle zone intorno alla
corteccia cerebrale. Ma molti anni dopo, il neuroscienziato Barry
Beyerstein dimostrò che non è vero che il 90% del cervello è
inutilizzato. Se fosse così, si potrebbero arrecare gravi danni a una
zona non attiva del cervello senza provocare conseguenze, e comunque il
processo di selezione naturale che caratterizza l’evoluzione umana
avrebbe già portato ad eliminare quella parte del cervello non
utilizzata. Inoltre, decenni di ricerche successive al 1930 circa e
l’uso della TAC e della risonanza magnetica hanno dimostrato che tutte
le parti del cervello sono sempre attive, anche durante il sonno. Le
mappature fatte con le nuove tecnologie hanno dimostrato che il
cervello è un organo singolo, ma con zone distinte per diverse
funzioni, sempre attive.
La radice della teoria ha origine fra l’Ottocento e il Novecento,
quando si fecero alcuni studi neurologici che portarono gli esperti a
interrogarsi sulle funzioni e potenzialità delle zone intorno alla
corteccia cerebrale. Ma molti anni dopo, il neuroscienziato Barry
Beyerstein dimostrò che non è vero che il 90% del cervello è
inutilizzato. Se fosse così, si potrebbero arrecare gravi danni a una
zona non attiva del cervello senza provocare conseguenze, e comunque il
processo di selezione naturale che caratterizza l’evoluzione umana
avrebbe già portato ad eliminare quella parte del cervello non
utilizzata. Inoltre, decenni di ricerche successive al 1930 circa e
l’uso della TAC e della risonanza magnetica hanno dimostrato che tutte
le parti del cervello sono sempre attive, anche durante il sonno. Le
mappature fatte con le nuove tecnologie hanno dimostrato che il
cervello è un organo singolo, ma con zone distinte per diverse
funzioni, sempre attive.
Se ci fossero delle cellule cerebrali inutilizzate, sarebbero già state
notate. La teoria confutata da Beyerstein resta comunque popolare e
ritenuta credibile per effetto di organizzazioni e religioni come
Scientology, per portare la gente a migliorare le proprie capacità e
potenzialità. Ma l’auto
perfezionamento è una cosa, l’attività cerebrale è un’altra. Ed è
quindi difficile, forse addirittura impossibile, dimostrare che con
l’applicazione quotidiana (lo studio o l’esperienza) si possa giungere
a manifestare o anche solo sbloccare certi poteri mentali, che sono
spesso un terreno battuto nella fantascienza.
|
|
|
L’ACQUA E LA SAGGEZZA - PENSIERO ZEN
 Lu Zen pass
Lu Zen pass
Gli arabi fanno tre tipi di tè e lo
versano dall’alto (NOTA1). Quando si versa il tè, più è lungo il filo e
più il tè si raffredda.
Versare i liquidi in senso dinamico li vitalizza. L’acqua diventa acqua viva perché si forma un vortice..
Secondo Masaru Emoto (NOTA 2) l’acqua ha una memoria: lo si vede
mettendone in frigo piccole quantità per formare cristalli. Se prima le
si fa ascoltare della musica, l’acqua raccoglie le vibrazioni. Con la
musica heavy metal non si formano cristalli, i cristalli vengono tutti
scomposti, con la musica di Mozart vengono cristalli armoniosi,
corrispondenti al brano armonioso. Se le dici “ti amo” l’acqua rimane
bella se le dici degli insulti va a male.
Ci sono persone studiose ma non sagge, che pensano che i saggi che
dicono queste cose non siano credibili. Non è detto che se sono in
pochi a dire una cosa non sia vera.
NOTA 1
Gli arabi insaporiscono il tè con foglie di menta fresca e lo servono in bicchieri anziché nelle tazze.
Molto complesso anche il rituale del tè dei Tuareg, gli uomini blu del
Sahara: secondo tradizione vengono consumati tre tè alla menta diversi,
uno di seguito all’altro. Si passa dal primo tè, forte e amaro (come la
morte), servito alzando la teiera, così che si formi un po’ di schiuma
nella tazza, al secondo tè per il quale viene aggiunta altra acqua
bollente nella teiera e altre foglie di menta per un risultato più
dolce (la vita), per finire con un tè molto più zuccherato e leggero
(l’amore). Questa complessa cerimonia richiede circa 2-3 ore
Da Storia: una bevanda antica migliaia di anni http://www.illyteca-brescia.it/download-pdf/cultura-te.pdf
NOTA 2
Masaru Emoto (Yokoama 1943 - 2014) saggista giapponese
|
|
|

CI FA ARROSSIRE MA PUÒ RAGGELARE
 Francesco Bridi
Francesco Bridi
(Da LiberaLaMente n.45 - settembre 2012)
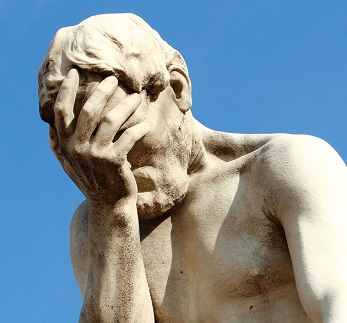 S
i dice spesso che, per vergogna, si arrossisce. Una sensazione di
calore che
si trasmette alle guance e non di rado si percepisce lungo il corpo.
Un’emozione, nascente dall’interiorizzazione del giudizio altrui, che
ci avvampa; tale, nel suo essere ‘calda’, da essere visibile agli occhi
di chi ci sta accanto. Un’emozione che, pur nella sua a volte
drammaticità, genera, almeno per chi se ne accorge, energia (magari
statica).
S
i dice spesso che, per vergogna, si arrossisce. Una sensazione di
calore che
si trasmette alle guance e non di rado si percepisce lungo il corpo.
Un’emozione, nascente dall’interiorizzazione del giudizio altrui, che
ci avvampa; tale, nel suo essere ‘calda’, da essere visibile agli occhi
di chi ci sta accanto. Un’emozione che, pur nella sua a volte
drammaticità, genera, almeno per chi se ne accorge, energia (magari
statica).
Un barlume di senso di presenza, anche se fonte di imbarazzo per chi lo
sente, con desiderio di fuga, spesso insostenibilmente impellente. Ci
si sente forse incapaci di muoversi, un blocco di cemento senza vie di
uscita. Un viso che si colora e si accalora, che lascia trasparire
emozioni, anche se vorrebbe nasconderle.
In fondo, un essere umano, anche se percepito è cristallizzato nella
sua fragilità dell’essere nel mondo, in quel momento e in quel luogo,
con quelle persone.
Ma esiste anche una vergogna fredda, gelida come un pianto muto. Una
vergogna che non fa arrossire, che non scalda, nella quale il sangue
non pare circolare, ma, anzi, sembra congelarsi, a fermare il respiro
in un attimo attonito. Una vergogna che non sembra avere dimensioni né
peso, ma scivola nell’aria, svapora o si sbriciola, fuggendo nel
silenzio e nell’assenza. Anzi, essendo già essa stessa silenzio e
assenza. Un fantasma che, in quanto tale, non ha un corpo, dal quale si
è già fuggiti o, addirittura, nel quale non si è mai stati. Che non ha
mai avuto specchi o pozzanghere o occhi in cui riflettersi. E che,
quindi, non ha imparato a vedersi e a vedere, e non sa come si fa e non
sa cosa e non sa chi. Una vergogna che non balbetta perché non sa
parlare, non sa come si fa, non sa a chi. In un’epoca che appare sempre
più senza vergogna, chi la prova in questa “versione” si vede costretto
a seppellirla sempre di più, nel profondo, e impercettibile agli altri,
rimbombare di un’eco senza fine. Perché, certo, non sa vedere e non sa
parlare, ma non ha mai smesso di sentire. Nel suo essere ciclone
invisibile, sente il silenzio che sta nell’occhio, nel centro di quel
ciclone, ma sente anche il turbinìo della tempesta che tutto travolge e
tutto fagocita, nel vuoto del suo essere fantasma.
QUATTRO ‘IRREGOLARI’ HANNO CONQUISTATO TOKYO
DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AL GIAPPONE IN RAPPRESENTANZA DELL’ITALIA
 Tratto dall'articolo di Benedetta Cucci ll Resto del Carlino 8 febbraio 2019
Tratto dall'articolo di Benedetta Cucci ll Resto del Carlino 8 febbraio 2019
[...]
MacKenzie (al secolo Giovanni Elmi), Augustine Noula, Francesco
Valgimigli e Andrea Giordani, quattro bolognesi di nascita o residenza
che fanno parte del Collettivo Artisti Irregolari di Bologna, sono gli
unici italiani volati in Giappone attraverso le loro opere, per
partecipare a ParaArt Tokyo, kermesse dedicata all’arte creata da
disabili, sia fisici che mentali, andata in scena dall’1 al 5 febbraio
con oltre settecento opere esposte. Quattro identità potenti con un
percorso esistenziale a tratti psicologicamente interrotto che, con
altri ventun creativi, animano il collettivo nato in seno al
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche nel 2014 e
coordinato da Concetta Pietrobattista dell’Ausl, educatrice dalla
trentennale carriera, che cita, come ispirazione l’Art Brut: sono tutti
figli di Jean Dubuffet, gli Irregolari… Come sottolinea Pietrobattista,
rispetto al-
la fondazione del gruppo dalla creatività differente, la sua attività è
finalizzata “a rendere le persone autonome e visibili nell’ambito del
territorio”.
E prosegue: “Queste persone hanno sempre avuto una predisposizione per
il mondo pittorico o della scultura, ma grazie al Comitato ‘Nobel per i
Disabili’ creato da Dario e Jacopo Fo, sono diventati visibili sulla
galleria virtuale arteirregolare.it,
creata in collaborazione col nostro Dipartimento, dove sono stati
immediatamente ospitati e contattati per la loro produzione”. Anche
grazie a due recenti esposizioni di opere, una a Palazzo d’Accursio e
l’altra all’Alcatraz di Santa Cristina di Gubbio, è poi arrivato
l’interessamento da parte della cooperativa Soteria-NPO Tokyo [...]
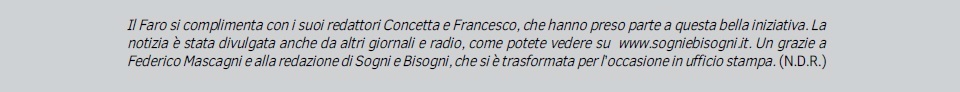
SENZA PERDERSI NEL BUIO
 Fabio Tolomelli
Fabio Tolomelli
(Da Il Cappello di Padre Marella - ottobre-novembre-dicembre 2018)
 La rivista Il Faro nasce per orientare
le persone che si sono perse nel buio di una società che emargina le
persone per comportamenti non in linea con quelli considerati
‘normali’. L’obiettivo del giornale è di utilizzare la scrittura e la
lettura per fare emergere, scoprire e riconoscere aspetti della propria
personalità e testimoniare alle persone che si sono appena ammalate,
che è possibile stare meglio o guarire.
La rivista Il Faro nasce per orientare
le persone che si sono perse nel buio di una società che emargina le
persone per comportamenti non in linea con quelli considerati
‘normali’. L’obiettivo del giornale è di utilizzare la scrittura e la
lettura per fare emergere, scoprire e riconoscere aspetti della propria
personalità e testimoniare alle persone che si sono appena ammalate,
che è possibile stare meglio o guarire.
Il giornale è stato pensato dal dottor Filippi, da mia moglie e da me e
ha goduto da subito di un forte interesse da parte di operatori ed
utenti. Un grazie va a Paolo Facchinetti che ha curato la grafica fino
a che la salute glielo ha permesso; poi a Lucia Luminasi e a Concetta
Pietrobattista che sono le persone che si sono impegnate per salvare la
rivista dopo che è deceduto Paolo, anche nominando una nuova direttrice
responsabile, Michela Trigari e un grafico, Marco Balboni. Grazie a
loro il giornale è diventato più espressivo e lo si può apprezzare
anche su internet. La redazione è formata da un nucleo storico e da
alcuni redattori ‘satellite’ e tutti sono potenziali lettori. La cosa
più importante è poter crescere umanamente capendo che ci sono delle
difficoltà psicologiche che, se condivise, possono facilitare un
percorso di salute attraverso una società più giusta e rispettosa.
Conoscendo la sofferenza psichica sotto il profilo umano si può
superare quello che è lo stigma. I tumulti delle onde nel buio della
vita ci disarcionano da quelle che sono le nostre sicurezze. Quando mi
sono ammalato ho perso la facoltà di interpretare correttamente la
realtà, di avere un buon umore, di avere una memoria efficace e via di
seguito. Però con le cure e con il tempo ora sto meglio ed ho
recuperato queste facoltà che erano andate perse. L’importante è avere
il faro che ci permette di orientarci e trarci in salvo. A me... mi ha
salvato.
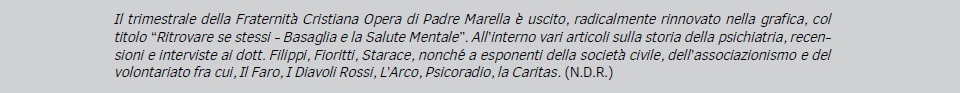
|
|
|

L’ALIBI
U
 n
giorno un gattino era nel parco di un grande ex ospedale psichiatrico
chiuso, dove però era aperto un CSM in cui molte persone sofferenti di
salute mentale potevano beneficiare di aiuto. Il piccolo felino, mentre
curiosava qua e là, vide un cane, che si trovava anche lui nel parco
per passeggiare in compagnia del suo padrone e lo apostrofò così: “Ehi,
ciao! Senti, ma tu vieni qui per quel motivo là?”. n
giorno un gattino era nel parco di un grande ex ospedale psichiatrico
chiuso, dove però era aperto un CSM in cui molte persone sofferenti di
salute mentale potevano beneficiare di aiuto. Il piccolo felino, mentre
curiosava qua e là, vide un cane, che si trovava anche lui nel parco
per passeggiare in compagnia del suo padrone e lo apostrofò così: “Ehi,
ciao! Senti, ma tu vieni qui per quel motivo là?”.
Il cane rispose prontamente: “Ah no, no di certo! Io sono qua solo
perché il mio padrone mi porta a passeggiare. Inoltre lui ci tiene a
far sapere a chi lo incontra nel parco che neanche lui, come me, è qui
per quel motivo - e indicando il suo padrone aggiunse - Per capire che
quel che dico è vero, basta osservarlo quando mostra alle altre persone
che gli passeggiano accanto che lui ha un guinzaglio in mano, che è lì
con il cane… E se io mi allontano troppo, lui subito mi chiama a voce
alta: ‘Pippo, Pippo, dove sei?’, se no risulterebbe difficile agli
altri capire che noi due siamo insieme al parco…”. Il gattino senza
mostrarsi troppo sorpreso osservò: “Si preoccupa che qualcuno possa
fraintendere e pensare che siete lì perché siete pazzi?”. E il cane:
“Già...”.
LO STIGMA
U
n paziente un giorno si chiese come mai se una persona ha una malattia
mentale si vergogna e cerca di nasconderla. Chi ha un cancro, per
esempio - pensò - non si nasconde, e se non è una persona riservata
parla volentieri della sua malattia. Essendo ascoltato e capito, il suo
disagio si ridimensiona. Inoltre un malato di cancro non si vergogna di
recarsi in ospedale per le cure, mentre una persona che ha problemi
psichici, si vergogna di andare in CSM.
IL DEPÔT
Un giorno uno psichiatra affermò che i
farmaci depôt avrebbero risolto molti problemi riguardo alla
somministrazione farmacologica, in quanto agendo secondo un rilascio
graduale nell’organismo possono essere somministrati ad esempio una
sola volta al mese e hanno la stessa funzione dei farmaci che debbono
essere somministrati anche sei, sette volte al giorno. “I depôt -
spiegò - risolvono sia il problema dei pazienti che si dimenticano di
assumere le medicine durante il giorno, sia quello di coloro che si
vergognano di far sapere agli amici che assumono farmaci antipsicotici.
Un paziente che deve assumere farmaci tre, quatto, o cinque volte al
giorno, se esce con gli amici e resta parecchie ore in compagnia, a un
certo momento avrà la necessità di assumerli e, se si vergogna, magari
dovrà farlo di nascosto, in bagno. I depôt invece si prendono una sola
volta mensilmente e uno può farlo anche tranquillamente a casa sua,
quando è da solo…”. Un operatore che aveva ascoltato attentamente il
discorso dello psichiatra, quando questi ebbe concluso obiettò che in
realtà il vero passo in avanti, per la società come per la salute
mentale, sarà quando un cittadino verrà messo in condizione di non
vergognarsi di alcuna diversità di fronte ai suoi amici, e potrà vivere
senza cercar di apparire quello che non è o far finta di non essere
malato…
COSE DELL’ ALTRO MONDO
I
 n un pianeta molto distante dalla terra, c’era una donna che si vergognava della sua mamma, perché questa era matta.
n un pianeta molto distante dalla terra, c’era una donna che si vergognava della sua mamma, perché questa era matta.
Quando
uscivano insieme per fare delle commissioni o recarsi alle visite
mediche, la figlia diceva alla mamma di non starle vicina, ma di
camminare qualche metro più avanti, perché così le persone in strada
non avrebbero capito che erano insieme e che lei era sua figlia. La
mamma con tanto dispiacere a queste richieste di sua figlia rispondeva
che per lei andava bene. Così si incamminavano ogni giorno per la
città. La mamma con un grande borsone a tracolla e vestita abbastanza
stravagante, parlando da sola si dispiaceva.
Il pianeta in cui vivevano aveva avuto una forte influenza da parte del
pianeta delle anime felici, i servizi perciò si attivarono e, anziché
preoccuparsi di riabilitare la mamma, presero in carico la figlia,
facendole superare il senso di vergogna che, stranamente, le era
rimasto. I clinici non capivano perché, in quanto questa educazione
veniva praticata fin dai primi anni dell’asilo.
L’INIBIZIONE
N
 on
è la malattia mentale che paralizza l’energia del corpo e della mente,
è la vergogna la responsabile di tale impoverimento. La malattia
mentale diventa paralizzante a causa dello stigma che colpisce la
persona che soffre. Lo stigma, in una lotta feroce ma silenziosa,
abbatte l’azione, la quale morendo distrugge la strada che accompagna
alla guarigione. on
è la malattia mentale che paralizza l’energia del corpo e della mente,
è la vergogna la responsabile di tale impoverimento. La malattia
mentale diventa paralizzante a causa dello stigma che colpisce la
persona che soffre. Lo stigma, in una lotta feroce ma silenziosa,
abbatte l’azione, la quale morendo distrugge la strada che accompagna
alla guarigione.
La vergogna ha una funzione positiva, in quanto consente di rispettare
condivise norme sociali, ma se inibisce eccessivamente ostacola lo
sviluppo di relazioni sane, che si nutrono di spontaneità. Se ti
deridono mentre cammini, oppure quando piangi, quando parli in pubblico
o quando parli da solo, pensa che non dovresti essere tu a provare
vergogna, ma chi fa del male sbeffeggiando.
|
|
|
ACQUA E LIMONE
 Laboratorio di Arteterapia - C.R.E.I. Casa San Giacomo Coop. Soc. Nazareno
Laboratorio di Arteterapia - C.R.E.I. Casa San Giacomo Coop. Soc. Nazareno
U
n educatore che si appresta a lavorare con le emozioni insieme ai
ragazzi della comunità è facile che si ponga diverse domande come: qual
è l’obbiettivo di un ragazzo che inizia ad esplorare le proprie
emozioni? Quanto diverge la prospettiva emotiva dei ragazzi rispetto a
quella dell’adulto che prova a sintonizzarsi con il suo sentire? Come
si modulerà il costrutto di un’emozione che si sperimenta
nell’isolamento?
Sorgono parecchi dubbi rispetto a questo argomento e, anche se superano
le nostre risposte, in quest’articolo proveremo ad inquadrare
l’emozione ‘vergogna’ attraverso diverse lenti. Non ci sono verità
assolute ma relative, è bene tenerlo a mente se vogliamo facilitare il
viaggio all’interno del mondo soggettivo dei ragazzi che sperimentano
la vita e costruiscono le proprie teorie per spiegarla.
È indubbio che le emozioni sono una grande fonte di informazioni che
permette di modulare l’organizzazione esterna ed interna del soggetto
che le sperimenta. Iniziare un discorso centrato sulla vergogna può
essere difficile per un addetto ai lavori, figuriamoci per un
adolescente, soprattutto se consideriamo che ‘vergogna’ è una parola
avulsa dal suo significato teorico, è astratta, non esiste se non
provata da esseri umani. Ognuno di loro la esperisce a suo modo, a
seconda dei costrutti personali interiorizzati nel corso la vita, che
si raffrontano con diversi livelli di tipo sociale, familiare,
affettivo e contribuiscono alla costruzione di regole affinché si possa
abitare il mondo oltre che lo spazio intimo. Detto questo, in parole
semplici potremmo definirla come quell’emozione che può assalirci
quando, in un determinato contesto, ci rendiamo conto che abbiamo agito
o parlato in modo non consono, questa caratteristica prettamente
sociale si commisura con i modelli etici interiorizzati di ognuno di
noi. La vergogna può acquisire differenti sfumature da soggetto a
soggetto e quindi assumere diverse accezioni: imbarazzo, pudore,
rossore, disagio e tante altre. In particolare, è un’emozione di cui
spesso si sente parlare in relazione al senso di colpa, tanto che c’è
chi li considera la medesima cosa. Detto questo, sembrerebbe che nelle
varie culture del mondo le due cose siano vissute differentemente.
Generalizzando: mentre a occidente pare prevalga il senso di colpa a
oriente vivono un maggior senso di vergogna.
All’interno del laboratorio di narrativa abbiamo introdotto l’argomento raccontando una storia:
 Un giorno la regina di un paese d’occidente invitò il re di una
popolazione africana molto lontana per banchettare insieme a tutte le
più grandi cariche mondiali in onore della giornata della pace. Durante
l’evento viene servita una pietanza che si mangia con le mani, una
volta consumata, i domestici misero di fronte i commensali una
ciotolina contenente acqua e limone per potersi sciacquare le mani. Il
re africano non avvezzo a questi usi, bevve il contenuto della coppa
ritrovandosi addosso gli occhi di tutti i presenti. A quel punto la
regina, con sguardo d’intesa, prese fra le mani la ciotolina e si gustò
l’acqua e limone, tutti gli invitati fecero il medesimo gesto.
Un giorno la regina di un paese d’occidente invitò il re di una
popolazione africana molto lontana per banchettare insieme a tutte le
più grandi cariche mondiali in onore della giornata della pace. Durante
l’evento viene servita una pietanza che si mangia con le mani, una
volta consumata, i domestici misero di fronte i commensali una
ciotolina contenente acqua e limone per potersi sciacquare le mani. Il
re africano non avvezzo a questi usi, bevve il contenuto della coppa
ritrovandosi addosso gli occhi di tutti i presenti. A quel punto la
regina, con sguardo d’intesa, prese fra le mani la ciotolina e si gustò
l’acqua e limone, tutti gli invitati fecero il medesimo gesto.
Dopodiché abbiamo chiesto ai ragazzi che tipo di emozione ha provato il
re africano nel momento in cui aveva gli occhi di tutti addosso. Non
c’è stato molto da attendere, la maggioranza ha detto imbarazzo.
Abbiamo chiesto di condividere un episodio in cui hanno sperimentato la
vergogna e come l’hanno gestita pensando alla regina del racconto. Una
volta terminato il lavoro è stato chiesto ai ragazzi come si sono
trovati nel descrivere le loro esperienze. Il riscontro è stato
positivo, anche se avere a che fare con questo tipo di emozione non è
facile, poiché può inibire una performance sociale e affettiva, può far
arrabbiare e probabilmente può diventare senso di colpa.
La vergogna deriva dal latino verecondia, da vereri, che significa
riverire, avere rispetto. È interessante notare come la costruzione
sociale successiva ha fatto assumere un’accezione più severa e rigida
di quella che aveva in origine. Infatti, di norma, questo sentimento è
considerato la ‘cenerentola’ di tutte le emozioni, nel senso che è
relegato a pulire i pavimenti, a fare il lavoro sporco. Potremmo
rileggere questo sentimento partendo dalle sue fondamenta etimologiche
e facendo nostro il suo significato primario: avere rispetto di noi
stessi che si traduce nel costruire delle regole, basi della nostra
società che a loro volta formano e alimentano il rispetto dell’altro e
della società nella quale viviamo.
Alessandro Falcone
Di seguito gli elaborati dei ragazzi che hanno partecipato:
A. - “Quando ero in terza media a San Marino c’è stato il torneo
di pallavolo delle medie. Ogni partecipante aveva una maglia del colore
assegnato alla propria classe che bisognava portare a scuola ad ogni
partita. Ogni volta che giocavamo tutte le altre classi ci guardavano.
Una volta mi sono dimenticato di portare la felpa perché non mi
ricordavo ci fosse la partita, così ho dovuto giocare con i jeans, ero
l’unico vestito in quel modo. Mi sono sentito in imbarazzo, ma una
volta terminata la partita, tornato in classe, ero io l’unico a essere
normale”.
M. - “Quando avevo circa sette anni, una mattina a scuola ho
tirato una forbice a un altro alunno che per poco non è andato in
ospedale. È intervenuta la maestra e per fortuna nessuno si è fatto
male. Quando sono tornato a casa, la mamma fortunatamente non mi ha
fatto niente, mi ha semplicemente detto di andare a letto senza cena.
Per me quella giornata è stata la lezione in cui mi sono sentito più in
imbarazzo davanti ai miei compagni e ai miei amici. Il giorno dopo non
volevo più andare a scuola”.
C. - “In vacanza con i miei, siamo andati in piscina. Prima di
entrare c’era una piccola vasca per pulirsi i piedi, il pavimento era
talmente scivoloso che sono caduto per terra a sedere. Mi sono sentito
in imbarazzo e indifeso perché c’era una ragazza che mi piaceva che mi
guardava ridendo. Così, in un primo momento, sono arrossito molto, ma
poi mi sono accorto che non stava ridendo di me, ma con me. Ho
cominciato a ridere anch’io e l’imbarazzo è andato via”.
R. - “Ero in classe con i miei compagni e una ragazza che mi
piaceva da un po’ di tempo. Volevo rivelarle i miei sentimenti ma avevo
paura che non ricambiasse. Un giorno però mi sono fatto avanti durante
l’intervallo, lei conversava con delle amiche. Le ho chiesto se
potevamo parlare in disparte e le ho detto ciò che provavo per lei. In
quel momento ho provato tanto imbarazzo e vergogna, ero diventato
rosso. Fortunatamente mi ha rivelato di ricambiare i miei sentimenti e
dopo pochi giorni ci siamo fidanzati”.
L. - “Stavo parlando con una ragazza che frequenta la mia
scuola e che mi piace molto, discutevamo di quanto fosse difficile
prendere la patente, quale fosse la nostra macchina preferita e quali
razze canine ci piacciono di più. Mentre parlavamo ero teso, agitato,
non mi sentivo alla sua altezza ed ero diventato tutto rosso in viso.
Mi sono bloccato, non riuscivo a parlare ma è intervenuta una sua amica
che mi ha aiutato a sbloccarmi. Una volta che si è rotto il ghiaccio
sono stato più a mio agio”.
|
|
|
LA VERGOGNA
 LABORATORIO DI NARRATIVA - RTP Casa Mantovani
LABORATORIO DI NARRATIVA - RTP Casa Mantovani
 Testimonianza
Testimonianza
Il mio percorso a “Casa Mantovani” è stato
faticoso e travagliato, ma pieno di ostacoli; posso dire che ero una
ribelle, non ascoltavo nessuno... Col tempo ho deciso di cambiare, di
voler essere una persona migliore. Grazie all’aiuto di operatori e non,
sono riuscita a lavorare su me stessa e a diventare la persona che
sono. Come ho accennato sono stata ospite a “Casa Mantovani” prima di
intraprendere il percorso del teatro. Questo lavoro è stato e continua
a essere un’emozione unica, ci vuole pazienza, passione ed energia, non
credo di avervi spaventato nel dire ciò.
Il mio suggerimento per riuscire a ottenere qualcosa è quello di
lottare con tutte le proprie forze, se l’inizio sarà un po’ faticoso
non spaventatevi, la vita, si sa, è una lotta continua da quando si
nasce... Faccio parte della compagnia del teatro “Testoni Ragazzi” e
sono un’attrice a tutti gli effetti, questo è sempre stato il mio sogno
nel cassetto, me la porto dietro sin da quando ero bambina. Grazie al
teatro sono riuscita a ridurre notevolmente la timidezza che mi ha
sempre accompagnato, perché a dirla tutta, non è facile stare sul
palcoscenico davanti a un pubblico di adulti e bambini. L’emozione è
fortissima e l’adrenalina non è da meno, a volte sembra di perdere la
cognizione del tempo, il momento più critico per un attore riguarda i
cinque minuti prima dello spettacolo, perché hai la sensazione di non
ricordare più nulla.
La fine dello spettacolo, gli applausi, però, ti ripagano di tutto.
Sono felice di fare parte di questo gruppo teatrale perché siamo tutti
molto affiatati, ci aiutiamo e stiamo insieme nei momenti di gioia, ma
soprattutto nei momenti tristi e stressanti.
Anja C.
La vergogna è una condizione che vivo spesso, perché mi sento molto ignorante e con poche qualità ed esperienza di vita.
Irene C.
 Non mi faccio vedere
Non mi faccio vedere
Non mi faccio vedere
Ho troppa vergogna
Bevo bel vedere
Alla faccia di chi sogna
Bologna fa schifo
Mi sembra una fogna
Per quello che dico
Finirò alla gogna
Mi vergogno di quello che penso
Provo a leggere ma non ha senso
È da tempo che mi sento perso
Do un bacio all’universo
L’odio scritto in ogni verso
La strada qua è lunga
Serve una prolunga
Stacco la spina
Poi la riattacco
Do vita a un altro
Nuoto nell’alcol
Muoio pensando
Non serve tanto
Mi vergogno di quello che penso
Provo a leggere ma non ha senso
È da tempo che mi sento perso
Do un bacio all’universo
L’odio scritto in ogni verso
Mi vergogno di me stesso, ma ci sto lavorando!
Davide P.
 La vergogna è un’emozione che, al pari di tutte le altre, non va
giudicata in termini di positività o negatività. Va solamente
riconosciuta e, nel caso in cui la sua intensità si riveli molto forte
e quindi causa di blocchi nell’agire, analizzata. A un’intensità media
e bassa credo possa segnalare normali intenti di riservatezza su temi
personali e intimi. Se l’intensità invece si presenta più alta, di
difficile gestione e invalidante, va affrontata e combattuta. Credo che
il modo migliore per farlo sia quello di attuare azioni opposte a
quelle che sarebbero dettate istintivamente dall’emozione stessa. Con
un po’ di allenamento l’intensità di questa emozione dovrebbe quindi
attenuarsi e col tempo non risultare più invalidante.
La vergogna è un’emozione che, al pari di tutte le altre, non va
giudicata in termini di positività o negatività. Va solamente
riconosciuta e, nel caso in cui la sua intensità si riveli molto forte
e quindi causa di blocchi nell’agire, analizzata. A un’intensità media
e bassa credo possa segnalare normali intenti di riservatezza su temi
personali e intimi. Se l’intensità invece si presenta più alta, di
difficile gestione e invalidante, va affrontata e combattuta. Credo che
il modo migliore per farlo sia quello di attuare azioni opposte a
quelle che sarebbero dettate istintivamente dall’emozione stessa. Con
un po’ di allenamento l’intensità di questa emozione dovrebbe quindi
attenuarsi e col tempo non risultare più invalidante.
Clemente P.
|
|
|
IL VOLO DEL BRUTTO ANATROCCOLO
 Gruppo di scrittura DiSegno InSegno – Budrio
Gruppo di scrittura DiSegno InSegno – Budrio
 Il brutto anatroccolo volò
Il brutto anatroccolo volò
E non si sentì più solo
Avendo trovato in sé stesso un ruolo
La vergogna non lo accompagnò.
Le piume grigie ora erano bianche
Lo ricoprivano fino alle anche,
Le ali battevano mai stanche.
Come Icaro si lanciò verso il sole
Era il più maestoso di tutti
Mai più vergogna!...Solo frutti
I migliori che si possono sognare
Volando sul mare.
I piccoli anatroccoli
Lo guardarono sgomenti
Librarsi su ali potenti...
Sognarono anche per sé stessi
Cieli diversi, mari aperti.
Agostino, Massimo, Giovanni, Simone, Laura, Maria Elena, Betta e Danila
|
|
|
SENTIRSI... NON ‘A POSTO’
 Gruppo del Laboratorio ESPRESSAMENTE
Gruppo del Laboratorio ESPRESSAMENTE
(progetto PRISMA “Benessere psicofisico e autonomia”)
condotto dalla dott. Elena Pasquali, psicologa e psicoterapeuta
Definizione:
La vergogna è un’emozione complessa che riguarda l’autoconsapevolezza,
poiché legata alla percezione che si ha di sé stessi. Ci si vergogna
per qualche cosa che si è commesso, che si è fatto o detto, per quello
che si è, si pensa e si sente. È però possibile anche vergognarsi anche
per qualcosa che si vede fare o dire da altri con cui ci si identifica,
e che si sente particolarmente sconveniente e inopportuno. La vergogna
si presenta in conseguenza a uno smascheramento, alla sensazione di
essere stati scoperti, di essere messi a nudo, per cui si vorrebbe
sparire, diventare invisibili, sprofondare. Si può reagire alla
vergogna in diversi modi, generalmente arrabbiandosi o isolandosi.
Si distinguono diversi tipi di vergogna riguardanti situazioni più o
meno invasive e dolorose, che si riferiscono allo svelamento,
all’essere lodato, a qualcosa che riguarda gli altri e la propria
appartenenza, eccetera.
Lavoro di gruppo:
Il gruppo ha raccontato diverse esperienze personali di vergogna che
riguardavano principalmente un senso di inadeguatezza di fronte agli
altri che portava al desiderio di sparire, di nascondersi. “Sentirsi
non a posto… e allora mi vergogno di me!”.
Questo vissuto ha portato a una comune riflessione a partire dalla lettura della favola di Hans Christian Andersen:
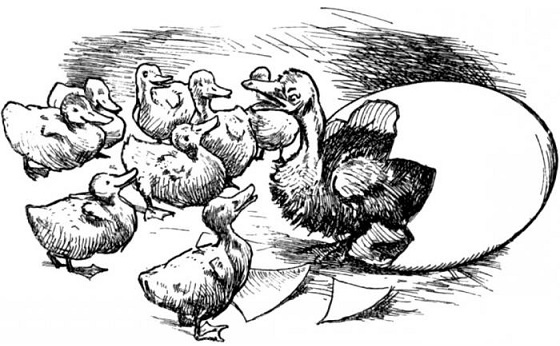 Il brutto anatroccolo
Il brutto anatroccolo
C’era una volta un’anatra che stava aspettando la schiusa delle sue
uova, poste nel nido fatto sulla riva di un laghetto all’interno del
campo di una fattoria. Poco a poco le uova si schiusero tutte, e ne
uscirono dei bellissimi pulcini tutti dorati. Però mancava ancora un
uovo, quello più grande di tutti, che tardava a schiudersi. Finalmente
l’uovo si aprì e… Che sorpresa! Mamma anatra e i suoi fratellini videro
uscire da quell’uovo più grande del normale uno strano anatroccolo,
tutto grigio e goffo! I suoi fratellini lo ribattezzarono subito
“Brutto Anatroccolo” e non mancavano mai di prenderlo in giro e fargli
gli scherzi. “Come sei brutto! Noi con te non vogliamo giocare! Brutto,
brutto! Sei brutto!”... Mamma anatra cercava di difenderlo come poteva,
e quando era triste il Brutto Anatroccolo correva da lei a farsi
stringere e coccolare. Ma purtroppo anche le altre anatre che abitavano
il laghetto lo deridevano e lo prendevano in giro, tanto che il
poverino tornava sempre a casa con i lacrimoni agli occhi.
Un giorno il Brutto Anatroccolo decise che ne aveva abbastanza di tutte
quelle stupide anatre che lo trattavano male. “Andrò dove troverò delle
anatre che mi sapranno apprezzare per quello che sono”, si disse, e
spiccò un volo incerto con le sue piccole alette. Non riuscì ad andare
molto lontano, e per la stanchezza si fermò in uno stagno lì vicino,
dove vide arrivare uno stormo di anatre selvatiche. “Forse loro mi
accetteranno meglio di come mi hanno accettato le anatre della
fattoria”, pensò. Il Brutto Anatroccolo si avvicinò piano piano allo
stormo che stava riposando sulle acque dello stagno, e quando fu
abbastanza vicino si presentò facendo la riverenza. “Salve a tutte
signore anatre selvatiche io sono…”, ma non fece in tempo a finire la
frase che già le anatre selvatiche lo stavano additando e deridendo. “E
cosa saresti tu? Un anatroccolo mostriciattolo?” e continuarono a
ridere. Il povero anatroccolo, deluso, amareggiato e pieno di lacrime,
scappò via anche da lì, finché stremato dal volo non si fermò sulle
rive di un altro stagno non molto lontano. Lì vide degli splendidi e
candidi cigni che nuotavano con grazia ed eleganza sullo specchio
d’acqua. Erano così belli che il Brutto Anatroccolo ne rimase
incantato. Più li guardava e più pensava: “Quanto vorrei essere bello
come loro…”. Così, senza nemmeno accorgersene, aveva nuotato verso di
loro, fino ad arrivare praticamente in mezzo al gruppo. “Forse mi
beccheranno e mi cacceranno anche loro - pensò l’anatroccolo - ma
preferisco che siano a farlo loro, che sono bellissimi davvero,
piuttosto che quelle stupide anatre vanitose…”. Ma invece che deriderlo
e cacciarlo, i cigni gli corsero tutti incontro, salutandolo e
abbracciandolo. Il Brutto Anatroccolo non capiva, e chiese: “Come mai
non mi deridete e non mi prendete in giro per quanto sono brutto?”. Una
di loro gli rispose; “Brutto tu?! Ma se stai per diventare uno
splendido cigno!” ... “Cigno io?!”, rispose sbalordito il Brutto
Anatroccolo. Tutti i cigni si misero a far di sì con la testa e gli
sorrisero con calore. “Aspetta qualche giorno e vedrai…”.
E fu così che dopo pochi giorni il Brutto Anatroccolo si svegliò e,
andatosi a specchiare nello stagno, vide che tutte le sue piume
grigiastre erano diventate bianche come il latte, e la sua goffaggine
si era trasformata in un portamento elegante ed aggraziato: era
diventato un cigno! E quanto era bello, il più bello di tutto lo
stagno! “Quando ero ancora un Brutto Anatroccolo, non avrei mai
immaginato che un giorno sarei stato così felice!”. E spiccò il volo
insieme a tutti i suoi nuovi amici.
Morale della favola: solo credendo sempre in sé stessi e nelle proprie
capacità alla fine si riesce a diventare grandi, accettandosi per
quello che si è.
Lavoro di gruppo:
Il lavoro di gruppo ha riguardato la lettura e messa in scena della
favola nella sua prima e più drammatica parte, quella che riguarda la
schiusa delle uova e l’esclusione del brutto anatroccolo da parte dei
fratelli e di altre anatre dello stagno. Ogni membro del gruppo veniva
invitato a interpretare il ruolo del brutto anatroccolo e a creare un
finale per la storia mettendolo in scena.
I finali per la storia del Brutto Anatroccolo:
A. - Rifiutato da tutti, rimango da solo e sconsolato vado a mangiare alghe nello stagno.
B. - “Venite qui fratellini, non vedete che sono anche io della
famiglia?! Qualcuno deve pure difendermi e sostenermi. Mamma vieni
anche tu che ne parliamo". Tutte le anatre allora fecero una riunione
familiare e trovarono un accordo insieme per vivere felici e contente.
F. - Mi faccio dare da mangiare da un bambino e aspetto da solo che ogni tanto ritorni.
S. - Mi faccio portare nello stagno da mamma anatra e lì rimango da solo.
M.C. - Cerco qualcuno finché non trovo un cagnolino e gioco con lui.
|
|
|

Solidarność
 Moira Orfei (scritto postumo)
Moira Orfei (scritto postumo)

 meglio la fine della solidarietà, o la finta solidarietà? Chi per ruolo
aiuta, accetta di essere aiutato? E chi in genere è aiutato, poi riesce
ad aiutare? Prove quotidiane per diventare Esp…
meglio la fine della solidarietà, o la finta solidarietà? Chi per ruolo
aiuta, accetta di essere aiutato? E chi in genere è aiutato, poi riesce
ad aiutare? Prove quotidiane per diventare Esp…
Ieri sono stata da un dentista, beninteso di quelli della ASL. In sala
d’aspetto ho cominciato a parlare con una signora che aveva accanto la
figlia, una donna disabile.
La figlia esce presto dall’ambulatorio e le chiedo se posso darle una
mano a mettere il cappotto. “Eh, sì, sono un disastro”, mi dice. Io le
infilo un braccio, poi l’altro. Poi cerco con difficoltà di chiuderle
la cerniera e le dico: “Non dire che sei un disastro, non è così. Lo
dico sempre anch’io, ma non è vero”. Esce l’assistente alla poltrona
del dentista e urla a gran voce: “Lo dico sempre anch’io che sono un
disastro!”. Io guardo la donna disabile e con un immenso sorriso le
dico: “Tranquilla, siamo nella stessa barca, sono disabile anch’io”.
Lei: “Non si direbbe”, e non smette più di ringraziarmi per quel
piccolo gesto.
Dopo il dentista, mi catapulto alla mensa parrocchiale. Un marocchino
ubriaco inveisce contro un altro. La situazione degenera, si vogliono
spaccare le caraffe di vetro in testa, è il caos. La polizia è stata
chiamata ma non arriva. Una volontaria anziana è scaraventata a terra,
un’altra volontaria, minuta minuta, urla con tutto il fiato che ha:
“Bastaaaaaaaaaaaa, bastaaaaaaaa, bastaaaaaa!”, ma a un certo punto
crolla, si accascia in ginocchio. A nessuno sembra importare
nient’altro che di portare a casa la propria pellaccia, che sia bianca,
nera o gialla. Mi precipito a prendere una sedia, sollevo l’eroica
volontaria impaurita per la sua ernia del disco e la metto a sedere.
Vado a cercare un bicchiere d’acqua e lo porgo alla signora, che
continua incredula a ringraziarmi. Mentre io tra me e me penso: “Ma
possibile che a nessuno sia venuto in mente un gesto così semplice? Una
sedia e un bicchiere d’acqua… Cosa ho mai fatto di speciale?”…
Oppure era l’inversione dei ruoli a rendere la cosa talmente
inaspettata: un’utente che sostiene una volontaria! Ma utente e
volontaria non appartengono entrambe al genere umano? Poi il ragazzo
marocchino aggredito. Non lo conosco bene, in realtà guardo sempre il
suo amico, perché è molto carino e loro ridacchiano di me... Avevo un
po’ paura che in questo caso una gentilezza potesse essere fraintesa.
Alla fine mi sono decisa. Sono andata alla ricerca di un altro
bicchiere d’acqua; lo ha rifiutato, ma io l’ho appoggiato accanto a
lui. Poi, prima di andarmene, mi avvicino e gli chiedo: “Come stai,
tutto bene?”. Avverto che la mia attenzione gli fa piacere: “Tutto
bene, risponde”. E io: “Sei proprio sicuro?”. Lui mi sorride: “Sicuro,
sicuro”. Tutti a urlare: “Ma vai al pronto soccorso”, “Denuncialo
quello stronzo”, “Magari così ti becchi un sacco di soldi”... Mentre
io, tra me e me, penso: “Possibile che a nessuno sia venuto in mente di
chiedergli semplicemente come sta?”. Mi sono sentita molto bene, con
quella pienezza d’animo che sento poche volte.
La sera in autobus. L’autista investe un ragazzino sulle strisce.
Niente di grave, ma due cose particolari. L’autista, terrorizzato di
perdere il posto per l’incidente, solo molto molto dopo aver
bestemmiato va a parlare con il ragazzino per capire come sta. Il
tredicenne insanguinato, da parte sua, non è preoccupato di essersi
fatto male, ma urla terrorizzato: “Vi prego, non chiamate mio padre,
lui farebbe un casino, la prenderebbe malissimo e sono sicuro che mi
picchierebbe”.
|
|
|
LA VERGOGNA NON MI APPARTIENE
 Paula Mencarelli
Paula Mencarelli
 La vergogna come sensazione non mi è
mai appartenuta in questi vent’anni di disagio. Non mi sono mai
vergognata né delle mie scelte di vita né del mio disturbo. Spesso mi
sono vergognata per empatia, in luogo di persone poco sensibili e
professionisti troppo frettolosi o addirittura indifferenti a noi
utenti. Quello che mi viene da dire è che ho incontrato tra i miei
‘amici’ utenti più pudore che vergogna. E tanta dignità, a volte
ironia, condividendo i nostri drammi, ma mai vergogna. Se ci penso
sinceramente, piuttosto, mi viene in mente che le persone che mi vivono
accanto spesso hanno vergogna di avere una madre come me o una nuora
come me... Io li perdono, ma non li giustifico e la loro pochezza si
riflette sullo stigma che mi appartiene, nella mia dolce follia...
Posso comprenderlo, ma non giustificarlo. Quando la dignità di ogni
creatura vivente sarà ritrovata, forse la nostra follia sarà compresa e
la vergogna annullata. E quando penso alla ‘follia’, penso alle poesie
di Alda Merini, alla vita trasformata in poesia, alle immagini di Van
Gogh, la sua passione su tela, alle bellissime risate con il mio caro
amico Fabrizio, che spero presto di riabbracciare, a Giorgia che con la
sua empatia riesce a farmi sentire normale...
La vergogna come sensazione non mi è
mai appartenuta in questi vent’anni di disagio. Non mi sono mai
vergognata né delle mie scelte di vita né del mio disturbo. Spesso mi
sono vergognata per empatia, in luogo di persone poco sensibili e
professionisti troppo frettolosi o addirittura indifferenti a noi
utenti. Quello che mi viene da dire è che ho incontrato tra i miei
‘amici’ utenti più pudore che vergogna. E tanta dignità, a volte
ironia, condividendo i nostri drammi, ma mai vergogna. Se ci penso
sinceramente, piuttosto, mi viene in mente che le persone che mi vivono
accanto spesso hanno vergogna di avere una madre come me o una nuora
come me... Io li perdono, ma non li giustifico e la loro pochezza si
riflette sullo stigma che mi appartiene, nella mia dolce follia...
Posso comprenderlo, ma non giustificarlo. Quando la dignità di ogni
creatura vivente sarà ritrovata, forse la nostra follia sarà compresa e
la vergogna annullata. E quando penso alla ‘follia’, penso alle poesie
di Alda Merini, alla vita trasformata in poesia, alle immagini di Van
Gogh, la sua passione su tela, alle bellissime risate con il mio caro
amico Fabrizio, che spero presto di riabbracciare, a Giorgia che con la
sua empatia riesce a farmi sentire normale...
Sto scrivendo da un letto di ospedale e pensavo proprio di non farcela
questa volta. Ringrazio mia sorella Alida, Tiziano e il dottor Gianluca
Piastra che non mi hanno mai abbandonato in questo lungo e spero ultimo
ricovero, e te, cara mia dolce infermiera, che prima che mi recassi in
quell’inferno che è l’Ottonello del Maggiore mi hai consolata e
preparata al più atroce dei giri dell’inferno danteschi… A te va tutta
la mia stima e il mio affetto. Tu ci sei sempre al momento giusto. Ti
voglio bene, Giorgia, tantissimo. E… Scusate la mia irruenza… Caro
direttore, ma lei ha mai fatto un giro in quell’inferno del Maggiore???
Di quel brutto posto, sì, mi vergognerei terribilmente, fossi in lei.
|
|
|
VERGOGNA MODELLO DI VITA
 Darietto
Darietto
D
opo che Adamo ed Eva sono stati scacciati dal Paradiso, la vergogna è
diventata un modello di vita, quasi addirittura un trofeo. Basta vedere
in politica quanti inetti, che nemmeno si vergognano di azioni fatte ai
danni del popolo italiano, portando il paese sull’orlo di una crisi. Ad
esempio, parlando del clima: un certo signore volle incrementare
l’energia nucleare quando ormai tanti paesi lo hanno già abbandonato a
favore di energie più pulite come l’eolica e i pannelli solari; sempre
quel signore creò Equitalia, strozzando l’esistenza di tante persone
che già erano in crisi e, grazie a quella trovata, molti decisero di
togliersi la vita... Quindi è come se fosse stato lui ad ucciderli! Non
se ne vergogna? Han fatto benissimo a levarlo e non capisco come certa
gente, che si dovrebbe vergognare, continua a votarlo! Forse gli piace
sto schifo di vita: sono ‘sadomaso’.
 Comunque, ricordo anche che quando, all’età circa di vent’anni, ero
alla ricerca di un lavoro, le agenzie prendevano in giro noi giovani,
indicando che per fare dell’apprendistato, bisognava avere già
dell’esperienza: ma che contraddizione del cavolo era? Cioè se io
voglio apprendere un mestiere, come faccio già ad avere esperienza su
quel lavoro? Mi chiedevo quindi: “Ma non si vergognano a mettere degli
annunci di quel tipo?” e non ero l’unico a pensarlo, tanto che lo
chiesi ai miei amici e loro mi diedero ragione. A tutt’oggi comunque
l’apprendistato non c’è più, sostituito da pratiche comunque precarie
che portano un disagio peggiore e, per di più, spingono i giovani a
uscire dall’Italia. Mi ricordo di un ragazzo che qui in Italia non era
stato apprezzato, mentre in Australia è diventato un gran ricercatore.
Ora devi avere esperienza in un ambito specifico per entrare in un
luogo di lavoro, ma chi altri lo può insegnare se non il datore di
lavoro stesso? I genitori non ti insegnano un lavoro (una volta si
passava da padre in figlio il mestiere, ora non più) e la scuola non è
adeguata al passaggio al mondo del lavoro (si fanno degli stage che
comunque non vengono pagati ed è come se i giovani fossero degli
schiavi, cosa vergognosa!!!). Tutto ciò, ripeto: non è estremamente
vergognoso?
Comunque, ricordo anche che quando, all’età circa di vent’anni, ero
alla ricerca di un lavoro, le agenzie prendevano in giro noi giovani,
indicando che per fare dell’apprendistato, bisognava avere già
dell’esperienza: ma che contraddizione del cavolo era? Cioè se io
voglio apprendere un mestiere, come faccio già ad avere esperienza su
quel lavoro? Mi chiedevo quindi: “Ma non si vergognano a mettere degli
annunci di quel tipo?” e non ero l’unico a pensarlo, tanto che lo
chiesi ai miei amici e loro mi diedero ragione. A tutt’oggi comunque
l’apprendistato non c’è più, sostituito da pratiche comunque precarie
che portano un disagio peggiore e, per di più, spingono i giovani a
uscire dall’Italia. Mi ricordo di un ragazzo che qui in Italia non era
stato apprezzato, mentre in Australia è diventato un gran ricercatore.
Ora devi avere esperienza in un ambito specifico per entrare in un
luogo di lavoro, ma chi altri lo può insegnare se non il datore di
lavoro stesso? I genitori non ti insegnano un lavoro (una volta si
passava da padre in figlio il mestiere, ora non più) e la scuola non è
adeguata al passaggio al mondo del lavoro (si fanno degli stage che
comunque non vengono pagati ed è come se i giovani fossero degli
schiavi, cosa vergognosa!!!). Tutto ciò, ripeto: non è estremamente
vergognoso?
Personalmente, l’unica cosa di cui provo vergogna è di vivere in un
paese nel quale le persone non vengono premiate per il loro merito
(meritocrazia) e per la volontà di aiutare il prossimo, ma vengono
messe in difficoltà. Molti poi vengono ‘rinchiusi in gabbie’, cucendo
loro la bocca. Molti vengono allontanati dalla società, costretti a
vivere la vita quotidiana in grave stato di crisi, cose che poi
sboccano in depressione.
La loro attitudine e bravura in certi campi (c’è ad esempio chi è
portato per la grafica, chi per il sociale, chi per l’informatica e via
di seguito) finisce per essere buttata nella spazzatura, con
conseguente perdita di stima e fiducia in sé stessi, e la persona
finisce per chiudersi e sminuire la sua potenzialità. Questo anche
perché, il mondo cambia troppo velocemente a favore di robot che
portano via posti di lavoro. Il dio denaro non perdona chi è troppo
debole e non dà spazio a chi invece vorrebbe far sentire la propria
voce (quindi addio libertà di parola e di pensiero). Ad esempio:
pubblicare un libro, solo chi ha potere e soldi può farlo liberamente e
chi è debole... Ciao! Stessa cosa avviene nella legge (“La legge è
uguale per tutti” è indicato nell’insegna di un qualsiasi tribunale: ne
siamo sicuri?) in quanto chi ha soldi e potere, se la cava con un
nonnulla, ma chi è nella fascia debole ha trentamila grattacapi che
prima di poterne uscire, per il poverino passano degli anni: non è
vergognoso? Bravi! Applaudiamo al grande ingegno dell’essere umano,
bravo solo a fare gravi contraddizioni. Vergognatevi! Complimenti a
tutti!
|
|
|
|
|
|
|
OPERE DEGLI ARTISTI IRREGOLARI BOLOGNESI:
AUGUSTINE NOULA
Augustine
Noula è nata in Camerun (Yaoundé) nel 1981. Laureata in Comunicazione e
Marketing, è affascinata dalla miscela dei colori e da tutto quello che
tocca la realtà virtuale tridimensionale.
I dipinti riprodotti qua sotto sono dell’artista Augustine Noula






|
|
|